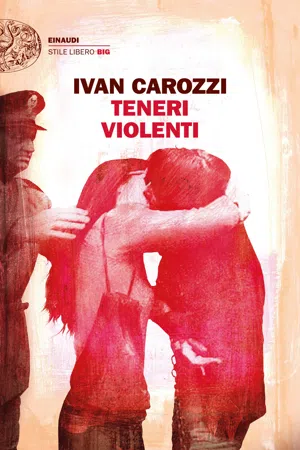![]()
Da un bar sulla spiaggia fino ai marmi della Stazione Centrale, in treno. Un tratto di piano ammezzato era invaso dall’afrore dolce e ricco di un McDonald’s. Sotto l’occhio di un leone scolpito, meravigliavano la cortesia, gli abiti, l’abbronzatura delicata di chi si metteva in fila per un taxi.
Tarda sera di fine agosto. In estate la città s’imperla come la fronte di un cuoco. Lo spazio tra cosa e cosa intorpidisce. Nella pedonale via Paolo Sarpi, chinatown milanese, qualche topo accaldato sbuca da sotto una panchina e corre fino a un cespuglio. Una volta posato a terra il trolley di nylon, ho riaperto persiane e finestre. Ancora un po’ di luce azzurra in cielo e sui vetri della Torre Unicredit. Dovevo riprendermi da tre ore e mezzo di regionale veloce, in parte senz’aria condizionata. Finalmente steso sopra la fresca vastità delle lenzuola, stretto e lungo come un’isoletta greca, nella notte ho sognato una donna. La donna parlava. Con mani e gambe ci cercavamo nel letto senza trovarci. Mi raccontava di suo padre e sua madre. Diceva che suo padre e sua madre avevano marciato in testa a un corteo. Poi la donna è scomparsa. Una luce a righe si è affacciata tra le stecche della persiana. Dopo le vacanze al mare, era la prima notte che passavo di nuovo a Milano.
![]()
Per intere settimane mi capita di restare chiuso in casa. Non d’inverno, ma d’estate. Passo il tempo sopra un divano a due posti. Non ho un lavoro. Non sono neppure iscritto a un corso di formazione. Non ricordo piú il giorno della mia laurea. Non ricordo le facce della commissione. Assaggio quel che trovo in frigo: un pezzo di cocomero che stacco con le dita, togliendo il cellophane sulla fetta; un semifreddo Carrefour strappato da una confezione.
Ogni anno firmo un contratto in scadenza a maggio, senza sapere se, prima o poi, succederà qualcosa nella vita, magari a settembre. Questo fatto mi genera ansia, parola sulla bocca di tutti, cosí popolare che al mercato l’ho vista stampata sulla maglietta di un fruttivendolo: «Brindiamo all’ansia». Per me è una febbre che rende permanentemente tesi, che come una polvere si scioglie nelle belle giornate e scende fin dentro lo smalto dei colori, quando in bicicletta, prendendo via Vincenzo Monti oltre la rotonda di piazza Virgilio, osservo il tunnel del fogliame ridondare il verde sfiorato in parco Sempione. Il disincanto è piú tenace del desiderio o della capacità di crederci e provare. Piú forte della volontà di trovarsi un lavoro. La precarietà si è fatta piega del vestito e fisiologia del carattere. Una forma di spleen. Un gusto fiacco per la recriminazione e un segreto amore per la sconfitta. I pomeriggi passati rimbalzando con le gomme sul pavé. All’Arco della Pace un incrocio di sguardi con l’occhio scuro di un’ex top model: sei tu, Nadège? Mi piace la fessura tra un cubetto e l’altro, il porfido grigio che sembra uno specchio. Non la periferia ma il centro, con le finestre timpanate e gli standard francesi di portici, giardini, piazzette, che fanno pensare al trotto di un ussaro a cavallo. Niente marce di pifferi e tamburi, semmai il vecchio rumore del traffico, levigato dal disegno dell’Area C.
L’atelier dell’hamburger, i boccoli delle ragazze fuori dai portoni col citofono in ottone lucidato. Camilla, Virginia, Costanza. Bibi e Bea. Gea, Gaia, Guia. Figlie di giornaliste, avvocate divorziste, di velisti in Liguria con una j o una w nel cognome. Rich kids Fumagalli e Brambilla. Le biciclette col cestino e il portapacchi di vimini parcheggiate sul cavalletto di fronte a un’edicola. Il «Corriere» arrotolato e un ciuffo verde di sedano rapa che spunta dalla busta di carta gialla. La precarietà è la delusione di una speranza concimata nel cuore di un altro secolo. La perdita di un benessere annunciato, ma all’improvviso fuggito. Che non può appartenermi. Come certi quartieri in cui posso appena pedalare.
Una sera d’inizio agosto, a una festa, Silvia mi raccontò di suo padre e sua madre. Erano ormai le tre di notte. Ogni tanto un venticello notturno si alzava, scorreva tra la pelle e i vestiti, poi tornava un caldo pazzesco. Sera africana, con le dune, il cammello e le stelle. Però a Milano. Si godeva del miraggio che dormire non fosse piú necessario. Lungo il tricipite aveva il tatuaggio di un ago e di un filo. Mi avvicinai. Silvia era seduta accanto a una palma nana, con un drink tra le mani. – Ciao, come stai? Posso sedermi qui con te? – E mi accomodai sul bordo spesso del vaso in terracotta. Per via dei riflessi cangianti del ghiaccio nei bicchieri, delle cannucce rosa, azzurre, degli ombrellini nei cocktail, delle montature da sole fluo dei due dee-jay, avevo a tratti provato l’illusione di trovarmi nei pressi di una piscina. Ma eravamo nel giardino di un locale che stava chiudendo. I bicchieri erano recuperati dai contenitori in vetro per marmellate. Sentivamo alle nostre spalle lo schiocco di una pallina da ping-pong contro la racchetta. C’era un tavolo, infatti, nascosto in un angolo e circondato da una l di cespuglietti di rosmarino. La non violenza del palleggio era il giusto contrappunto a decine di conversazioni troppo amabili. – Tu che cosa bevi? – mi chiese Silvia, scuotendo il ghiaccio mezzo sciolto nel bicchiere; e: – Se hai finito, prendi un po’ del mio –. Lei un mojito e io un moscow mule. La pulizia dei battiscopa e dei mattoncini a vista faceva pensare a una recente ristrutturazione del locale. Di giorno era per metà un coworking. Aveva l’aspetto di un’ex cascina, ma forse non lo era. – Mi lasci il cetriolo, se non lo mangi? – mi disse Silvia, spiando nel vetro del bicchiere le fettine bianche e sottili tra i cubetti di ghiaccio.
Il tatuaggio non era, come avevo sulle prime immaginato, una citazione della scultura di fronte alla stazione Cadorna. Claes Oldenburg e Coosje Van Bruggen avevano riprodotto fuori scala, e dipinto di giallo, verde e rosso, la sagoma di un ago e di un filo, in omaggio all’industria della moda. Opera commissionata dal comune e inaugurata nel 2000. Un ago in ferro di quasi venti metri piantato sulla piazza con un filo annodato intorno. Ombra sul viavai dei pendolari che, con la pochette nel taschino e una borsa computer, si portano tra le studentesse in marcia verso l’Università Cattolica. Quasi un ballo delle debuttanti, sotto le finestre di «Vanity Fair». – È un omaggio al mestiere, – diceva Silvia guardandosi il braccio, – faccio la stylist. – Mi sembri piú una specie di sarta… – Non proprio, – fece Silvia, – ma non mi dispiace vedermi come una sarta. Comunque non hai notato il ditale sotto l’ago e il filo –. «Ditale» era un termine che non sentivo da tempo. Il cappuccio di metallo che Silvia si era fatta disegnare, quasi non riuscivo a figurarlo nelle sue vere dimensioni. Però potevo ritrovare, nella memoria tattile, il ricordo dei piccoli rilievi sbalzati lungo il corpo troncoconico. – Mia mamma aveva un ditale chiuso in un cassetto da qualche parte, – dissi. Le chiesi se avesse qualche sarto in famiglia e mi disse che, in effetti, una sua prozia di Riccione cuciva. Era stata una sartina, lavorava in ciabatte nella cucina di casa. – La Donatella, detta Tella –. A Silvia piaceva anche lavorare a maglia. Aveva imparato grazie a un corso organizzato ogni lunedí sera in un knit café di via Tadino. Mi accennò ai torciglioni, alle coste sottili, al punto brioche, alla costa inglese, al punto traforato, alle torte salate che venivano servite durante le lezioni. Mi parlò poi del quartiere dov’era nata e cresciuta e ancora viveva. – Dove abiti? – le chiesi. – Porta Romana –. Fece una pausa e aspirò dalla cannuccia bicolore il mojito, mentre la menta a mucchietti si appiccicava alle pareti del bicchiere. Disse di Dario Fo e Franca Rame. Un tempo facevano colazione in un bar accanto a un fioraio sotto casa sua. Un negozio di fiori che era per metà officina e bottega di biciclette usate: PetaliPedali. Succhiò ancora un po’ dalla cannuccia. Vidi una coppia di fossette scavarsi in mezzo alle guance. Disse di com’era cambiata nel tempo quella zona: – Mi segui o fai finta? – Chiese se avessi mai sentito parlare dell’occupazione da parte di studenti e teatranti della Palazzina Liberty, nel 1974. – La cosa bella, – mi disse tornando al biciclettaio fiorista, – è la penombra di questo antro profumato –. Il miscuglio umido dei semenzai, delle piante grasse esotiche, dei kokedama volanti legati con lo spago e sospesi nel buio, accanto ai manubri rigenerati, ai reggisella e ai telai Bianchi ridipinti. Come se si fosse accesa una torcia a illuminare un varco, intuendo che per qualche ragione la mia psicologia fosse sensibile alla lusinga del tempo, del passato e della Storia, Silvia prese a dirmi con venerazione di suo padre e sua madre, della partecipazione appassionata, come studenti militanti rivoluzionari e come giovani di quella generazione, ai cortei del Sessantotto. – Mio padre ha fatto parte di una formazione marxista-leninista, che chiamavano in tanti modi, per esempio «Servire il popolo», una cosa durata qualche anno, fino alla metà degli anni Settanta, credo, io sono nata dopo. Era già tutto finito da un pezzo, ma conosco a memoria le foto di mio padre e mia madre in corteo –. Per Silvia il Sessantotto, questa cifra antonomastica, catturava un nucleo di energia. – Come il simbolo del sole. Non è facile da spiegare…
Intorno si sfoltivano comitati informali di cinque, sei persone, che per tutta la sera avevano discusso fitto vicino a noi. C’erano un paio di studenti della Naba, che si spartivano i resti di un pinzimonio in una tazza. – Sto progettando una scultura per un padiglione Expo, – diceva uno dei due, sotto il colpo secco di una pallina da ping-pong. – Un remake delle Marille, hai presente? I maccheroni, lisci fuori e lavorati dentro, che Giugiaro aveva disegnato per Voiello nell’83 –. A un certo punto parlarono del recupero dell’estetica anni Cinquanta, dei tatuaggi edwardian, delle nuove barberie in Ticinese e del bar ispirato ai diner americani aperto da poco in via Thaon di Revel. Contemporary fifties. Un fotografo approfittò per dire di uno spot cui aveva lavorato, quel pomeriggio, in uno studio di Milano sud, in via Malaga. Era riuscito, dopo qualche tentativo, ad ammorbidire la luce sul dorso di un raviolo. – A proposito, nel loft in via Malaga stiamo cercando di affittare una scrivania. Se a qualcuno interessa… – In fila alla cassa per un drink o di fronte alla porta del bagno, piú o meno lontani dalla vibrazione degli amplificatori, non si rinunciava ad alimentare il perpetuo arabesco delle interazioni. Una danza d’inganni e aderenze, dove cospiravano alcol e tecniche di autopromozione. Dappertutto camicie decorate con fantasie di ranocchie e coni gelato, un commercio di pubbliche relazioni e spume, effervescenze ormonali, che si cucivano in trame geometriche al trap rap o a un pezzo degli Andy Warhol Banana Technicolor. L’ansia del lavoro, o l’ansia della mancanza di un lavoro, apriva cosí tante porte, digressioni, collegamenti, da fare di ogni conversazione un labirinto fino all’ultima goccia del cocktail. – E tu di cosa ti occupi? – Ma a notte fonda il lavoro cedeva spazio al resto della vita. La vita, cosí, si riprendeva un po’ di ciò che le era stato tolto. Gli ultimi chupitos venivano versati in bicchierini alti un pollice, ancora caldi di lavastoviglie, mentre una vecchia macchina del fumo, sistemata in un angolo, spargeva un vapore bianco e inodore, come nelle discoteche all’epoca di Spagna.
Silvia indossava un paio di shorts a vita alta, tagliati cosí stretti e corti che le sparivano in mezzo alle chiappe, le gambe fuoriuscivano dall’orlo con uno scoppio di sensualità. Seduta sul vaso di terracotta, si passava spesso un dito tra la coscia e il ginocchio, a cercare una puntura di zanzara sul velluto abbronzato della carnagione. Portava un paio di sandali dalle fasce sottili e la suola fine. Il rosa scuro della pelle intorno all’evanescenza delle vene. Le lingue della palma nana con le striature gialle e nere incorniciavano come un boa l’immagine di lei che parlava, succhiava dalla cannuccia, e ogni volta chiudeva la frase con un risolino e un paio di fossette. Un po’ Monna Lisa e un po’ ragazza Disney Channel, nonostante avesse già trent’anni. – Quanti anni mi dài? – Un retrogusto ironico, e malizioso, dietro ogni giro di parole. Quando rideva, con i suoi denti piccoli e candidi, la guardavo con piú curiosità. Con desiderio. – Ce l’hai Twitter? – Sí, – le risposi. – Ti cerco io, – disse, e aggiunse: – Ce l’hai WhatsApp? Dammi il numero… – E cosí ho sentito il cellulare vibrarmi in tasca, tra gli spiccioli e il mazzo di chiavi.
In una nicchia in fondo al locale, sotto una volta a botte prospiciente una piccola pista, alcuni oscillavano, uomini e donne, allineati come asticelle di metronomi, ballando l’ultimo disco; una luce gialla e rosa nello spazio, immersa in una vasta nube fosforescente, dove ci si dondolava lenti. Quel modo di schioccare le dita nell’aria ridestava qualcosa, un fantasma: Michael Jackson? A occhi chiusi ciascuno guardava il tempo, la propria esistenza trascorsa, rivoltarsi come terra, mentre si ballava senza urti. E lí, in quella nicchia, vidi Silvia andarsene. Deglutita dal vapore e dall’elettronica per una porticina nera sotto la volta a botte. Prima di scomparire tirò fuori un piccolo oggetto dalla borsa. Era un braccialetto di corda intrecciata. Avrei voluto chiederle se avesse a che fare con il corso che aveva frequentato nel caffè di via Tadino, ma non aprii bocca. La musica era troppo alta e la domanda era inutile. Lasciai che mi prendesse il polso, ci passasse attorno la corda fino a infilare un’estremità dentro un’asola e facesse un piccolo nodo robusto. Adesso il braccialetto era saldo e stretto al mio braccio sinistro. A quel punto Silvia sparí, come in un mélo hippie, anche se non sembrò promettermi niente e mi lasciò con un banale «ci vediamo».
Un ciclista pieno di birra pedalava piano sotto il bagliore arancio dei lampioni. Via Farini era attraversata dal profumo di una panetteria aperta, dove si era raccolto qualche altro ubriaco. Dopo un bel pezzo di strada a piedi, superata la Torre Arcobaleno, arrivai finalmente a casa. Preparai il trolley, riempiendolo di tutta la roba che ci voleva per passare un paio di settimane in spiaggia.
Tornato a Milano dopo le vacanze, il racconto di Silvia, la biografia per sommi capi di suo padre e sua madre, le foto nei cortei del Sessantotto di cui mi aveva parlato, mi riapparvero in sogno.
Il giorno dopo era il primo di settembre. Non avevo un lavoro. Quella mattina, sotto la doccia, sentii il telefono squillare due volte.
![]()
Piero, il capoautore, mi fece entrare in una saletta improvvisata a ufficio, proprio accanto alla redazione. Si presentò con una stretta di mano elettrica e franca, e un sorriso comico, che spinse in alto le rughe degli occhi e la montatura nera in bachelite. Dietro la scrivania c’era una finestrella che dava su via Colussi e i tetti di Milano est. Non era la prima volta che finivo dentro gli studi della rete. Casette di periferia a due piani, con i gerani rossi e le azalee sul davanzale. Sotto la redazione si vedevano le moto parcheggiate, gli scooter con i bauletti e le biciclette legate con la catena a una rastrelliera. In mezzo alla parete, di fronte al divanetto Ikea, c’erano due quadri dalla cornice in bambú con serigrafie di Thomas McKnight. Non avevo mai conosciuto Piero, se non di nome. Piú di un collega aveva accennato a lui ogni volta che la chiacchiera, durante una pausa in montaggio o un viaggio in metropolitana, era finita su un certo giro di autori comici o su una nuova casa di produzione. «Ma tu hai mai lavorato con Piero Ruffini? E in Fremantle, hai mai lavorato?»
Al termine di un preambolo, senza entrare nel merito della questione, Piero se ne andò, girando su sé stesso e imboccando la porta a vetri. Come in una partita di calcio, gli diede il cambio Claudio, altro autore comico. Claudio portava pantaloncini mimetici tagliati al ginocchio e un paio di Nike. Era abbronzato come se fosse appena sbarcato a Malpensa da un viaggio a Formentera. Ci sedemmo su due poltroncine da ufficio, con le ruote logore e mangiucchiate. Negli anni dovevano aver lasciato la ragnatela di graffi che vedevo sui listoni in pioppo.
Come Piero, Claudio era molto alto, quasi un metro e novanta, e aveva un modo elastico di camminare, facendo della spina dorsale una molla. Ogni passo era un atterraggio. Il tallone lo adoperava come una leva alloggiata dentro le sneakers. Senza muoversi in coppia, ma ciascuno lungo un proprio raggio d’azione, componevano la diarchia a capo di un gruppo autoriale che solo apparentemente si occupava di tv. Sotto quell’etichetta, in realtà, si praticava una disciplina ibrida che si nutriva del rimbalzo, del tocco effettato, affine al basket, allo snowboard, alla rima hip hop, pressata con mestiere, giorno dopo giorno, dentro la struttura del copione, fino a trasformarsi in sketch, battute, bumper in o bumper out, voltapagina, lanci, grafiche, tappi, crawl, andate a nero. Li conoscevo di fama e avevo visto qualche loro trasmissione.
– Quest’anno sono cambiate molte cose, nel format, – disse Claudio. – Ti spiego: oltre all’ospite ci sarà un game a fine puntata, vale a dire un quiz. – Che genere di quiz? – gli chiesi e mi disse che avrebbero sorteggiato qualcuno tra il pubblico per portarlo a centro studio e fargli una specie d’interrogazione di Storia: – Scegliendo dentro un bouquet di vecchie notizie che prepareremo e gli presenteremo noi, dopo averle selezionate da qualche archivio. Un po’ di cronaca, un po’ di costume, di sport, di televisione, di spettacolo, di cinema. Tutto. L’arrivo in Italia di Windows ’95; Mike Bongiorno che lascia la Rai e firma per Berlusconi e la Fininvest; la visita in carcere di papa Wojtyła ad Ali Ağca; la messa in onda di Arnold, di Friends, di Seinfeld, di Beverly Hills 90210; l’entrata in vigore dell’euro; il debutto di Doom, il videogioco; Grecia Colmenares, le telenovelas; i viaggi di Beppe Grillo in Brasile e in America. Ma niente cronaca nera. Siamo uno show satirico. Niente stragi, niente bombe, niente sangue. Niente morte di Lady Diana. O forse sí. Dipende. Comunque dobbiamo torturarlo, il sorteggiato. L’idea ci è venuta dai vox populi che fanno davanti al Parlamento, o di fronte alle scuole, dove viene fuori che nessuno sa piú un cazzo, che nessuno ricorda piú nulla della strage di Bologna o della Seconda guerra mondiale, okay? Mi dimentico niente? Non mi dimentico niente. Allora, che ne pensi? – Non ci fu tempo di rispondere: continuò a parlarmi. – Devo dirti che ci sei venuto in mente per la figura del… – fece una pausa in quel getto a rubinetto, per indovinare un’immagine: – … di quello col casco e la tuta stagna, che deve scendere dentro gli archivi dei quotidiani come un palombaro, del cercatore di notizie, quello che si mette lí a rovistare nel passato, insomma. – E dove le trovo le notizie? – gli chiesi. – Te l’ho detto, negli archivi dei quotidiani. Entri con o senza password, a seconda dei casi, e te ne stai chiuso a leggere fino alle sette di sera, a cercare tutte le notizie che ci servono. Verifica chi ha un archivio e chi no –. Al «Che ne pensi? Accetti?», risposi con una spinta in avanti del busto, e dissi di essere «concretamente interessato».
– Le notizie devono essere brillanti. Devono avere un link stretto con la giornata e l’attualità, dobbiamo stare sul pezzo. Se c’è il lancio di un nuovo iPhone, allora cerchiamo la pubblicità di un prodotto Apple di trent’anni fa, okay? La trovi su un giornale o cerchi il commercial americano su YouTube e la mandi al montaggio e in grafica. Vado a braccio: se un politico dice una cazzata, cerchiamo la foto di un epic fail. Esempio: un Babbo Natale in skate che va a sbattere contro un palo. Niente di sofisticato. Milly Carlucci chiede piú ritmo a Kaspar Capparoni, allora noi cerchiamo una foto della Ritmo Fiat. Staremo molto su Facebook e su Twitter. Dobbiamo tenere il pubblico agganciato. Non mollarlo mai. Status, gif, fotomontaggi. Parlargli, incalzarlo, coinvolgerlo. Ci sarà il ragazzo dell’ufficio stampa, lo stesso della rete, che seguirà i nostri account. Dalla mattina e per tutto il pomeriggio fino alla diretta –. Feci di sí con il mento pulito e sbarbato, sgranando un pelo gli occhi, come se stessi dividendo a fette le informazioni. Poi Claudio proseguí: – Ti faccio una domanda. È una mia curiosità personale, anzi professionale. Tu preferisci Face...