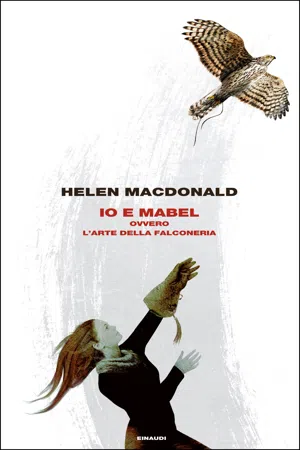![]()
![]()
A tre quarti d’ora da Cambridge, in direzione nordest, si stende un paesaggio che ho finito per amare moltissimo. È dove l’umida palude cede il passo alla sabbia inaridita. Una terra di pini contorti, auto bruciate, cartelli stradali crivellati di colpi e basi dell’aviazione americana. Qui abitano fantasmi: le case si sgretolano dentro lotti numerati di foreste di pini. Sotto tumuli erbosi protetti da recinzioni alte quattro metri ci sono spazi per armi nucleari, e poi saloni di tatuaggi e campi da golf dell’Usaf. In primavera è un’orgia di rumori: un incessante viavai di aerei, fucili a gas su coltivazioni di piselli, tottaville e motori a reazione. Sono le Brecklands – broken lands, le terre spaccate –, ed è lí che mi ritrovai quel mattino di sette anni fa, all’inizio della primavera, in un viaggio neanche lontanamente programmato. Alle cinque stavo fissando un riquadro di luce esterna proiettata sul soffitto e ascoltavo un paio di tiratardi che chiacchieravano sul marciapiede. Mi sentivo strana, una sensazione sgradevole: tesa, spossata, come se mi avessero asportato il cervello e imbottito il cranio con pellicola di alluminio passata al microonde, ammaccata, carbonizzata, un cortocircuito pieno di scintille. Oddio, avevo pensato, allontanando le coperte. Devo uscire. Via! Uscire! Mi ero infilata jeans, stivali e maglione, mi ero ustionata la bocca con del caffè bruciato e solo quando la mia gelida e antica Volkswagen procedeva ormai da un po’ sulla A14 mi ero resa conto di dove stessi andando e perché. Là fuori, oltre il parabrezza appannato e le strisce bianche, c’era la foresta. La foresta spaccata. Ecco dove stavo andando. A vedere gli astori.
Sapevo che non sarebbe stato facile. Gli astori non lo sono. Avete mai visto un rapace catturare un uccello nel vostro giardino? Io no, ma so che è successo. Ho trovato i segni. Ogni tanto, minuscoli frammenti sul lastrico del cortile: il piccolo arto di un uccellino, simile a un insetto, la zampa serrata dai nervi contratti; o, piú raccapricciante, un rostro disarticolato, la parte superiore o inferiore del becco di un passero, una piccola goccia grigio piombo arrossata, lievemente traslucida, con sopra appiccicate impalpabili piume facciali. Ma forse voi sí, forse lanciando un’occhiata dalla finestra voi avete visto, là fuori, sul prato, un rapace enorme intento a uccidere un piccione, un merlo, una gazza, e vi è sembrato l’esemplare selvatico piú grosso e impressionante su cui aveste mai posato gli occhi, come se qualcuno vi infilasse un leopardo delle nevi in cucina e voi lo beccaste mentre si mangia il gatto. A me è capitato che al supermercato o in biblioteca qualcuno mi corresse incontro per riferirmi a occhi sgranati: «Stamattina in giardino ho visto un astore catturare un uccello!» E ogni volta ero lí lí per ribattere: Uno sparviero!, quand’ecco arrivare la precisazione: «Ho guardato sul libro. Era un astore». Ma non è mai cosí; i libri non servono. Quando lotta con un piccione sul vostro prato il rapace diventa molto piú grande di quanto non sia in realtà, e le illustrazioni di un libro di ornitologia non corrispondono mai al ricordo. Qui c’è lo sparviero: grigio, petto barrato bianco e nero, occhi gialli e coda lunga. E questo qui di fianco è l’astore: anche lui grigio, petto barrato bianco e nero, occhi gialli e coda lunga. Mmm, pensate voi. Leggete la descrizione. Sparviero: 30-40 centimetri di lunghezza. Astore: 50-60 centimetri. Eccolo. Era enorme, quindi sarà un astore. L’aspetto è identico. Gli astori sono solo piú grandi, tutto lí. Solo piú grandi.
No. In realtà gli astori stanno agli sparvieri come i leopardi stanno ai gatti. Piú grandi, certo. Ma anche piú massicci, piú sanguinari, piú micidiali, piú spaventosi e molto, molto piú rari. Uccelli del folto dei boschi, non dei giardini, sono il graal proibito dei birdwatcher. Potete passare una settimana intera in un bosco pieno di astori senza mai vederne uno, solo qualche indizio della loro presenza. Una calma improvvisa seguita dai richiami terrorizzati degli altri uccelli, e la sensazione di un movimento che sfugge alla vista. O i resti dilaniati di mezzo piccione in un’esplosione di penne bianche sul pavimento della selva. O magari siete fortunati e, camminando nell’alba nebbiosa, girate la testa e per una frazione di secondo vedete sfrecciare un proiettile d’uccello, enormi zampe artigliate, occhi puntati su un bersaglio distante. Una frazione di secondo che però basta a stamparvi indelebilmente nella memoria quella visione, lasciandovi solo piú bramosi. Inseguire un astore è come inseguire lo stato di grazia: arriva, ma non spesso, e non sapete mai né dove né quando. Le probabilità di incontrarne uno aumentano tuttavia di quel poco nelle mattine serene di inizio primavera, perché è allora che gli astori abbandonano il folto degli alberi per andare a corteggiarsi in cielo aperto. Ed era ciò che io speravo di vedere.
Sbattei la portiera rugginosa della macchina e mi addentrai armata di binocolo in un bosco peltrato di brina. Dall’ultima volta che c’ero stata ne erano scomparsi tratti interi. Mi imbattei in zone distrutte, aree disboscate zeppe di radici divelte e di aghi secchi sparsi sul terreno sabbioso. Radure. Ecco che cosa mi serviva. Lentamente il mio cervello si riadattò a spazi che non frequentava da mesi. Era cosí tanto tempo che vivevo solo in biblioteche e aule universitarie, fissando schermi, correggendo compiti, spulciando bibliografie accademiche. Questa era una caccia diversa. Lí ero un animale diverso. Avete mai osservato i cervi quando escono allo scoperto? Fanno un passo e si fermano, restano immobili, naso levato in aria, a osservare e a fiutare. Ogni tanto un fremito nervoso gli percorre i fianchi. Poi, finalmente sicuri, si lasciano alle spalle il sottobosco, adagio, e vengono a brucare. Quel mattino mi sentivo come un cervo. Non che fiutassi l’aria o me ne stessi ferma in preda allo spavento, ma come un cervo mi spostavo nel paesaggio seguendo modalità arcaiche e istintive, adottando forme di attenzione e di condotta inconsce. A mia stessa insaputa, qualcosa mi diceva come e dove mettere i piedi. Saranno un milione di anni di evoluzione, sarà l’intuizione, ma quando vado a caccia di astori provo un senso di nervosismo se devo camminare o sostare alla luce del sole, e mi ritrovo a puntare inconsapevolmente verso la semioscurità, o a scivolare nelle ombre fredde e sottili lungo le ampie cesure tra i pini. Il richiamo di una ghiandaia o il prolungato grido d’allarme di un corvo mi fanno trasalire. Entrambi potrebbero significare Pericolo, astore! o Pericolo, essere umano!, e quel mattino volevo trovare l’uno nascondendo l’altro. Le vecchie intuizioni spirituali che per millenni hanno legato i nervi all’anima avevano preso il sopravvento e furono loro a guidarmi, comunicandomi disagio se uscivo allo scoperto o ansia se procedevo sul lato sbagliato di un crinale, ordinandomi a un certo punto di avanzare fino a un rilievo d’erba piú chiara per raggiungere qualcosa dalla parte opposta: uno stagno. Dalla riva si levarono nuvole di piccoli uccelli: fringuelli, peppole, uno stormo di codibugnoli che finirono impigliati tra i rami dei salici come batuffoli di cotone animati.
Lo stagno era il cratere lasciato da un ordigno, uno di un’intera batteria sganciata sopra Lakenheath da un bombardiere tedesco durante la guerra. Un’anomalia idrica, quella pozza fra le dune circondata da densi ciuffi di carice a cosí tanti chilometri dal mare. Scossi la testa. Che stranezza. Del resto lí tutto è strano, e camminando per il bosco ti imbatti in un sacco di cose che non ti aspetti. Larghi tratti coperti di lichene delle renne, per esempio, stelle e fioretti e sentori minuscoli di un’antica flora che ancora cresce sul terreno esaurito. D’estate questa chiazza di Artide atterrata nel posto sbagliato scrocchia sotto i piedi. Ovunque affiorano coste ossute e lame di selce. Nelle mattine umide può capitarti di raccoglierne frammenti scheggiati dalle mani degli artigiani del Neolitico, scaglie di pietra luccicante rivestite da esili membrane d’acqua gelida. Allora questa regione era il cuore dell’industria della selce, e in seguito diventò famosa per i conigli da carne e da feltro. Un tempo su queste terre sabbiose si stendevano enormi warrens, garenne recintate e delimitate da siepi di rovi da cui i dintorni hanno preso il nome – Wangford Warren, Lakenheath Warren –, ma alla fine i conigli portarono la rovina. A forza di brucare di concerto con le pecore ridussero la corta zolla erbosa a un’esile scorza di radici di superficie. Là dove i pascoli erano stati messi piú a dura prova la sabbia spirava formando cumuli e avanzava ovunque. Nel 1688 forti venti di sudovest la soffiarono in cielo e un’enorme nube gialla oscurò il sole: tonnellate di terra si levarono, traslocarono e riprecipitarono al suolo. Brandon si ritrovò circondata dalle sabbie; Santon Downham ne fu inghiottita, il suo fiume soffocato. Quando i venti si placarono, dune ininterrotte correvano da Brandon fino a Barton Mills e l’area acquistò fama orribile e impervia: le dune, cedevoli, erano roventi d’estate e infestate dai banditi di notte. La nostra Arabia Deserta. Per John Evelyn erano le «sabbie vaganti» che «in tanto sfacelo hanno versato il paese, rotolando di loco in loco similmente alle sabbie dei deserti della Libia, e seppellendo campagne intere»1.
Eccomi lí, tra le sabbie vaganti di Evelyn. Il grosso delle dune è nascosto dai pini, piantati negli anni Venti per fornire il legname necessario a guerre future, e i banditi sono scomparsi da tempo. La sensazione di pericolo, di sepoltura, di rovina, però rimane. A me piace perché di tutti i posti che conosco in Inghilterra mi sembra il piú selvatico. Non di una selvatichezza inviolata da picco montano, ma di una selvatichezza sgangherata e bizzarra frutto di cospirazione tra il luogo e le genti. Trasuda un diverso senso di storia della campagna; non soltanto sogni ricchi e grandiosi di possedimenti terrieri, ma una storia fatta di industrie, silvicoltura, disastri, commercio e lavoro. Un posto perfetto per andare in cerca di astori. E loro alla perfezione si adattano allo strano paesaggio delle Brecklands, perché altrettanto umana è la loro storia.
Una storia affascinante. In passato gli astori si riproducevano in tutto l’arcipelago britannico. «Vi sono astori di varii tipi e taglie, – scriveva Richard Blome nel 1618, – diversi per carattere, forza e ardimento a misura dei Paesi in cui vengano allevati; ma nessun luogo supera la Moscovia, la Norvegia e il Nord dell’Irlanda, in ispecie la Contea di Tyrone»2. Le virtú degli astori caddero tuttavia nel dimenticatoio con l’avvento delle leggi sulle enclosures, le recinzioni delle terre comuni, che limitarono la possibilità di far volare liberamente i rapaci, e delle armi di precisione, che portarono alla ribalta i fucili a discapito della falconeria. Anziché compagni di caccia gli astori diventarono cosí animali nocivi, e il colpo di grazia a una popolazione già indebolita dalla perdita di habitat naturale venne dalla guerra senza quartiere ingaggiata dai guardacaccia. Alla fine dell’Ottocento gli astori inglesi erano estinti. Ho la fotografia dei resti di uno degli ultimi esemplari abbattuti, un’istantanea in bianco e nero di un uccello proveniente da una tenuta scozzese: sporco di fango, impagliato e con gli occhi vitrei. Fine di un’era.
Negli anni Sessanta e Settanta, però, senza troppo rumore i falconieri avviarono un progetto di ripopolamento. Il British Falconers’ Club calcolò che, per ogni astore importato dal continente a scopo di falconeria, se ne poteva importare un secondo da rimettere in libertà. Compri uno, liberi uno. Nel caso di un uccello predatore e indipendente come l’astore, non certo un’impresa impossibile. Bastava trovare un bosco e aprire la gabbia. Altri falconieri che la pensavano allo stesso modo cominciarono a fare la stessa cosa in tutta l’Inghilterra. Gli esemplari arrivavano dalla Svezia, dalla Germania e dalla Finlandia, e per la maggior parte si trattava di esemplari enormi, chiari, delle foreste della taiga. Alcuni furono liberati apposta. Altri, semplicemente, si persero. Sopravvissero, si trovarono e, senza troppo rumore, riuscirono a riprodursi. Oggi il numero dei loro discendenti si aggira intorno alle quattrocentocinquanta coppie. Elusivi, spettacolari, perfettamente integrati, la realtà degli astori inglesi mi rende felice. La loro esistenza sfata la falsa credenza che natura inviolata significhi sempre natura non sfiorata dal cuore e dalla mano dell’uomo. Invece può esserne il frutto.
Erano le otto e mezza esatte. Stavo osservando un giovane virgulto di maonia che sbucava dalla terra, le foglie rosso scuro simili a pelle di cinghiale lucidata. Sollevai lo sguardo. E vidi i miei astori. Eccoli là. Una coppia che volava alta sopra le cime degli alberi, nell’aria sempre piú calda del mattino. Il sole mi teneva una mano aperta e rovente sul collo, ma alla vista di quegli uccelli le mie narici sentirono odore di ghiaccio. Odore di ghiaccio e fronde di felci e resina di pino. Cocktail di astore. Stavano prendendo quota. Nell’aria gli astori diventano di un grigio complicato. Non grigio ardesia e neanche grigio piccione. Piú un grigio nembo, e malgrado la distanza individuai il grosso piumino da cipria delle caudali inferiori aperte a ventaglio, seguito dalla coda compatta e arrotondata, e quel superbo piegarsi e incurvarsi delle secondarie che impedisce assolutamente di confondere un astore in ascesa con uno sparviero. Erano assediati dalle cornacchie ma non ci facevano nemmeno caso, della serie chi se ne importa. Una cornacchia scese in picchiata verso il maschio, che senza tanti drammi sollevò un’ala per lasciarla passare. Ma quella non era stupida e non gli rimase sotto a lungo. In realtà gli astori non erano nel pieno del corteggiamento e non vedevo nessuna delle acrobazie tipiche di cui avevo letto nei libri. Piú che altro corteggiavano lo spazio che li separava, cesellandolo in una molteplicità di splendide distanze e segmenti concentrici. Un paio di colpi d’ala e il maschio, il terzuolo, si portava al di sopra della femmina, poi saliva gradualmente verso nord e di nuovo giú, veloce, una coltellata, nitido svolazzo calligrafico sotto di lei, che abbassava un’ala per tornare a impennarsi in sua compagnia. Si muovevano sopra una macchia di pini, proprio davanti a me. Poi all’improvviso erano spariti. Un attimo prima la mia coppia di astori stava descrivendo in cielo traiettorie degne di un testo di fisica, e un attimo dopo il nulla. Non mi sembrava di avere abbassato gli occhi o stornato lo sguardo. Forse avevo solo battuto le palpebre, nient’altro. E, in quella minuscola lacuna obliterata dal cervello, loro si erano rituffati nel bosco.
Mi sedetti, stanca ma felice. Gli astori se n’erano andati, il cielo era vuoto. Il tempo scorreva. Intorno a me la lunghezza d’onda della luce si accorciava e il giorno si allungava. Uno sparviero, lieve come un modellino di balsa e velina impermeabile, mi sfrecciò accanto ad altezza ginocchia, planando su un letto di rovi e infilandosi tra gli alberi. Lo guardai passare, smarrita nei ricordi. Memorie incandescenti, irresistibili. L’aria sapeva di resina di pino e dell’aceto pecioso delle formiche del legno. Sentivo le mie piccole dita agganciate agli anelli di una catenella di plastica e il peso di un binocolo della Germania Est intorno al collo. Mi annoiavo. Avevo nove anni. Di fianco a me c’era papà. Eravamo a caccia di sparvieri. Nidificavano nei dintorni e quel pomeriggio di luglio speravamo in un avvistamento del tipo che ogni tanto ci era concesso: il fremito subacqueo che tra le cime dei pini accompagnava il tuffo di un esemplare; il giallo di un occhio; barrature pettorali tra gli aghi in fermento, o un’improvvisa silhouette nera stampata contro il cielo del Surrey. Per un po’ era stato eccitante fissare nell’oscurità in mezzo agli alberi e all’arancione sanguigno e al nero dello sghembo pavimento di ombre create dal sole. Ma a nove anni l’attesa è pesante. I miei piedi chiusi negli stivali di gomma scalciavano contro la base dello...