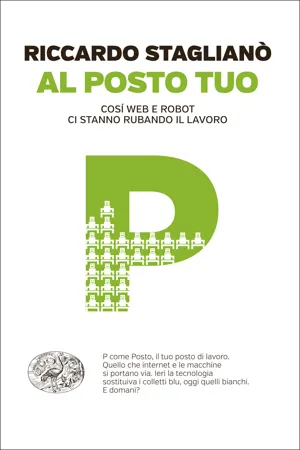3,2 milioni di addetti al commercio
(Italia 2014. Fonte: Istat)
Come sono diventato uno «shopaholic» elettronico.
All’inizio fu un telecomando universale, quelli che invece di averne quattro diversi per tv, dvd, videoregistratore e stereo, ti permettono di fare tutto con uno solo. Sedici dollari e ottantotto, acquistato il 29 luglio 2003. Seguirono libri, auricolari Sony, una macchina fotografica Canon Powershot da 4 megapixel che all’epoca non era cosí male. Di tutti saprei dirvi prezzo e data di acquisto, non perché sia un feticista dello scontrino, ma perché li ho comprati su Amazon.com che non dimentica niente della nostra storia di consumatori. Basta andare al menu «ordini» e visualizzarli anno per anno. È una sorta di autobiografia merceologica involontaria, con risvolti potenzialmente anche divertenti, per ripercorrere attraverso gli oggetti le fasi della nostra vita. Vi sto parlando però del sito americano e di 3-4 acquisti all’anno perché la triangolazione per farli arrivare in Italia era un po’ complicata. O li intercettavo io durante qualche viaggio statunitense o dovevo farli spedire ad amici che a loro volta me li rispedivano. Cosí i costi lievitavano, come pure i tempi di consegna, e la gratificazione dell’acquisto si riduceva drammaticamente. Altri tempi.
Aspettavo in gloria il giorno in cui Amazon, che già aveva inaugurato siti in vari altri paesi europei, avrebbe alzato i battenti in Italia. Sul punto specifico avevo anche intervistato a Seattle il numero tre dell’azienda, Diego Piacentini, che mi aveva rivelato l’ovvietà che il problema erano le poste. Quel giorno tuttavia arrivò alla fine del novembre 2010. Mi iscrissi subito ma all’inizio, come quando il desiderio lungamente dilazionato si infrange con la realtà, comprai poco. Nel 2011 un trolley Eastpak e una custodia per iPad per un totale di 75 euro. L’anno successivo gli ordini quadruplicarono: una custodia per telefono, un toner della stampante, uno stylus per la tavoletta grafica, un orologio Casio di quelli che andavano di moda quando ero ragazzo e che incredibilmente esistevano ancora, delle lame di ricambio per un rasoio elettrico Braun, dei sandali Birkenstock per mio padre seguiti da altri per me (visto che con i suoi era andato tutto liscio), una borsa da bici. Il tutto per circa 206 euro.
L’anno della svolta, come ricostruisco adesso, è però il 2013. Mi abbono a Prime che, in cambio di 9,99 euro all’anno, mi dà diritto a consegne illimitate a costo zero per un’ampia serie di articoli. Non so quanto ha contato, ma è da lí che comincio a darci dentro. Compro una stampante wifi; un Kindle Paperwhite; un super-lucchetto Kryptonite Evolution Mini; un fanale anteriore Busch & Müller per bici che illumina quasi come quello di un motorino; un’altra borsa da bici (quella di prima, troppo economica, si era tutta scolorita sotto il sole e faceva abbastanza schifo); una pompetta per fare il sottovuoto nel vino, una mandolina tedesca per affettare le verdure; una bilancia digitale per alimenti, un aspirapolvere a pile che si rivelerà abbastanza inutile; sei pile Aaa ricaricabili, utilissime; forbici Fiskars come quelle esposte nel reparto design del MoMA; una teglia per dolci con fondo staccabile; un microfono Røde per fare interviste con l’iPhone; il libro Morte dei marmi del mio amico Fabio Genovesi; una tastierina Logitech ultrasottile per iPad mini che si sdoppia anche come custodia; un set di prese telecomandate tedesche (quelle, per intenderci, con cui puoi accendere qualsiasi apparecchio collegato alla presa elettrica dove le hai applicate senza dover spaccare il muro per fare una traccia che porti a un interruttore); una batteria esterna per iPhone; una batteria di ricambio per quella esausta del computer portatile; un filo retrattile per stendere i panni sul balcone. Totale: 630 euro, euro piú euro meno. Ovvero il triplo dell’anno prima e sei volte di quello prima ancora. L’anno dopo gli ordini crescono ulteriormente e diventano 23, per un totale di 645 euro. Tra le ricorrenze statistiche, per gli eventuali voyeur del carrello altrui o per i sociologi dei consumi alla Vanni Codeluppi, segnalo un altro libro di Genovesi, Versilia Rock City (perché me l’aveva suggerito il recommendation engine? No, ma avrebbe potuto), un diverso modello di Kryptonite, il New York, che tengo per me (quello precedente era un regalo) e un nuovo stendipanni retrattile, stavolta a due fili paralleli e assai piú robusti (l’altro si era schiantato sotto il peso di un lenzuolo matrimoniale bagnato).
L’ingrediente segreto: nessun errore è irreversibile, tutto si può cambiare!
Peccato che, a rischio di sembrare ossessionato, anche il secondo stendipanni si riveli molto deludente. Non si può regolare la tensione dei fili e se ci metti sopra troppa roba il tutto si imbarca in maniera immonda, toccando terra e inzaccherandosi, al punto che decido (dopo aver fatto i buchi nel muro del balcone, fissato i tasselli e montato l’ingombrante aggeggio) di restituirlo. È la prima volta che mando indietro qualcosa. La procedura si rivela sorprendentemente semplice. Online vai sull’ordine e clicchi su reso, brevemente spiegando perché ci hai ripensato. A quel punto devi stampare un foglio con un codice a barre che metterai nella busta o nel pacco per la restituzione. O chiedi al corriere che venga a ritirarlo a domicilio (io ho fatto cosí), o lo porti tu alle poste, usando l’affrancatura prepagata da Amazon. Che a stretto giro ti riaccredita i soldi sulla carta di credito. Ora provate un attimo a immaginare cosa sarebbe successo se avessi provato a restituire lo stesso oggetto al ferramenta sotto casa. Il massimo cui potete aspirare, quando trovate gente particolarmente ben disposta, che magari soprassiede su un’ispezione al Luminol della merce deludente, è di ottenere un buono da spendere nel medesimo negozio. E questo, vale la pena ripeterlo, è lo scenario fortunato. Mi dilungo su questi dettagli apparentemente eccentrici, e piuttosto corrivi, rispetto al tema del libro per farvi avvicinare a un ragionamento. Ci sono motivi niente affatto misteriosi se la curva dei miei acquisti online è cresciuta cosí tanto, in cosí poco tempo. Il primo si chiama varietà. Nel negozio sotto casa, in media, trovo sí e no un decimo dei modelli reperibili online. Il secondo si chiama prezzo. In media mi sembra di spendere almeno il 20 per cento in meno di quel che succederebbe offline. Il terzo motivo ha a che fare con la comodità. In due-tre giorni la merce arriva a domicilio. E se qualcosa non ti piace non devi inventarti una scusa fine-del-mondo per cercare di convincere il cerbero di turno a guardia di un punto vendita della grande distribuzione o del singolo fortilizio d’antan del commercio di quartiere a riprendersela.
Amazon è diventata Amazon rimuovendo ogni traccia di stress dall’esperienza dell’acquisto (è il quarto motivo, che chiameremo «fattore serenità»). Parafrasando l’intuizione di un responsabile marketing di un’azienda di cosmetici degli anni ’50 citato ne I persuasori occulti di Vance Packard («Noi non vendiamo rossetti, compriamo clienti»), il gigante di e-commerce di Jeff Bezos si è conquistato negli anni la fiducia dei propri utenti regalando loro una totale pace mentale. Qualsiasi cosa succeda, qualsiasi dubbio o ripensamento abbiano, c’è sempre un modo (piuttosto indolore) per rimediare. Ciò spiega perché, nella prima metà del 2015, avevo già comprato undici articoli, sino a quando il mio nuovo senso di colpa ha pigiato sul freno. Perché adesso mi è molto piú chiaro (lo intuivo anche prima, ma preferivo ignorarlo) che comprare online non è senza conseguenze. E ha a che fare con quella peculiare schizofrenia contemporanea di cui l’economista Robert Reich parla nel libro Supercapitalismo. Ovvero quella che, da consumatori, ci fa ipersalivare per ogni sconto online mentre, da cittadini, ci fa addolorare quando il negozietto di mattoni che vende le stesse cose chiude per mancanza di utili. Eppure le due cose non sono disgiunte. Con il primo cappello in testa siamo entusiasti (ancorché spesso inconsapevoli) complici dell’uccisione del business del nostro vicino al cui funerale (rigorosamente indossando il secondo cappello) partecipiamo affranti. E ovviamente la dissonanza cognitiva non è limitata al commercio, ma praticamente a tutti gli altri esempi che toccheremo in questo libro. Per dirla con Reich, «comprare un biglietto del treno allo sportello anziché alle macchinette automatiche è un atto politico». Significa: ci metto un minuto di piú, ma non partecipo alla rottamazione dell’uomo dietro allo sportello. In questa prospettiva lo slogan storico di Amazon, «and you’re done», «e fai in un attimo», assume un altro, ben piú inquietante significato, dal punto di vista dei negozi tradizionali che hanno assaggiato la polvere nell’impossibile rincorsa del colosso di Seattle. Amazon, e sei spacciato. Per te è la fine. Kaputt.
Ad Amazon basta un terzo dei dipendenti del negozio sotto casa…
Dopo tante parole e una svergognata ostensione del mio prosaicissimo carrello della spesa, qualche numero saccheggiato da un definitivo articolo scritto da George Packer del «New Yorker» per capire di cosa stiamo parlando. Cinque virgola venticinque miliardi di dollari: è il fatturato Amazon del 2014 per le vendite di libri, ovvero il 7 per cento dei 75 miliardi totali (compresi gli stendibiancheria e le mandoline concupite e acquisite dal cronista). Diciannove virgola cinque per cento: è la quota dei Kindle, gli e-book di Amazon, sul totale dei libri venduti. Cinquantatre per cento: lo sconto reale che la compagnia ottiene da Random House, il piú grande editore statunitense. Una parte del quale viene rubricato come «fondi per sviluppo marketing», ovvero soldi che Amazon chiede agli editori in cambio di promozione sul sito (i piccoli editori, con meno margine di contrattazione, alla fine possono essere costretti a fare sconti anche superiori al 60 per cento). Cinquanta per cento: la riduzione del numero delle librerie indipendenti negli ultimi vent’anni. Negli Stati Uniti erano circa 4000, oggi sono meno di 2000. A farle fuori hanno cominciato le grandi catene, tipo Barnes & Noble e Borders, a loro volta cannibalizzate da Amazon. Meno del dieci per cento: percentuale di libri venduti attraverso le librerie indipendenti. Quattordici: il numero di dipendenti che Amazon impiega per ogni 10 milioni di dollari generati. Prima, per i negozi tradizionali, erano 47. Oltre tre volte tanto.
Ecco, fermiamoci un attimo su questo dato, calcolato dall’Institute for Local Self-Reliance di Washington a partire dai numeri forniti dallo Us Census. Sebbene Amazon assuma (quasi 30 mila dipendenti nel 2013), finisce per distruggere molti piú posti di lavoro di quanti ne crei. D’altronde il fondatore Jeff Bezos sembra pensare dei lavoratori la stessa cosa del suo omologo di Uber Travis Kalanick: una volta che li avremo totalmente fatti fuori dall’equazione, è il senso, il nostro prodotto sarà davvero perfetto. Amazon l’ha capito sin da subito, sia per quanto riguarda il versante piú fisico (la gestione del magazzino) che quello piú intellettuale (i contenuti del sito), soprattutto per quanto riguarda la merce piú preziosa, ovvero i dati sul comportamento dei clienti. Con notevole anticipo rispetto al web 2.0 propriamente detto, l’azienda di Seattle è stata la prima a intuire che tutto quel che poteva essere esternalizzato agli utenti sarebbe stato un enorme risparmio. Cosí ha iniziato con le recensioni dei libri. Perché chiederle ai professionisti, con la loro caratteristica e fastidiosa pretesa di essere pagati, quando ci sono migliaia di dilettanti pronti a scriverle gratis? Il capolavoro è stato vendere un sistematico taglio di costi come la prova ontologica della democraticità dell’azienda. Ed era, appunto, solo l’inizio. La parte piú sofisticata riguarda i consigli al lettore: se hai comprato questo, allora ti potrebbe piacere anche quest’altro. All’inizio Amazon aveva assunto redattori per fare ciò che i librai hanno sempre fatto: raccomandare libri. Ma presto ha capito che gli algoritmi erano sicuramente piú economici e forse addirittura piú efficaci. Il «team personalizzazione», nome in codice P13N, ha cosí cominciato a sostituire le raccomandazioni fatte dagli umani con quelle ottenute in automatico dal software dopo aver analizzato la storia degli acquisti passati da cui dedurre inferenze statistiche su potenziali acquisti futuri. Sulla parete di quell’ufficio, stando a Vendere tutto di Brad Stone, c’era un cartello irridente che avvertiva: «La gente dimentica che John Henry alla fine è morto». Un riferimento piuttosto crasso alla figura semi-leggendaria di uno Stachanov afro-americano, il cantoniere che alla fine dell’800 faceva buchi per l’esplosivo nella roccia per aprire tunnel ferroviari. Armato solo di mazza e forza fisica a un certo punto Henry avrebbe ingaggiato una gara con un prototipo di martello pneumatico a vapore, per vedere chi riusciva a farne di piú. Alla fine il suo cuore non aveva retto la competizione con la macchina. E oggi, un secolo e mezzo dopo, gli ingegneri di Seattle ne facevano materia prima per il loro umorismo nero.
… e sta lavorando per far fuori anche quelli.
L’altro fronte sul quale Amazon procede nel disboscare dagli umani è quello della logistica. Con una progressione piuttosto tipica, prima ha assunto magazzinieri, pagandoli poco e facendoli trottare tanto. Compresi i casi estremi, come quello denunciato dall’«Allentown Morning Call» nel 2011 di ambulanze parcheggiate davanti a un magazzino nel bel mezzo della Pennsylvania che servivano da shuttle per il pronto soccorso per i tanti che svenivano durante un’ondata di caldo anomala (l’aria condizionata è stata introdotta dopo la denuncia, e in concomitanza con l’introduzione del servizio di consegna di alimenti). Fino allo scandalo fatto emergere da un’inchiesta della tv pubblica tedesca nel 2013, con condizioni di lavoro altrettanto pessime e l’aggiunta inquietante di sadici vigilantes reclutati dalle file dell’ultradestra germanica. Per non dire dell’inchiesta con cui, nell’agosto scorso, il «New York Times» ha rivelato il parossistico mix di efficienza (con email a mezzanotte seguite da sms per sapere perché non avevano ancora risposto) e terrore, con adulti che piangono alla scrivania come bambini, che l’azienda esigerebbe dai suoi dipendenti. Tra i quali, in America, non ce n’è uno iscritto al sindacato. Un alto dirigente, dando prova di ammirevole candore, aveva spiegato di considerare le organizzazioni dei lavoratori un ostacolo al continuo miglioramento dell’assistenza ai clienti. Questa della forza lavoro low cost, tuttavia, è sempre stata considerata una tappa intermedia. La soluzione finale è un’altra: sostituirli con le macchine. È per questo che, quattro anni fa, il colosso di Seattle ha acquisito per 678 milioni di dollari Kiva Systems. La sua specialità sono robot logistici della forma e dimensioni di un grosso pneumatico, sdraiato in parallelo al terreno, che riesce a spostare sulla schiena interi scaffali, per portarli piú vicini al magazziniere che a quel punto non ha che da estrarre il prodotto e impacchettarlo. Oggi, oltre ai 50 mila magazzinieri negli Stati Uniti, Amazon impiega circa 15 mila di questi robot. Per dirla altrimenti, un quarto della sua forza lavoro logistica è non umana. C’è dunque ancora un ampio margine di miglioramento.
Non a caso uno dei momenti piú attesi dell’International Conference on Robotics and Automation che si è tenuta a maggio scorso a Seattle è stato proprio l’Amazon Picking Challenge. Ovvero una gara tra robot da tutto il mondo per automatizzare anche la penultima parte, ovvero l’estrazione del prodotto dallo scaffale trasportato dal Kiva (l’ultimo passo sarà il suo imballo nella scatola di cartone che poi verrà spedita al cliente). I prodotti da afferrare erano di venticinque tipi diversi tra cui una scatola di biscotti Oreo (simili ai nostri Ringo: la difficoltà sta nel non sbriciolarli), un’edizione economica (quindi piú pieghevole della brossura) di Huckleberry Finn di Mark Twain, una paperella gialla da vasca da bagno, un barattolino di colla liquida in plastica, una rana di pelouche e cosí via. Ogni oggetto ha una forma e una consistenza molto diverse tra loro. Per noi non è un problema. Anche un bambino, dopo i primi anni di vita, sa dosare presa e forza a seconda delle situazioni. Ma per un robot questa varietà presenta una sfida non banale. Se applica troppa forza a un oggetto fragile lo polverizza. Se non posiziona bene le pinze intorno a un contenitore troppo tondeggiante, gli cade e può danneggiarsi. Tutti errori che hanno costi economici che possono sballare l’impresa. Alla fine il primo premio è stato vinto dalla squadra della Technical University di Berlino. Il loro Rbo, afferrando correttamente 10 oggetti su 12 in 20 minuti si è aggiudicato 148 punti (i candidati del Mit, secondi classificati, ne hanno totalizzati solo 88) e 20 mila dollari come ricompensa. Nell’attesa che si compia la promessa fatta da Bezos durante un’intervista televisiva a Charlie Rose, uno dei volti piú noti della tv Usa, per cui entro i prossimi cinque anni anche la consegna a casa sarà stata fatta senza scomodare alcun umano. Ci penseranno i droni. E a quel punto saremmo finalmente soli, noi con i nostri acquisti. Perché tanta avversione per i lavoratori in carne e ossa? Perché costano. Si stancano. E se li tratti troppo male i giornali ne parlano e ti rovinano l’immagine. Invece, dal primo giorno, l’ossessione di Bezos è quella di fare contento il cliente (compreso quello che legge i giornali). In tutti i modi. Uno, oggettivo, è di poter vantare tra i prezzi piú bassi in circolazione. Risultato che Amazon centra in due modi. Il primo accettando margini bassissimi per sé (in alcuni casi vendendo anche sotto costo, come è successo per il lancio del Kindle, allo scopo di diventare la piattaforma piú usata). Il secondo imponendo ai fornitori margini ancora piú bassi e condizioni capestro. Cosí facendo da una parte fa fuori chi non sta su Amazon. Ma dall’altra, con paletti rigidissimi, indebolisce anche chi usa la sua piattaforma. Fuori o dentro, non c’è salvezza: tutti devono fare i conti con l’everything store che nel 2013 era il nono venditore al mondo per fatturato e sembra destinato a diventare il numero due entro il 2018. E che nel frattempo, a luglio scorso, ha addirittura superato la catena Walmart quanto a capitalizzazione di borsa (250 miliardi di dollari) laureando Bezos la quinta persona piú ricca del pianeta.
L’«everything store», paradiso di chi compra e inferno di chi vende.
Ci viene facile solidarizzare con altri consumatori, molto meno con i venditori. Ma mi era tornato in mente quel che mi aveva raccontato un vecchio amico di mio padre, Edoar-do Boccaccini, poco dopo aver deciso di trasportare una parte di Idea Interior, la sua gloriosa attività di arredamento di design che gestisce da sempre con la moglie Maria, sulla celebre piattaforma: «È stato un incubo. Un giorno ti dirò…» Sono passati anni e il momento è arrivato. Cosí sono andato a trovarlo. Lui era appena rientrato da un paio di boline sulla sua piccola barca a vela, ci siamo seduti a uno splendido tavolo scandinavo e mi ha finalmente spiegato in cosa consistesse il brutto sogno da cui si era dovuto risvegliare. In primo luogo il trasloco stesso si era rivelato assai piú laborioso (e quindi dispendioso) del previsto. «Pretendono un minimo di quattrocento articoli. Per ognuno serve codice Isin, specifiche e caratteristiche dell’imballo» ovvero una discreta imputazione di dati che Edoardo aveva delegato a un neolaureato, pagandolo mille euro. Di ogni prodotto bisognava indicare chi fosse il fornitore «cosí, se scoprono che quella cosa vende bene, magari lo contattano direttamente loro, tagliandoti fuori dal business». Quindi c’era la commissione: 15 per cento. Oltre a questa, dal totale incassato, stornavano anche un cautelativo 5 per cento come garanzia per eventuali vizi della merce, che Amazon ti avrebbe restituito, in assenza di contestazioni, quattro mesi dopo l’acquisto. Ma le contestazioni capitano. E anche se non è colpa tua, puoi rimetterci. «Una volta ci era arrivata una email da una signora che aveva ricevuto da noi un sofisticato accessorio da scrivania da 427 euro che, a sentir lei, non aveva mai ordinato. Eppure noi l’ordine ce l’avevamo. “Ha figli piccoli? – avevo suggerito, – Sarà stato lui, per sbaglio, mentre lei era fuori”. Ma la signora negava e voleva indietro i suoi soldi. Cosa che ovviamente è successa e gli unici a rimetterci, il 20 per cento tra commissione e vizi, siamo stati noi». Il che spiega meglio perché Amazon è cosí tranquilla quando qualcuno rende le cose: molto spesso non è lei a pagare. Ma allora chi glielo fa fare a un commerciante di aprire una vetrina sul gigante dell’e-commerce?
«Ovviamente è una collocazione di grandissima visibilità. Loro lo sanno, e se ne approfittano. E i nostri margini si assottigliano pericolosamente». In media, per le merci che tratta lui, lo sconto del produttore è tra il 40-42 per cento che, al netto dell’Iva, equivale a un 33 per cento. Significa che, se Boccaccini vende a 100 euro, ne ha guadagnati 33. Ma se ci togli i 15 di Amazon, il ricarico diventa del 18 per cento. E se qualcosa va storto, si scende subito al 13 per cento. Che, per la gigantesca scala di Amazon, è un margine ancora decoroso, ma su quella ben piú piccola di un venditore di provincia assume tutto un altro sapore. L’apparente paradosso è che il danno maggiore Boccaccini l’ha subito online. Nel 2006 fu il primo in Italia ad aprire un sito che vendeva Stokke, le sedie ergonomiche ...