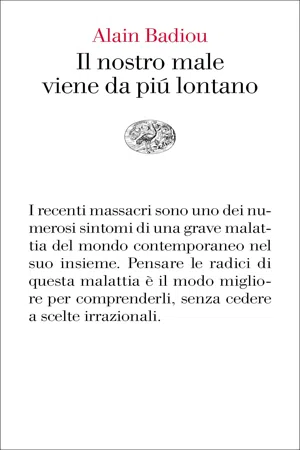![]()
Procediamo dunque con la struttura del mondo contemporaneo, cosí come appare ai miei occhi e come in maniera evidente ci permetterà d’illustrare la nostra questione. Penso che sia possibile descriverla, a grandi linee, attraverso tre temi profondamente intrecciati, profondamente connessi.
Premetto che tutto ciò può sembrare di una banalità desolante, ma a mio parere le conseguenze di questa banalità sono lungi dall’essere tratte. Da trent’anni assistiamo al trionfo del capitalismo globalizzato.
Un trionfo che è innanzitutto, in modo particolarmente visibile, il ritorno di una sorta di energia primitiva del capitalismo, a cui è stato attribuito il nome discutibile di neoliberismo, e che in effetti è la riapparizione e la ritrovata efficacia di quella che da sempre è l’ideologia costitutiva del capitalismo, vale a dire il liberismo. Dubito che il prefisso «neo» sia giustificato. A ben guardare, non credo che quello che sta accadendo sia tanto «neo». In ogni caso, il trionfo del capitalismo è una specie di energia ritrovata, il ritorno di quella indiscussa capacità di mostrare, ormai pubblicamente e senza il minimo pudore, se cosí posso dire, le caratteristiche generali di questo tipo di organizzazione molto particolare della produzione, degli scambi e, alla fine, delle società intere, e anche la sua pretesa di essere l’unica via ragionevole per il destino storico dell’umanità. Tutto ciò, che è stato inventato e teorizzato sul finire del XVIII secolo in Inghilterra e che avrebbe dominato incontrastato per decenni, è stato ritrovato con una sorta di gioia feroce dai nostri padroni di oggi.
«Globalizzato» ha una sfumatura un po’ diversa. Il capitalismo attuale si è insediato in maniera esplicita su scala planetaria. Ciò significa che questo capitalismo globalizzato è non solo un capitalismo che ha ritrovato la sua energia dissolvente, ma che l’ha anche profusa in modo tale che oggi il capitalismo, inteso come struttura globale, costituisca un dominio praticamente incontrastato per l’insieme del pianeta.
Il secondo tema è l’indebolimento degli Stati. È una conseguenza davvero sottile del primo, ma è molto interessante evidenziarlo.
È risaputo che uno dei concetti piú irrisi del marxismo è stato quello del deperimento dello Stato. Il marxismo sosteneva che la riorganizzazione dello Stato, dopo la distruzione rivoluzionaria degli Stati-nazione dominati dal capitalismo, avrebbe condotto in via definitiva, attraverso un potente movimento collettivo di tipo comunista, a una società senza Stato, una società che Marx chiamava «associazione libera». Ebbene, noi oggi assistiamo a un fenomeno del tutto patologico, vale a dire a un processo capitalista di deperimento degli Stati. È un fenomeno fondamentale per la nostra epoca, nonostante sia mascherato dalla sussistenza, per un periodo storico probabilmente piuttosto lungo, di poli statali di notevole potenza. In realtà, la logica generale del capitalismo globalizzato consiste nel non avere rapporti diretti e intrinseci con la sussistenza degli Stati nazionali, perché oggi la sua diffusione è transnazionale. Negli anni Sessanta, si era evidenziato il carattere multinazionale delle grandi imprese. Ma queste imprese sono diventate da allora dei mostri transnazionali di ben altra natura.
Il terzo tema, infine, è quello che chiamerei delle nuove pratiche imperiali, le modalità dell’azione di forza, se cosí posso dire, dell’espansione mondiale del capitalismo.
1. Il trionfo del capitalismo globalizzato.
Il trionfo del capitalismo globalizzato è un’evidenza che hanno tutti ben presente. Oggi, il mercato mondiale è il riferimento assoluto della storicità planetaria. Se ne parla in continuazione. Non è un mistero che appena la borsa di Shanghai oscilla, il mondo intero si preoccupa, sembra terrorizzato, si chiede cosa succederà, e cosí via…
L’aggressività che accompagna questa estensione del carattere dominante del mercato mondiale come riferimento della storicità planetaria è particolarmente spettacolare. Oggi assistiamo ovunque alla distruzione dei precedenti tentativi d’introdurre nel capitale una misura. Per misura intendo i compromessi del passato, in particolare nell’ultimo dopoguerra, tra la logica del capitale e altre logiche. Altre logiche che potevano essere il controllo statale, le concessioni fatte ai sindacati, la reticenza davanti alle concentrazioni industriali e bancarie, le logiche di statalizzazione parziale, le misure di controllo di alcuni eccessi della proprietà privata, le leggi antitrust… C’è stata anche l’introduzione di misure che hanno esteso i diritti sociali della popolazione, come la possibilità per chiunque di accedere alle cure sanitarie, o di forme di limitazione dell’esercizio privato delle libere attività, e cosí via.
Tutto questo è oggetto di una distruzione sistematica, compreso nei paesi che ne costituivano il paradigma. Non parlo neanche degli Stati socialisti, di quelli che furono i paesi socialisti: la Francia era uno dei paesi che offriva piú esempi di questo spirito di misura. Ebbene, oggi tutto questo viene distrutto con un’applicazione estrema. Si è cominciato ovviamente con le destatalizzazioni, con le privatizzazioni. La parola «privatizzazione» è profondamente aggressiva; anche se non ce ne rendiamo piú conto. Indica senza mezzi termini che alcune attività destinate al bene pubblico devono essere restituite alla proprietà privata in quanto tale. È una parola di un’aggressività straordinaria, benché ora sia diventata banale. In modo analogo, e incessante – si tratti della destra o della sinistra, su questo punto non c’è alcuna differenza –, interi stralci della legislazione sociale vengono demoliti, basti pensare al Codice del lavoro, alla Previdenza sociale, al sistema educativo…
È evidente che la vittoria oggettiva del capitalismo globalizzato è una pratica distruttrice, aggressiva. Non è solamente una specie di espansione ragionata o ragionevole di un particolare sistema di produzione. Ed è impossibile non preoccuparsi per la debole resistenza nei confronti delle distruzioni future. Una resistenza che, di fatto, è una costante marcia indietro. È isolata, frammentata, molto spesso corporativista, settoriale, non è sostenuta da nessuna visione d’insieme. In realtà, questa marcia indietro è ininterrotta da trent’anni.
Si sta imponendo progressivamente uno schema dominante che vieta che sia inflitta al capitalismo la minima forma di misura. In tal senso, possiamo dire che la logica del capitale è stata liberata. Il liberismo è stato liberato. Ecco. Assistiamo da trent’anni, con le mani in mano, alla liberazione del liberismo. E questa liberazione assume due forme: la globalizzazione, cioè l’espansione ininterrotta del capitalismo su interi territori come la Cina, e al contempo la straordinaria potenza di concentrazione del capitale, ossia di quel movimento dialettico caratteristico del capitale: il capitale si espande e, espandendosi, si concentra. L’espansione e la concentrazione sono due modalità, assolutamente legate tra loro, della natura proteiforme del capitale.
Le concentrazioni si realizzano, dunque, nello stesso tempo in cui le privatizzazioni e le distruzioni accelerano il loro corso.
Di sicuro non vi sarà sfuggita, per la sua forma un po’ spettacolare, la recente fusione di Fnac e Darty, due perle della grande distribuzione. Una fusione tra il libro e il frigorifero! Che il fine sia strettamente finanziario è molto chiaro, e caratterizza la fusione puramente capitalistica, senza alcun interesse per il pubblico. Queste concentrazioni creano cosí, progressivamente, dei poli di potenza paragonabili agli Stati, se non addirittura superiori a molti di essi. Si tratta di poli di potenza finanziari, produttivi, a volte speculativi, sempre dotati di un personale considerevole, spesso anche di potenti milizie e che si diffondono ovunque, spesso con la forza, sempre con la corruzione. Questi poli sono transnazionali, tanto da avere un rapporto trasversale con gli Stati. Per quanto riguarda queste potenze transnazionali e massicce, la sovranità dello Stato non è affatto implicita.
Si può pertanto constatare che, al pari di altre imprese di notevoli dimensioni, la piú grande compagnia francese, Total, non paga nessuna tassa sulle società in Francia da molti anni. In base a cosa può essere allora definita «francese»? Sí, certo, la sede si troverà da qualche parte a Parigi, ma… Lo Stato francese, è evidente, non ha nessuna incidenza reale persino su quei poli di potenza che esibiscono la nazionalità francese. È in corso una vittoria, vasta e ramificata, delle ditte transnazionali sulla sovranità degli Stati.
Ma c’è anche una vittoria soggettiva che accompagna questa vittoria oggettiva del capitalismo. È lo sradicamento totale dell’idea stessa di un’altra ...