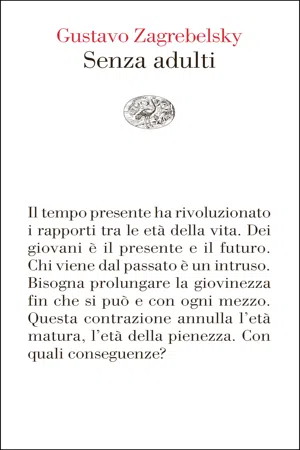![]()
Gioventú e vecchiaia sono due «stati fisici» legati al tempo calcolato sugli anni della vita, con i mali connessi e le limitazioni conseguenti, di competenza della pediatria e della geriatria? O sono stati psichici e spirituali, indipendenti dall’anagrafe?
Indubbiamente, c’è una componente anagrafica che si riflette sugli altri fattori nella definizione delle due età. Quando si dice che la gioventú è l’età dell’incompletezza, della frivolezza, delle passioni sconclusionate e pericolose, delle infatuazioni e delle delusioni, della scontrosità e degli alti e bassi d’umore di cui non ci si può fidare, si mettono in evidenza caratteri che hanno a che vedere con aspetti di personalità ancora in formazione. La stessa cosa è per i bravi «impetuosi» di Machiavelli che abbiamo appena incontrato, ma anche per quelle qualità di spontaneità e dolcezza che si suole riconoscere come tratti distintivi della gioventú. La giovinezza è l’età non corrotta, in cui l’umanità si manifesta genuina, positiva e benevola. Ha occhi ridenti e fuggitivi, soprattutto rapidi. È bella, fresca e contemporaneamente calda, spregiudicata, disinibita, umida e arrogante quanto basta per legittimare la rivendicazione del comando, al posto dei vecchi. Sí, perché i vecchi sono oppressi dai sogni perduti, e i sogni perduti li rendono tristi, fissi, lenti, disincantati, scettici, rassegnati, abulici, stanchi, malinconici, freddi e secchi («marasmatici», disse Galeno). Se non cadono nel mutismo, diventano vacui, queruli, chiacchieroni, brontoloni, fastidiosi e importuni, rancorosi, inutilmente sentenziosi e laudatori di un tempo che non c’è piú. In breve: sono dei seccatori, dei sopravvissuti e dei sorpassati. Se mantengono ancora viva la mente, si vantano di essere «scientifici», di contro ai giovani, che appaiono loro animati da inconcludente «spirito romantico». L’iconografia è ricca e ben rappresenta la triste decadenza della vecchiaia. Quasi mai dipinge la serenità della tarda età, che pure esiste. Per lo piú, i «ritratti di vecchi» esprimono arida sentenziosità o desolata solitudine (per la prima, ad esempio, Joos Van Cleve a Madrid, Prado; per la seconda, Rembrandt a San Pietroburgo, Ermitage).
Persino la conoscenza e l’esperienza del mondo che sono proprie dei vecchi possono essere un handicap e non un vantaggio. La conoscenza e l’esperienza sono in proporzione inversa all’energia. I giovani, per il fatto di essere tali, ne sono immuni. Thomas Mann tratta di quella che egli chiama la nausea del conosce-re o del comprendere di chi «ne ha già sperimentate di tutti i colori» e ora sa darsi la ragione di ogni cosa al mondo: un aspetto fastidioso della relazione di certi vecchi con i giovani
[…] è poi, beninteso, la sufficienza, l’indifferenza, l’ironica stanchezza della verità, come pure è innegabile che nulla è piú sordo e disperato di una cerchia di cervelli fini che ne abbiano già sperimentate di tutti i colori. Ogni conoscenza acquisita è per costoro vieta e stucchevole. Provate a enunciare una verità la cui conquista e possesso vi rendano, forse, giovanilmente felici; uno sprezzante «hm, hm» accoglierà, per tutta risposta, le vostre scoperte […] Ah sí, la letteratura stanca […] Comprendere tutto vorrebbe dire tutto perdonare? Eh, non lo so. C’è qualcosa […] che io definisco la nausea del conoscere; lo stato d’animo nel quale all’uomo basta vedere a fondo una cosa per sentirsi disgustato a morte (e per nulla disposto alla conciliazione): il caso di Amleto, del danese, di questo prototipo del letterato. Egli sapeva che cosa significhi essere chiamato al conoscere […] Veder limpido pur attraverso il lacrimoso velo dei sentimenti, riconoscere, notare, osservare, e quel che si è osservato doverlo mettere da parte sorridendo, ancora negli istanti in cui mani si stringono, si ritrovano labbra, in cui, spegnendosi nella sensazione, lo sguardo umano vien meno – tutto ciò è infame […], è abbietto, è indegno […] ma a che serve indignarsi?1.
Ogni comprensione totale esclude dunque alternative e, con esse, esclude la libertà morale degli uomini nelle cose del mondo. Soprattutto, non permette di dire: comprendo, ma non giustifico e non perdono. In questo «non» c’è la condizione affinché la libertà morale assuma, per trasformarsi in azione, l’energia che è condizione della libertà stessa. La conoscenza che abbraccia tutte le opzioni spegne le volontà. «Tutto comprendere» significa, infatti, darsi una ragione di ogni cosa, nel senso di tutto giustificare. Se tutto è giustificabile, tutto è accettabile e non c’è motivo di fare scelte. Chi di tutto sa farsi una teoria, finisce per teorizzare che tutto è teorizzabile; che tutto dipende dal punto di vista; che un punto di vista ne vale un altro; che questa è la «verità», e che l’errore sta nel fatto stesso di decidere per una cosa o per un’altra. Questa comprensione totale conduce a risultati contraddittori: o l’autorizzazione illimitata, perché, comunque, una cosa vale l’altra; oppure, l’estraneazione dal mondo, perché non c’è nulla che possa valere. Questo è il pericolo di «chi sa troppe cose» e finisce per accettare che il mondo è un guazzabuglio in cui tutto può essere vero, buono, giusto o falso, cattivo e ingiusto, a seconda dei punti di vista. I punti di vista sono liberi: chiunque può avere il suo e nessuno può imporgliene uno particolare. Questa è la ragione per cui spesso gli uomini di pensiero – qui, effettivamente, fra anziani e giovani si coglie una differenza – sono restii alle decisioni e quindi alle azioni: energia e cultura stanno quasi sempre in rapporto inverso. È anche la ragione per la quale, al contrario, gli uomini d’azione hanno spesso una psiche che ama la superficialità e le semplificazioni e sono piuttosto refrattari alla riflessione2. Anzi, spesso sono uomini insolentemente e lietamente innamorati della loro ignoranza o dell’unilateralità della propria rozza visione del mondo e si sentono autorizzati a dileggiare ciò che essi chiamano sprezzantemente «la cultura». Certo, l’ignoranza è comoda e la sapienza è scomoda, anzi è dolorosa, penosa: «Dove è molta sapienza, v’è molta molestia: e chi accresce la scienza accresce il dolore»3.
Un certo grado di spensieratezza è dunque condizione di vita. Questa considerazione, con riguardo alla vita delle società, è in pagine memorabili di Friedrich W. Nietzsche, rivolte contro il «filisteo colto» (colui che crede di sapere tutto per aver appreso molto da «aggiornate citazioni»). Sono pagine dedicate alla cultura come fardello, remora, appesantimento che spegne la vita. Il titolo, di per sé eloquente, è Sull’utilità e il danno della storia per la vita. Il peso del passato:
La cultura storica è, in effetti […] una sorta d’innata canizie e quelli che sin dall’infanzia ne portano il segno, devono quindi pervenire a un credo istintivo nella vecchiaia dell’umanità; ma alla vecchiaia conviene ormai un’occupazione da vecchi, cioè il guardare indietro, fare i conti, concludere, cercare sollievo nel passato, attraverso i ricordi, insomma: [attraverso] la cultura storica4.
Il filisteo «sradica il futuro» ed è indotto dalla sua erudizione ad accettare come già vista qualsiasi cosa, nella quale non c’è piú nulla di cui stupirsi. Egli coltiva una sorta di estetismo storico della cultura; è il saccente e aggiornato chiacchierone che disquisisce sullo Stato, sulla Chiesa, sull’arte, su ogni sensazione umana; è «uno stomaco insaziabile che ciononostante ignora che cosa siano davvero la fame e la sete». Egli crede che tutto sia già stato detto e vissuto. Le società soffocate da un «eccesso di storiografia» si isteriliscono, come risucchiate dal loro passato. La cultura si trasforma in «indigeribili pietre del sapere», che «rumoreggiano nel corpo» senza generare alcunché, tantomeno una qualsiasi ricchezza interiore. Invano le società cercano la propria «salute» riempiendosi di codeste pietre. L’uomo moderno è sterile e vuoto, insaziabile e iperattivo. Consuma smodatamente cultura. Ma si tratta di un consumo che finisce per consumare il consumatore, in una sorta di eccitazione fine a se stessa. Da qui, la funzione positiva dell’ignoranza, che seleziona e libera energie.
Dunque, c’è di sicuro una base biologica: non è esclusivamente e, forse, neppure principalmente un fatto di cultura.
Tuttavia, non diciamo anche che ci sono giovani per età che sono vecchi per spirito o, al contrario, che ci sono vecchi per età che sono giovani per spirito? Dicendo cosí, non sottintendiamo che le età della vita dello spirito non corrispondano necessariamente agli anni di esistenza del corpo? Oppure, che vi siano caratteri spirituali che frequentemente non coincidono con le età anagrafiche? L’identificazione della giovinezza e della vecchiaia con i dati anagrafici sarebbe adeguata alla natura dell’oggetto se esso fosse la mera esistenza, non la vita, secondo la distinzione che si è messa in testa di questa esposizione. Chi ci appare piú giovane, dal punto di vista della vita: Lev Tolstoj che a ottantadue anni, su un vagone di terza classe, la notte del 28 ottobre 1910 se la svigna da Jàsnaja Poljàna e dall’esistenza monumentale che vi aveva costruito per cercare una nuova vita in Crimea, oppure il ventenne rampollo di famiglia che passivamente segue le tracce che papà ha preparato per lui, per assicurargli un’esistenza possibilmente uguale alla sua?
Se ciò che conta è lo spirito, non ignoriamo affatto l’importanza del fisico e della sua salute. L’essere umano è un’unione. Pura spiritualità è un’aberrazione tanto quanto pura fisicità. Cosí, un fisico debilitato e colpito da malattie incontra difficoltà a coltivare la giovinezza dello spirito. Ma non sempre gli inconvenienti fisici hanno la meglio sull’energia spirituale. Sono i vecchi-giovani. Al contrario, non incontriamo con frequenza giovani-vecchi, coloro nei quali si verifica l’opposto? Questi apparenti ossimori dimostrano di per sé la relativa indipendenza della nozione anagrafica da quella spirituale. Relativa, però; l’età anagrafica, al termine, può avere la meglio. La fine di Tolstoj che pochi giorni dopo la sua fuga, il 7 novembre, muore nella stazione ferroviaria di Astàpovo pronunciando le parole (se è vero quanto fu riferito): «Svignarsela! Bisogna svignarsela!» mostra, se ce ne fosse esigenza, che alla fine la natura biologica ha il primato sulla piú forte delle nature spirituali.
Non si può che accettare un certo grado di indeterminatezza che rifugge dalle generalizzazioni. Possono valere le parole di Max Weber, dette in riferimento alla celeberrima contrapposizione fra l’etica della convinzione rispetto ai principî (che sarebbe propria dei giovani) e l’etica della responsabilità nei confronti delle conseguenze (che sarebbe propria dei vecchi):
Chi agisce secondo l’etica della convinzione è ignaro delle potenze diaboliche che entrano in gioco. Esse sono inesorabili e creano alla sua azione, e anche a lui nel suo intimo, conseguenze alle quali egli è abbandonato senza difese ove non ne abbia chiara visione. «Il diavolo non è nato ieri». E non è agli anni, non è all’età, che intende riferirsi l’adagio: «Bisogna perciò diventare vecchio per capirlo». Nemmeno io ho mai accettato di essere sopraffatto in una discussione in forza della data del certificato di nascita; ma, d’altro canto, il semplice fatto che uno abbia vent’anni e che io superi i cinquanta non può tutto sommato indurmi a considerare questa circostanza come un merito davanti al quale dovrei prosternarmi in venerazione. Non l’età conta; bensí lo sguardo addestr...