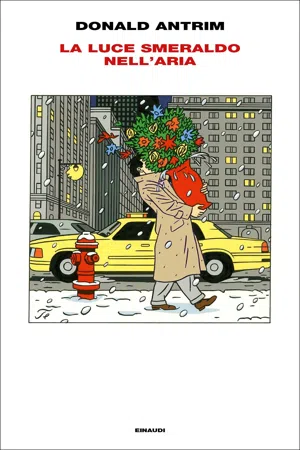![]()
Lee Strasberg, tra i fondatori del Group Theatre e grande insegnante del Metodo, diede ai suoi allievi il famoso consiglio di non «usare» mai – per generare lacrime eccetera, in una scena drammatica – materiale storico/personale appartenente al passato storico/personale dell’attore da meno di sette anni; altrimenti la Memoria Emotiva (la morte di una persona amata o un evento analogo nella vita dell’attore che, non appena evocato tramite il ricordo e la sostituzione, può, come si suole dire, aprire le cateratte al momento giusto, sera dopo sera, anche nel corso di molte repliche), essendo, per certi versi, troppo recente, potrebbe travolgere l’artista e compromettere il controllo totale necessario a recitare la parte o, piú precisamente, a recitarla bene; potrebbe, a dirla tutta, destabilizzare lo spettacolo; se, per esempio, a un dato momento di una scena si rende indispensabile che Nina o Gertrude o Macduff si asciughino le lacrime e vadano avanti con la propria vita; se, in quel momento, l’attore in lacrime non riesce a riprendersi; se, in altre parole, l’attore resta intrappolato dall’emozione anche quando il personaggio si è spostato a tavola o sul campo di battaglia – quando succede una cosa del genere, state sicuri che ne verrà fuori un marasma teatrale folle.
Cosa voglio dire con tutto questo discorso? Che Strasberg si sbagliava. Sette anni non bastano, l’ho scoperto poco tempo fa, durante una rappresentazione al tramonto del Sogno di una notte di mezza estate, andata in scena sul prato del college per commemorare la fondazione, centocinquant’anni orsono, ad opera del reverendo William Trevor Barry – mio trisnonno dal lato paterno –, del piccolo istituto di studi umanistici che reca nome e stemma della nostra famiglia. Sono Reginald Barry, preside del centro orientamento e docente di Arte drammatica presso il Barry College, dunque è naturalmente toccato a me dirigere l’allestimento commemorativo a piedi nudi della grande e gioiosa commedia shakespeariana. Mentre lo preparavo, ho deciso di produrmi io stesso in un ruolo da mattatore, impersonando Lisandro. Che senso ha un Lisandro di quarantasei anni, secco, con la pelata, celibe e senza figli – un accademico con la schiena villosa – nell’ambito di uno spettacolo studentesco? Non credo di saper rispondere a questa domanda. Di norma, a cimentarsi nel ruolo di Lisandro, dovrebbe essere un aitante portiere di lacrosse, che aspetta il proprio turno per frequentare-stuprare la bellissima e diafana Mary Victoria Frost, la nostra Ermia, lei pure solo una giovane allieva del secondo anno e già la migliore attrice che abbiamo mai avuto da quando insegno al Barry, sicura candidata a Yale, o alla Juilliard, se riuscirà a rallentare un po’ con le droghe. Potrei interpretare Egeo o Teseo, o magari Oberon, il re delle fate, se mi sentissi all’altezza. Ma l’idea forte per lo spettacolo la decide il regista. Due stagioni fa abbiamo messo in scena una Bisbetica domata di tutti maschi tutti nudi. Gli spettatori hanno detto che li ha aiutati a comprendere meglio le potenzialità radicali del dramma elisabettiano.
Dunque, la commedia. Quattro adolescenti scacciati dalla legge e dai genitori in un verde universo governato da spettri, tutti a giocare – i ragazzi e i loro fantasmi – con l’amore e i malefici notturni.
Gli adolescenti eravamo io, Mary Victoria Frost, Sheila Tannenbaum, nel ruolo di Elena, e Billy Valentine, in quello di Demetrio. Sheila, del terzo anno, interpreta parti da caratterista quando non gioca a pallacanestro per le Mamme Orse, e io sapevo che sarebbe stata un’Elena accettabile anche se non del tutto gradevole, con le sue manone e l’andatura scoordinata e gli occhi castani troppo distanti sul viso asimmetrico, storto; ma era Valentine il vero azzardo nell’assegnazione dei ruoli. Valentine incarna un certo tipo di ragazzo biondo alto-borghese – tipo riconoscibile in qualunque scuola privata del paese, immagino –, uno svogliatello sarcastico, smilzo, che, sulla scorta di nessuna prova, i coetanei reputerebbero un genio.
– Billy, non presentarti strafatto alle prove, – l’ho avvisato prima della lettura integrale del copione.
– Strafatto, prof? – Si è messo a ridere. Il venerdí precedente alcuni di noi si erano ritrovati stesi sui divani del mio ufficio sulla Lower Hancock, rintronati da una potentissima erba nostrana fornita da Billy.
– Siamo qui per lavorare, – gli ho detto, e lui: – Non crede che dovrei farlo io Puck?
– Vuoi dirigerlo tu lo spettacolo, Valentine? – gli ho chiesto. – No? Allora, se permetti, le parti le assegno io.
– Ehi, prof, tranquillo. È solo che Martin non può leggere il copione. Cioè, non ci vede.
Billy Valentine aveva ragione. Dare la parte di Puck a Martin Epps era come darla a… mah, non saprei. Come lo difendi un Robin Goodfellow cieco totale che gira picchiettando in scena con il bastone telescopico, se non in teoria?
A livello drammaturgico la teoria mi pareva abbastanza valida; perciò ho aperto le prove illustrandola – in forma alquanto indiretta – ai miei attori. Eccolo lí, il «clan dei teatranti», nello scantinato senza finestre di Hancock Hall, venticinque o trenta fra Innamorati, Reali, Spiriti, Allegri Compari, macchinisti, tecnici scenografi, figuranti, tutti col cerchio alla testa, tutti in jeans tardo-primaverili sfrangiati a metà coscia, camicia oxford e toppino trasparente, quasi ogni membro di quel consesso – tranne Martin Epps, il cieco – tirava boccate di sigaretta; era una folla annoiata, dall’aria blasé. – La visione autentica, espressa sul piano artistico da Shakespeare tramite il personaggio di Puck, trascende la capacità di aprire gli occhi, guardarsi intorno e vedere quel che non va nella tua vita, – ho annunciato a quei fattoni dall’ormone impazzito.
Nessuno ha aperto bocca, tanto meno alzato gli occhi, e io ho avuto la terribile sensazione che mi assale all’avvio di ogni periodo di prove, quando mi rendo conto delle tante delusioni che mi aspettano. Ho detto: – Be’, comunque, Teseo, la battuta che dà inizio alla commedia è la tua.
Ancora silenzio. – Danielle, hai l’elenco delle parti? – ho chiesto alla mia assistente di scena del secondo anno.
– Un attimo, prof, è qui da qualche parte.
– Chiamami Reg, – le ho detto. – Durante la commedia siamo tutti uguali.
Mi ha fissato come se non ne fosse tanto sicura. L’etichetta poco ortodossa lascia spesso perplessi i giovani. Ha trovato l’elenco degli attori e – con un gesto che voleva essere «teatrale» – se l’è sventolato sopra la testa. – Greg Lippincott, tu fai Teseo.
– Ah, per cui il nome si pronuncia cosí? – ha chiesto Greg. Era dura credere che fosse un Lippincott di Filadelfia. Ha tirato una boccata di sigaretta. Si è sentita qualche risatina. Ci abbiamo messo quattro ore a leggere tutto il copione. Danielle recitava le battute a Martin Epps e Martin le ripeteva una alla volta, con diligenza, parola per parola, come una spia che viene istruita per una missione.
– Metterò una cintura intorno alla terra in quaranta minuti!1 – ha declamato Danielle.
– Metterò. Una. Cintura. Intorno alla terra. In quaranta minuti, – ha detto Martin.
Mi sono segnato di chiedergli di velocizzare e di non battere il ritmo per terra con il bastone. Mi sono anche segnato di avvisare Jim Ferguson di non intercalare con «cioè» i discorsi di Oberon a Titania. Avevo un po’ timore di dire a folletti e fate che il loro costume di scena consisteva in perizoma e copricapezzoli.
In queste situazioni delicate posso sempre contare su Carol, la nostra costumista, la mia donna.
Carol è arrivata in tarda settimana, durante la nostra prima prova vera e propria, e ha perorato la causa della tenuta succinta.
– Credo saremo in grado di dedurre dall’abbigliamento che queste fate sono giocose e assai pericolose, terrene eppure diaboliche, con particolare insistenza sul genere che non solo sovverte la nostra cultura dominata dal maschio ma sottolinea anche la crudeltà reciproca dei giovani innamorati nel boschetto ateniese, – annunciò guardandomi dritto in faccia. Possibile che Carol dovesse vedere tutto come un riflesso dell’antagonismo sessuale nel nostro rapporto di amore-odio?
Ha sollevato i bozzetti delle fate – Ragnatela, Fiordipisello, Bruscolo e Senape – alla luce abbagliante della plafoniera. Una ragazza in shorts e maglietta ha obiettato: – Non esiste. Io non ci esco lí fuori nuda.
– È il teatro, tesoro. Non sei nuda tu, ma il personaggio.
– Ben detto, Carol, – sono intervenuto io, poco saggiamente. Carol mi ha rivolto uno dei suoi sguardi furenti, ricordandomi che era giunta al limite della sopportazione nella nostra storia d’amore. Cosa posso dire? Dopo cinque anni, capita con una certa regolarità. La verità è che non siamo mai stati molto felici insieme. Ci punzecchiamo e ci perdiamo in squallidi litigi. I dettagli ve li risparmio, dirò solo che ogni volta che penso alle nostre liti, o a Carol che beve, mi sento triste per noi due; a quel punto mi viene voglia di telefonarle per sapere se sta bene; e questo comportamento, come capirà subito chiunque abbia vissuto una sia pur breve relazione erotica ostile, prelude quasi immancabilmente al sesso da sballo.
– E io, cosa mi metto? – ha urlato un ragazzo dal fondo dello scantinato. Era Sam English, un habitué del teatro, gran barba e voce profonda; era il mio Bottom. Carol ha spiegato a lui e a tutta la compagnia: – I costumi sono fatti per suggerire il periodo storico e la classe sociale, pur riferendosi anche al vestiario moderno. Bottom e i suoi colleghi Artigiani indosseranno una cintura da sollevamento pesi sulla tunica di lana che ha il nome del personaggio stampato sopra con i trasferelli.
Era stata mia l’idea di raffigurare i volgari artigiani di Shakespeare come una squadra di sollevamento pesi elisabettiana. Li immaginavo con le confezioni da sei birre penzolanti dagli anelli di plastica trasparente. – Bottom e i suoi uomini, subito qui davanti, – ho urlato, per cominciare la prova di quel giorno della commedia nella commedia, l’irresistibile «tediosa breve scena del giovane Piramo e della sua amante Tisbe»2 del quinto atto.
Ed ecco arrivare Quince, il falegname; Bottom, il tessitore; Flute, l’aggiustamantici; Snout, il calderaio; Snug, il carpentiere; e Starveling, il sarto – nella realtà un gruppetto di laureandi in scienze politiche e studi religiosi. I sei mi hanno attorniato e io ho detto: – Siete delle seghe, oltre che brutti. Siete un branco di dipsomani analfabeti di ritorno e mi stupirei se qualcuno di voi fosse stato a letto con una donna. Le vostre madri dovrebbero vergognarsi.
I ragazzi sembravano confusi e ho capito di averli portati dove volevo. È utile, per il regista, offuscare i confini tra attore e ruolo, suscitare, con pochi vocaboli stringenti, se necessario, una certa instabilità emotiva; nella fattispecie stavo sfruttando le normali insicurezze dei miei studenti onde portarli a identificarsi con la variopinta ghenga shakespeariana.
Ho poi tenuto a quegli Allegri Compari il mio discorso edificante sulla dura vita del teatro. A un certo punto mi sono accorto di Danielle – la vedevo sopra il capoccione di Sam English; agitava la mano e si indicava l’orologio, faceva quei gesti e quelle smorfie assurde che fa la gente quando ha bisogno della tua attenzione e al contempo ti teme –, cosí ho concluso: – Ragazzi, il punto è questo. La gente crede che il teatro sia magico e romantico. A volte è cosí. Ma di solito è solo una marea di cazzate che non interessano a nessuno.
– Ora dell’improvvisazione animale! – ha gridato Danielle.
Il Sogno di una notte di mezza estate, raccontano gli storici, fu probabilmente rappresentato per la prima volta a un matrimonio reale celebrato d’estate in una dimora fuori Londra. Può darsi che gli invitati, come tutti gli invitati a nozze nel corso della storia, siano rimasti inebriati dall’alcol e dallo spirito afrodisiaco dell’evento. Le giovani coppie, che entravano e uscivano di casa, che sgattaiolavano via per flirtare, lasciarsi o fare l’amore, avevano un omologo teatrale negli infelici giovani persi d’amore nel bosco immaginario di Shakespeare. Quanti veri innamorati si saranno svegliati dopo la cerimonia con la nausea e il cerchio alla testa, scoprendosi intrecciati sul prato a una persona conosciuta solo durante i festeggiamenti della sera prima? Volevo creare un mondo dove l’amore è mercuriale, sfrenato, bestiale. Nel nostro allestimento del Sogno di una notte di mezza estate, gli innamorati non sposati si addormentavano dopo essersi rincorsi nella foresta; poi, bagnati dal nettare del fiore di Puck, si giravano sull’altro fianco, si stropicciavano gli occhi, e scopavano con la persona sbagliata.
– Mettiamoci tutti giú a quattro zampe, – ho ordinato agli attori.
E via, tutti giú a quattro zampe. Subito ho notato che Mary Victoria Frost e diverse fate si comportavano come gatti domestici; quelle ragazze inarcavano la schiena, sporgevano le terga feline, e soffiavano. Sheila Tannenbaum – che, nel secondo atto, scena prima, ripete il famoso verso: «Trattami come il tuo cagnolino, cacciami via, colpiscimi»3 –, stava imitando non male un docile cagnetto, si rotolava e tirava fuori la lingua per leccare Billy Valentine, che passava strisciando sullo stomaco. Leone ruggiva e Bottom ragliava come un asino, e Sarah Goldwasser, la nostra Titania, ha cominciato a strusciarsi contro Sam; era chiaro che quei due avevano una tresca. Questa è una cosa che vedo sempre con piacere. Il sesso esalta qualunque spettacolo. – Grunf grunf, – ho grugnito a Mary Victoria Frost.
Io amo il teatro. Davvero tanto. E adoravo i miei attori. Che si adoravano tra loro; quei ragazzi e quelle ragazze – mentre i giorni diventavano settimane e la commedia prendeva forma – stavano cadendo in preda a una passione reciproca senza pudori. Era metà maggio e nell’aria aleggiavano i primi tepori d’estate. Lo scantinato sapeva di chiuso ed era un forno, grazie alla caldaia surriscaldata nell’angolo.
– Non siamo ancora fuori dal guado, – ho annunciato all’inizio della terza settimana. – Quelli che ancora non sanno la parte a memoria rallentano gli altri. Demetrio, calcola bene i tem...