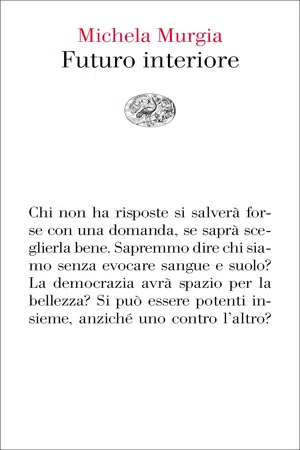L’espressione «vecchio mondo» riferita all’Europa è del tutto appropriata: siamo vecchi ed è con occhi vecchi che guardiamo al futuro. Le ragioni sono diverse, ma la prima è banalmente demografica1: il tasso di natalità europeo è inchiodato da anni alla percentuale di 1,7 nati per donna, un numero che gli studiosi di demografia ritengono essere la soglia minima di sopravvivenza di un popolo.
Si sono ipotizzate le cause piú varie per questa sterilità d’intenzione: il tasso di istruzione che innalzerebbe l’aspettativa generale di qualità della vita, il dislivello di carico genitoriale e lavorativo tra i sessi e anche la presenza o l’assenza di servizi sociali come gli asili, i congedi retribuiti e altre tutele statali. Fino a ora però nessuna delle politiche di incentivo alla natalità, al lavoro femminile e alla condivisione della responsabilità genitoriale messa in atto dai governi europei è stata abbastanza efficace da invertire la tendenza alla scomparsa che sembra aver contagiato tutti gli Stati dell’Unione. In Italia, dove il tasso di natalità è inferiore anche alla pur bassissima media europea, si guarda con invidia alla Svezia o alla Francia perché ancora fanno quasi due bimbi a testa, ma entrambi i Paesi restano distanti dalle impressionanti percentuali africane, dove il numero di nati per donna oscilla fra i tre del Ghana e i cinque del Niger.
La prima conseguenza di questo lento suicidio demografico, combinato con un’aspettativa di vita sempre piú lunga, è l’innalzamento dell’età media: con i suoi 41 anni pro capite, l’Europa attualmente è il Paese con la popolazione piú anziana del mondo, ma le stime dell’Onu prevedono che la media si innalzerà fino a 47 anni entro il 2050. Questo invecchiamento ha molte conseguenze e la prima è di carattere politico: i popoli vecchi fanno meno figli e hanno piú paura, e di conseguenza eleggono governi piú disposti a investire in sicurezza che in istruzione.
L’Europa che verrà, che sta già venendo, avrà forse piú welfare per affrontare la problematica delle malattie da invecchiamento, ma molte meno scuole e asili, diventando un posto piú difficile per chi i figli vorrebbe continuare a farli. Non dovremmo stupirci se in futuro avremo piú caserme e sistemi di controllo sociale che investimenti culturali e spazi aperti ai giovani, né sarà sorprendente vederli sempre piú spesso partire verso luoghi dove la gioventú è considerata ancora un investimento e non un rischio. Siamo un continente in piena crisi di mezza età, già fuori dai processi dove davvero si decide il futuro, ma con ancora abbastanza vita addosso da coltivare l’illusione di poter fare una qualche differenza.
Questa differenza non sarà facile farla, perché l’Europa non è vecchia solo per ragioni demografiche. Per una sequenza di eventi storici del tutto peculiari, questo continente negli ultimi quattro secoli ha vissuto un percorso di evoluzione senza paragoni che ha accelerato esponenzialmente la sua crescita economica, culturale e sociale e ha finito per fargli assumere un’influenza che è andata molto al di là dei suoi confini geografici. L’imperialismo coloniale, gli scismi del cristianesimo, la Rivoluzione francese con l’avvento dei principî democratici, la rivoluzione tecnologica industriale e la conseguente accelerazione produttiva, la contrapposizione pluridecennale tra capitalismo e comunismo, le grandi guerre mondiali: sono solo alcuni dei ravvicinati mutamenti storici che hanno segnato l’Europa e hanno costretto i suoi intellettuali a elaborare in modo sistematico gli strumenti per nominare questi fenomeni e comprenderli. Filosofia, antropologia, scienze umane e sociali, lo studio del linguaggio proprio e altrui e lo stesso metodo scientifico sono nati e si sono perfezionati qui, dove il pensiero complesso si è organizzato prima e in modo piú continuato che in tutti gli altri Paesi del mondo.
Se da un lato questa cornucopia culturale ha regalato agli europei un’enorme gamma di possibilità di espressione e imposizione della propria presenza storica, dall’altro lato ha condotto l’evoluzione dell’idea di Europa verso una sorta di fermo immagine permanente, una stasi che da decenni ce la fa percepire come morente, quasi ci fossimo pensati troppo e avessimo raggiunto un limite di consapevolezza oltre il quale non è possibile procedere. Qualunque cosa di nuovo si stia verificando nel mondo da cinquant’anni a questa parte, si ha l’impressione diffusa che stia avvenendo altrove: con l’America che detiene l’egemonia dell’immaginario, l’Asia e l’India che dominano i vecchi e i nuovi mercati e l’Africa che esplode demograficamente in tutte le direzioni, non è strano che l’Europa appaia come un evento storico-geografico già trascorso persino agli occhi dei suoi stessi cittadini. La sua cultura millenaria, definita da secoli di scambi in cui ci si è potuti permettere il rischio di ogni innesto, ora appare da decenni immobile e conservatrice, in difesa permanente delle posizioni acquisite.
Essere cittadini d’Europa oggi significa aderire a un’idea di cittadinanza statica, che porta il peso inevitabile di un logoramento che rende molto difficile l’eventualità di ripensarla. Allo stesso tempo però quel ripensamento appare indispensabile e non piú rimandabile: i vecchi schemi di definizione dell’appartenenza hanno smesso di funzionare, ma è ancora lí, in quello spazio di relazione dove si definiscono le nuove identità, che l’Europa potrà forse giocarsi la possibilità di avere un ruolo nella storia futura del mondo.
Come potrebbe definirsi la cittadinanza del futuro? Per poter rispondere a questa domanda non si può prescindere da cosa si intende attualmente in Europa con la parola «cittadinanza». Per farlo bisogna tenere presenti due dati ineludibili.
Il primo è che le democrazie che conosciamo sono il risultato tribolato di processi storici molto complessi: gli attuali cittadini con voto sono stati tutti sudditi di un monarca, i sistemi parlamentari sono stati dittature feroci, le federazioni sono state poteri centralizzati e i loro confini sono cambiati innumerevoli volte, costringendo le popolazioni che li abitavano a ridefinire all’infinito il proprio concetto di appartenenza, senza mai risolverlo del tutto. Quello che oggi chiamiamo cittadinanza è il prodotto giuridico di quell’eredità e ne porta addosso tutti gli anacronismi e le contraddizioni.
Il secondo dato è che il continente europeo è quasi interamente composto da statinazione, cioè soggetti istituzionali che per molti decenni hanno vantato una cultura con pretese di omogeneità, dove l’identità di lingua, etnia e valori corrispondeva (o veniva fatta corrispondere con la forza) a quella dei confini geografici. La matrice dell’idea di cittadinanza in uno stato-nazione è tutta in quella maledetta parolina di quattro sillabe: identità. La sua radice latina è la stessa di identico, che indica ciò che è perfettamente uguale, medesimo, somigliante in tutto all’originale. È identico a me – e dunque ha la mia stessa identità – solo chi parla la mia lingua, chi si riconosce nella mia stessa storia, chi mangia secondo le mie abitudini, chi prega il medesimo dio e chi ha il mio stesso colore di pelle.
Secondo questa idea, molto popolare, le diversità non sono un valore, ma una minaccia alle identità nazionali e a quelle personali che ci si rifugiano. Il diverso, lo straniero, l’alieno da me sono elementi di sovvertimento dell’equilibrio simbolico su cui si fonda il concetto di appartenenza nazionale ottocentesca, quello in cui la geografia e l’identità culturale coincidono. La xenofobia in questa cornice non è un problema collaterale che le vecchie società europee possano affrontare fino a debellarlo, ma un elemento costitutivo della loro stessa esistenza: la paura del diverso e della diversità nasce dalla pretesa costitutiva dell’identico e dell’identità. Il terrore dell’estraneo che nutre tutte le destre del mondo ingrassa soprattutto quelle d’Europa, che dei concetti di identità e di radici ha fatto per anni il suo vessillo.
Dentro a questa premessa è chiaro perché nella storia europea degli stati-nazione siano potuti esistere solo due modi per diventare cittadini: o si nasceva su un determinato territorio, oppure si nasceva altrove, ma da persone che di quel territorio potevano comunque rivendicare la cultura. Il primo caso, quello in cui la cittadinanza era determinata dalla geografia, è all’origine delle legislazioni che si appoggiano allo ius soli, il diritto del suolo. Il secondo caso, quello in cui erano i genitori a garantire l’appartenenza, ha dato vita ai sistemi di riconoscimento basati sullo ius sanguinis.
Tutti gli altri aspiranti cittadini, cioè coloro che non sono nati nel territorio di uno stato-nazione né da genitori che vi appartengono, potranno sperare di essere accolti pienamente solo se accetteranno che in quel territorio esista un «originale culturale» che non è il loro e vi si conformeranno, diventandogli somiglianti in tutto. Dovranno parlare quella lingua, assumere quei costumi e far propri per quanto è possibile tutti i marcatori culturali che definiscono l’identità nazionale a cui aspirano, che sia italiana, francese, tedesca, spagnola o una qualunque delle altre europee. In Europa questo processo di progressivo mimetismo è chiamato con notevole ipocrisia «integrazione», ma si tratta piú propriamente di un’assimilazione sociale, un processo in cui la cultura dell’altro viene trattata come minoritaria e subordinata alla propria, che è concepita come superiore per il solo fatto di essere preesistente su u...