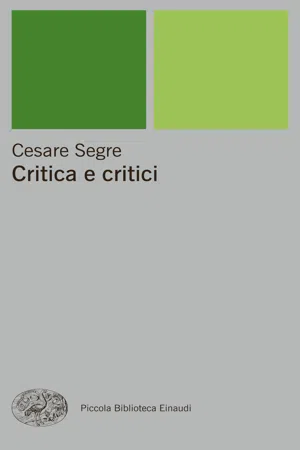![]()
![]()
Parlare di Leo Spitzer in una sede come questa1 non significa solo dare un ritratto di un grande romanista, innovatore della sua disciplina, consacratore di un tipo di critica, la stilistica, tuttora viva, anche se con sviluppi nuovi. Significa illustrare un momento decisivo della storia dei nostri studi.
Portiamoci al 1945. Guerra appena finita, inizio della ricostruzione dopo tante tragedie, recupero culturale dopo una lunga dittatura che aveva isolato l’Italia dal concerto europeo e mondiale. Durante il fascismo era in atto una censura ferrea, che doveva difendere i valori nazionali; in pratica, un provincialismo volontario e il rifiuto di qualunque spirito critico, che avrebbe messo in pericolo le verità del regime. In questo clima, curiosamente, aveva potuto svilupparsi il pensiero di un grande filosofo antifascista come Benedetto Croce, che, almeno nei suoi studi eruditi e critici, non appariva pericoloso alle autorità. Si ebbe dunque uno strano accoppiamento fra censura al nuovo che maturava in Europa, e sviluppo incontrastato dei principî critici crociani. Non sto a riassumerli: tutti sanno che Croce sottoponeva ogni testo a un vaglio mirante a individuare ciò che aveva di buono (la poesia, diceva lui) e ciò che era praticità, erudizione, sentimento non elaborato, struttura (la non poesia); che condannava le analisi rigorosamente linguistiche, o metriche, dei testi, affermando che l’estetica è essa stessa linguistica (come si vede nel titolo dell’opera omonima: Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale); che metteva alla berlina la ricerca formale, contrapponendole il saggio di estetica. Insomma un’impostazione antifilologica, proprio in anni – la prima metà del Novecento – che avevano visto il maturare di una filologia di gran livello, l’allestimento di edizioni critiche esemplari, per esempio quelle di Dante, dell’Ariosto, di Manzoni, ecc.
In questo clima avverso, i filologi avevano continuato il loro lavoro, dando forse il meglio di quanto la nostra filologia abbia mai prodotto: ricorderò i nomi di Pio Rajna, Francesco D’Ovidio, Francesco Novati, Michele Barbi, Cesare De Lollis, Santorre Debenedetti, Angelo Monteverdi. Il volume di Barbi, La nuova filologia e l’edizione dei classici italiani (1938), è quasi il manifesto di questa rinascenza filologica. Analoga eccellenza si nota negli studi classici, dove basta citare Giorgio Pasquali con il suo mirabile Storia della tradizione e critica del testo (1934). Avendo tempo, sarebbe interessante vedere come questi filologi, partiti dall’impostazione positivistica del metodo storico, abbiano poi tenuto presente il pensiero idealistico rappresentato da Croce e allora dominante, trovando mediazioni e contaminazioni. Nel campo della linguistica, l’avere un antecessore come Graziadio Isaia Ascoli indicava già linee di ricerca e procedure collaudate, e soprattutto un intreccio tra storia e sviluppo linguistico, evidente nelle ricerche ascoliane sui sostrati italiani e sulle aree dialettali, ed esteso sino all’attualità della polemica con il Manzoni. Insomma, s’era messo a punto, sotto l’insegna di «Linguistica storica», una concezione culturale del linguaggio, e un modello interpretativo basato sui rapporti dialettici tra individuo e collettività. La libertà linguistica cui l’individuo aspira può esplicarsi solo entro i confini della comprensibilità, e la tradizione non è altro che il deposito di tutte le precedenti innovazioni, se esse sono state accettate. L’individuo è dunque voce della storia sia quando si attiene alle norme della tradizione, sia quando innova riguardo alla tradizione stessa.
I linguisti trovano i materiali per descrivere una lingua nei testi, tra cui quelli letterari spiccano per l’inventività e il dominio dei mezzi linguistici. Ma molti dei linguisti italiani (citerò soprattutto Benvenuto Terracini e Giacomo Devoto) giunsero a spostarsi temporaneamente dalla loro disciplina alla critica letteraria, offrendo analisi autonome di testi, sia pur visti in particolare negli aspetti linguistici. Ricordo come esempio i lavori di Terracini su Dante e su Pirandello (in Analisi stilistica. Teoria, storia, problemi, Feltrinelli, Milano 1966). E non è un caso se intorno al 1938 si affermò come disciplina di insegnamento universitario la Storia della lingua italiana (Migliorini e Schiaffini i primi docenti), che, caratterizzando su un piano storico i testi, li sottoponeva necessariamente a un’analisi linguistica.
Che un testo letterario sia, primariamente, un prodotto linguistico, dovrebbe esser chiaro a tutti. E in effetti la critica, da quella umanistica di tipo retorico alla explication de texte di scuola francese, ha sempre tenuto presente questo dato costitutivo. Diversa la critica idealistica, e crociana in particolare, che da una veloce lettura del testo passava immediatamente ai contenuti, e di quelli parlava o disquisiva. Di qui l’aspetto, per i tempi, rivoluzionario, di analisi letterarie che partivano invece da un approfondito esame del tessuto prosastico o poetico che costituisce ogni testo, e poi del lessico, del modo in cui le frasi sono congegnate, ecc. È in questo che la stilistica di Spitzer apparve come una rivelazione.
I primi a parlarne, negli anni Quaranta, furono Terracini e Gianfranco Contini, entrambi attivi allora fuori d’Italia, e perciò immuni dalla chiusura autarchica vigente lí. Terracini insegnava a Tucumán, in Argentina, dov’era allora esule come ebreo; Contini a Friburgo in Svizzera. Ma per curiose vicende editoriali la prima diffusione di lavori di Spitzer tradotti in italiano è dovuta proprio a Benedetto Croce, ispiratore della casa editrice Laterza, che nel 1954 pubblicò una scelta di scritti di Spitzer tradotti dal tedesco e dall’inglese, a cura dello storico della lingua Alfredo Schiaffini e con il titolo Critica stilistica e storia del linguaggio (poi diventato C. S. e semantica storica, 1966). Vennero in seguito numerose altre scelte di scritti di Spitzer, spesso tematiche (scritti di letteratura francese, o italiana, o spagnola, per esempio)2, sin quando nel 2007 fu tradotta presso il Saggiatore l’importante Italienische Umgangssprache, col titolo Lingua italiana del dialogo, a cura di Claudia Caffi e Cesare Segre.
L’operazione culturale di Croce era molto sottile. I legami di Spitzer con il pensiero idealistico cui anche Croce si richiamava erano innegabili. In piú, si poteva cogliere una linea di sviluppo tra Karl Vossler e Spitzer. Ma Vossler era dichiaratamente vicino a Croce, col quale ebbe fitti scambi d’idee; Spitzer veniva cosí messo al seguito di Croce per la sua parziale dipendenza da Vossler. Croce deve aver pensato che, mettendo l’etichetta di crociano a Spitzer, il suo insegnamento sarebbe risultato meno eversivo. Il disegno di Croce ebbe qualche successo, anche se si deve avvertire subito che Spitzer si sottrasse a questa affiliazione forzata, segnalando un’origine complessivamente diversa del suo pensiero, che in parte attribuiva al suo concittadino Sigmund Freud.
Chi era Leo Spitzer? Nato nel 1887 a Vienna, quando era la grande metropoli austroungarica, fu scolaro di Wilhelm Meyer-Lübke, il massimo linguista romanzo. Nel 1913 ottiene la libera docenza in Filologia romanza. Richiamato alle armi all’inizio della Grande guerra, viene assegnato all’ufficio censura, per un impegno che diventerà ricerca scientifica quando si metterà a studiare il modo in cui i prigionieri di guerra italiani indicano la fame che soffrono nei Lager e non possono nominare per timore della censura. Ne vengono due grossi volumi, su Italienische Kriegsgefangenenbriefe (1921) e Die Umschreibungen («trascrizioni») des Begriffes «Hunger» im Italienischen (1921). Nel 1925 è nominato professore di Filologia romanza a Marburg, in Germania, e nel 1930 a Colonia. Cacciato dalle università tedesche per la persecuzione razziale, ottiene il posto all’università di Istanbul, in Turchia, nel 1933; nel 1936 passa negli Stati Uniti, dove diventa professore nella Johns Hopkins University di Baltimore, e lí resterà sino alla morte, avvenuta nel 1960 a Forte dei Marmi.
La Filologia romanza, fondata nella prima metà dell’Ottocento da Friedrich Diez, aveva concentrato le sue prime ricerche sull’edizione dei testi antichi romanzi (furono allora pubblicati criticamente quasi tutti i principali trovatori) e sulla descrizione linguistica delle lingue romanze, cosí da farne rilevare la profonda unità. Il Meyer-Lübke è appunto autore di un dizionario etimologico delle lingue romanze tuttora fondamentale e di una grammatica delle lingue romanze, in tre volumi, non superata. L’interesse di questi primi filologi per il linguaggio letterario era scarso o nullo. Spitzer, nel 1948, racconta la sua delusione di studente, appassionato di letteratura francese, frequentatore di teatri dove compagnie francesi rappresentano commedie francesi, di fronte al suo maestro che spiega come la a latina tenda, retta da leggi fonetiche inesorabili, verso la e francese (pater è diventato père); dove un sistema di declinazione sorge dal nulla, riducendo a due i sei casi del latino, e piú tardi a uno, ecc. Il Meyer-Lübke, in rapporto a una data forma francese, citava esempi in portoghese antico, bergamasco moderno e macedorumeno, forme tedesche, celtiche e latine arcaiche; «ma dove si rifletteva in tutta questa dottrina il mio francese appassionato, spiritoso, disciplinato, nei suoi presumibili mille anni di esistenza?» Non meno gravi le accuse allo storico letterario Philipp August Becker, tutto preso da problemi di cronologia e di derivazione, ma assolutamente alieno dal domandarsi che cosa renda un’opera opera d’arte, e perché essa sia stata composta. Insomma, Spitzer rinfaccia a questi filologi e linguisti la mancanza di storia, la mancanza di gusto, la mancanza di senso dell’umanità; e soprattutto la mancanza d’interesse letterario.
C’erano tuttavia in seno alla linguistica ricerche piú vicine alle aspirazioni di Spitzer. In Germania, Vossler, professore a Monaco, aveva scritto importanti opere teoriche su Positivismo e Idealismo nella linguistica, sulla vita della lingua, e soprattutto su Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung (1913), tradotta in italiano col titolo Civiltà e lingua di Francia (1948). Vossler studiava la lingua piuttosto come espressione che come comunicazione, ed era attento al lato artistico del linguaggio. Il suo tentativo precoce di studiare i riflessi linguistici diretti della cultura francese nelle fasi del suo sviluppo attirava perciò l’attenzione di Spitzer, che pur ne vedeva i limiti. In un ambito molto diverso, quello dello strutturalismo di Ferdinand de Saussure, Charles Bally, che ne era allievo, aveva fondato una stilistica della lingua (Traité de stylistique française, 1909), studiando le alternative offerte dalla lingua per esprimere con diversità di accentuazione gli stessi concetti. Bally studiava dunque lo stile della collettività, considerando l’assieme dei parlanti come un autore.
A questo punto verrebbe fatto di proporre uno schema, effettivamente abbastanza diffuso, secondo il quale abbiamo da una parte la stilistica della lingua (Bally), dall’altra la stilistica degli scrittori (Spitzer). Invece il primo Spitzer lavora proprio su entrambi i temi, come segnala la bipartizione delle sue Stilstudien (1928) in Sprachstile e Stilsprache, lo stile della lingua e la lingua dello stile, distinzione già di Vossler. Insomma Spitzer indaga sia sull’espressività collettiva, sia su quella individuale, degli scrittori3. Appartengono alla prima serie gli studi sui prigionieri di guerra e sulle metafore della fame, nonché il bellissimo Italienische Umgangssprache4, all’altra il giovanile Die Wortbildung als stilistisches Mittel exemplifiziert an Rabelais (1911), e gli studi ormai classici su Barbusse, Péguy, Romains, Saint-Simon, ecc. Spitzer proponeva come termine comprensivo delle due serie quello di Stilwissenschaft, «scienza dello stile».
Lo sbocco nella stilistica letteraria, e insomma nella critica, è già enunciato nella premessa a Romanische Stil- und Literaturstudien (1931), nella quale comunque Spitzer sottolinea l’ispirazione linguistica e non semplicemente critica (le sue «Textinterpretationen, – dice, – nicht als Selbstzweck betrachte, sondern als einen Weg, das Sensorium zu verfeinern, um die beglückende Vielfalt und Vielfarbigkeit der romanischen Sprachwelt aufnehmen zu können»).
Ma venne dall’esterno la spinta a far convergere la stilistica verso la critica letteraria. Esule sin dal 1936, prima in Turchia, poi negli Usa, Spitzer incontrò i seguenti ostacoli: 1) la necessità di non esprimersi piú in tedesco; 2) la scarsità di sussidi bibliografici (in Turchia); 3) la mancanza di una tradizione filologica nel senso europeo. Per esempio le sue raffinate analisi etimologiche, i suoi riferimenti a tutte le lingue romanze e ai periodi antichi delle letterature, trovavano un ambiente assolutamente sordo. È cosí che Spitzer abbandona i legami con la romanistica tedesca, e si presenta prevalentemente come critico o, semmai, si ricicla come studioso di semantica. Era del resto un periodo di fervore negli Usa, il «new criticism» era oggetto di un dibattito vivo, e Spitzer vi poté entrare, anche grazie all’uso ormai definitivo dell’inglese.
Si deve dunque distinguere tra un periodo austriaco e tedesco di Spitzer, ancora legato alle sue radici di romanista tedesco, e un periodo americano (quello turco fu molto breve), con uno Spitzer prevalentemente critico e americanizzato.
Il principio cui si ispira Spitzer nelle sue analisi stilistiche è enunciato in un suo articolo del 1928 (in Critica stilistica cit., pp. 46-72, a p. 46: «a qualsiasi emozione, ossia a qualsiasi allontanamento dal nostro stato psichico normale, corrisponde, nel campo espressivo, un allontanamento dall’uso linguistico normale; e, viceversa, un allontanamento dal linguaggio usuale è indizio di uno stato psichico inconsueto. Una particolare espressione linguistica è, insomma, il riflesso e lo specchio di una particolare condizione dello spirito»). Ecco allora, per esempio, nel romanziere Charles-Louis Philippe (Bubu de Montparnasse), l’abbondanza di espressioni causali inconsuete, come à cause de l’anniversaire de sa délivrance, oppure à cause de toi, e i molti parce que, car, puisque, che Spitzer chiama «motivazioni pseudo-obiettive», perché lo scrittore motiva come se le ragioni addotte dai suoi personaggi avessero un valore oggettivo. Si prende cosí contatto con la simpatia dello scrittore, piena di umorismo verso questi personaggi mantenuti ai livelli sociali piú bassi dal destino e dai loro errori. Spitzer poi allarga ad altre particolarità e deduzioni (l’uso di on invece di nous), sino a disegnare un «ètimo spirituale» o «radice psicologica» o «forma interna». Negli scritti del pacifista Henri Barbusse, Spitzer nota l’abbondanza di termini relativi a sangue e stupro, tracce dell’ossessione visiva di immagini di massacro. E in una graziosa épître di Voltaire nota l’alternanza di espressioni arcadiche e rococò, riferite a un vestiario che subito cade a colpi di sans, di «senza», lasciando trionfare la bellezza greca di una Fillide.
Due anni dopo la pubblicazione di Critica stilistica di Spitzer, viene tradotto in Italia un volume di Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale (Einaudi). Curiosamente, Auerba...