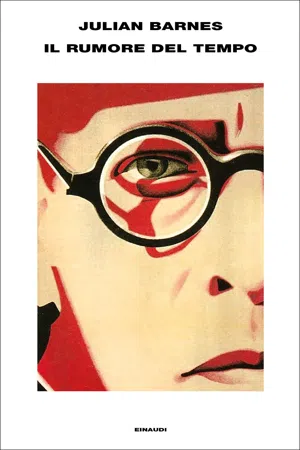![]()
Sapeva solo che quella era la volta peggiore di tutte.
La peggiore, non necessariamente la piú pericolosa. Perché non necessariamente la piú pericolosa è quella in cui si è esposti al massimo pericolo.
Ecco una verità che in passato gli era sfuggita.
Seduto nell’auto con chauffeur, osservava il paesaggio allontanarsi a scossoni alle sue spalle. E intanto si faceva una domanda. Questa:
Lenin trovava la musica deprimente.
Stalin era convinto di capirla e di saperla apprezzare.
Chruščëv la disprezzava.
Che cosa era peggio per un compositore?
Ci sono domande per le quali non esiste risposta. E comunque, la domanda si dissolve quando chi la formula muore. Solo la fossa guarisce la gobba, amava ripetere Chruščëv. Lui gobbo non era nato, ma forse lo era diventato, moralmente, spiritualmente. Un gobbo assillato dalle domande. E forse la morte cura le domande insieme a chi le fa. Cosí che le tragedie, col senno di poi, sembrano farse.
Per l’arrivo di Lenin alla Stazione Finlandia, Dmitrij Dmitrievič era accorso con un gruppo di compagni a salutare il ritorno dell’eroe. Chissà quante volte aveva raccontato quella storia. E tuttavia, essendo stato un bambino cagionevole e molto sorvegliato, è poco probabile che lo si fosse lasciato andare cosí. Piú plausibile invece che ad accompagnarlo alla stazione ci fosse lo zio, il Vecchio Bolscevico Maksim Lavrentjevič Kostrikin. Anche quella versione aveva ripetuto tante volte. Entrambi i racconti davano lustro alle sue credenziali rivoluzionarie. Il piccolo Mitja di soli dieci anni, alla Stazione Finlandia a farsi ispirare dal Grande Condottiero! L’immagine non era stata d’impaccio agli esordi della sua carriera. C’era però una terza possibilità: e cioè che non avesse affatto visto Lenin e che non si fosse mai trovato nelle vicinanze di quella stazione. Poteva avere semplicemente fatto suo il racconto di un compagno spacciandolo per un’esperienza vissuta. Ultimamente, non sapeva piú con certezza a quale versione credere. C’era proprio stato alla Stazione Finlandia? c’era stato veramente? Beh, come dice il proverbio, non c’è peggior bugiardo del testimone oculare.
Si accese un’altra sigaretta proibita e fissò l’orecchio dell’autista. Se non altro era un dettaglio tangibile, reale: l’autista era dotato di un orecchio. E, sebbene non fosse in condizione di vederlo, era certo che ne avesse uno anche dall’altra parte. Quest’ultimo dunque era un orecchio destinato a esistere solo nella sua memoria o, piú precisamente, nella sua immaginazione, fino a quando non avesse potuto tornare a vederlo. Deliberatamente, si sporse di lato finché padiglione e lobo dell’orecchio non comparvero alla vista. Altra domanda che trovava una risposta, per il momento.
Da piccolo, il suo eroe era stato Nansen, l’esploratore artico. Crescendo, la sola presenza della neve sotto un paio di sci lo terrorizzava, e il massimo dell’avventura era per lui affrontare il viaggio fino al paese in cerca di cetrioli, su richiesta di Nita. Adesso che era vecchio, si faceva scarrozzare in giro per Mosca, spesso da Irina, ma a volte da un autista professionale. Era diventato un Nansen delle Periferie.
Sul suo tavolino da notte, sempre: una cartolina del Cristo della moneta di Tiziano.
Secondo Čechov si può scrivere qualunque cosa, tranne un atto d’accusa.
Povero Anatolij Bašaškin. Denunciato come tirapiedi di Tito.
Anna Achmatova diceva che sotto Chruščëv, il Potere era diventato vegetariano. Può darsi, anche se si può benissimo strozzare qualcuno ingozzandolo di ortaggi non meno che utilizzando i metodi tradizionali del passato carnivoro.
Al ritorno da New York aveva composto Il canto delle foreste, su un testo tronfio e magniloquente di Dolmatovskij. Tema dell’oratorio era il rimboschimento delle steppe e la trasformazione di Stalin, da Maestro e Condottiero, Amico dei Fanciulli, Grande Timoniere, Grande Padre della Nazione e Grande Ingegnere Ferroviario, nell’attuale Grande Giardiniere. «Copriamo la Patria di foreste!» – un’esortazione che Dolmatovskij non esitava a ripetere una buona dozzina di volte. Con Stalin, sottolineava l’oratorio, perfino i meli crescevano piú coraggiosi, sbaragliando gli assalti del gelo come l’Armata Rossa aveva fatto con i nazisti. La roboante banalità dell’opera ne aveva garantito l’immediato successo. E contribuí ad assicurare a lui il quarto Premio Stalin: 100 000 rubli e una dacia. Riconoscendo a Cesare il dovuto, Cesare aveva saputo ricambiare con generosa riconoscenza. Complessivamente vinse il Premio Stalin sei volte. E ricevette l’Ordine di Lenin a regolare cadenza decennale: nel 1946, nel 1956 e nel 1966. Nuotava nelle onorificenze come un gamberetto nella salsa aurora. E si augurava di arrivare morto all’appuntamento con il 1976.
Forse il coraggio era come la bellezza. Una bella donna che invecchia vede soltanto ciò che è andato perso; gli altri, quello che rimane. Alcuni si congratularono con lui per la sua indefettibile resistenza, il rifiuto di lasciarsi soggiogare, il nocciolo duro sotto la superficie nevrastenica. Lui vedeva solo quel che non c’era piú.
Lo stesso Stalin non c’era piú da tempo. Il Grande Giardiniere era andato a curare l’erba e a irrobustire i meli dei Campi Elisi.
Le rose rosse sulla tomba di Nita, sparse ovunque. Ogni volta che andava a visitarla. Rose che non aveva mandato lui.
Glikman gli aveva raccontato un aneddoto su Luigi XIV. Il Re Sole era stato un sovrano assoluto, come Stalin. Ma sempre disposto a riconoscere il dovuto agli artisti, ad ammetterne la segreta magia. Uno di essi era il poeta Nicolas Boileau-Despréaux. Ebbene, Luigi XIV, dinanzi all’intera corte di Versailles, aveva annunciato, come se si trattasse di una verità corrente: «Monsieur Despréaux possiede una cognizione della poesia migliore della mia». Senza dubbio si erano levate risa servilmente incredule da coloro che, in privato come in pubblico, si affannavano ad assicurare al grande monarca che la sua cognizione della poesia – come della musica, e della pittura e dell’architettura – non avesse rivali sul pianeta dai tempi dei tempi. E forse il commento conteneva dal principio una sorta di modestia diplomatica. Nondimeno era stato formulato.
Stalin, dal canto suo, poteva vantare tali e tanti vantaggi rispetto al vecchio re. Una profonda padronanza della teoria marxista-leninista, l’intuitiva comprensione del Popolo, l’amore per la musica tradizionale, il fiuto infallibile per le congiure formaliste… Oh, basta, basta. C’era abbastanza da far sanguinare le orecchie.
Ma perfino il Grande Giardiniere, nelle vesti di Grande Musicologo, non era riuscito a scovare il Beethoven Rosso. Davidenko si era rivelato una delusione – già solo morendo ben prima dei quarant’anni. Il Beethoven Rosso, insomma, non comparve mai.
Gli piaceva raccontare la storia di Tinjakov. Un bell’uomo, un bravo poeta. Abitava a Pietroburgo e scriveva d’amore, di fiori e d’altri temi elevati. Poi venne la Rivoluzione, che in breve fece di Tinjakov il poeta di Leningrado che non scriveva piú di amore e fiori, ma della sua orrenda fame. E col passare del tempo le cose si misero male al punto da costringerlo a piazzarsi su un angolo di strada con un cartello al collo che diceva POETA. E siccome i russi tengono in conto i loro poeti, i passanti gli davano qualcosa. Tinjakov amava sostenere di aver guadagnato assai di piú chiedendo l’elemosina che componendo versi, tanto che ogni sera era in grado di rifocillarsi in un buon ristorante.
Sarà stato vero anche l’ultimo dettaglio del racconto, si chiedeva? Del resto, ai poeti è concesso esagerare. Quanto a lui, non aveva bisogno di un cartello – aveva intorno al collo tre Ordini di Lenin e sei Premi Stalin e cenava regolarmente al ristorante dell’Unione dei compositori.
Un uomo bruno dall’aria scaltra, con un rubino pendulo a un orecchio, stringe una moneta fra il pollice e l’indice. La mostra a un altro uomo, piú pallido di carnagione, e questi non la tocca, limitandosi a guardare dritto negli occhi il primo.
C’era stato quel periodo bizzarro nel quale il Potere, avendo stabilito che Dmitrij Dmitrievič era un caso recuperabile, aveva messo in atto una nuova strategia. Anziché aspettare il prodotto finito – una composizione completa che avrebbe poi dovuto passare al vaglio di esperti politico-musicologi per essere definita apprezzabile o condannabile –, il Partito, nella sua saggezza, si portava avanti, giudicandola sin dall’inizio in termini di zelo ideologico. In un gesto di generosa intelligenza l’Unione dei compositori nominò un tutore, il compagno Trošin, sociologo affermato e serio, con l’incarico di aiutare Dmitrij Dmitrievič a chiarirsi i principî del marxismo-leninismo, e a riforgiarsi. Gli fu fatto pervenire un certo numero di volumi tutti rigorosamente opera del compagno Stalin, quali Marxismo e questioni di linguistica e Problemi economici del socialismo in Urss. In un secondo tempo, Trošin si presentò al suo appartamento per spiegargli il proprio ruolo. L’avevano mandato perché perfino i piú illustri compositori, ahimè, andavano soggetti a gravi errori, come era stato ampiamente dimostrato in anni recenti. Onde evitargli la possibilità di ricadere nei medesimi errori, occorreva accrescere il suo livello di competenza politica, economica e ideologica. Il compositore accolse la dichiarazione d’intenti dell’ospite non invitato con la debita gravità, ed espresse il proprio rincrescimento di non essere ancora riuscito a ultimare la lettura di tutti i volumi tanto cortesemente recapitatigli, in quanto impegnato su una nuova sinfonia dedicata alla memoria di Lenin.
Il compagno Trošin passò in rassegna con lo sguardo lo studio del compositore. Non era né un uomo ambiguo né intimidatorio, solo uno dei tanti funzionari diligenti e acritici che ogni regime è in grado di produrre.
– Dunque è qui che lavora.
– Già.
Il tutore si alzò, fece qualche passo in ogni direzione, lodò il generale arredo della stanza. Infine, con un sorriso impacciato, disse:
– Purtroppo manca una cosa, per essere lo studio di un illustre compositore sovietico.
L’illustre compositore sovietico si alzò a sua volta, diede un’occhiata alle librerie e alle pareti che ben conosceva e scosse il capo con aria di imbarazzate scuse, dispiaciuto nel disattendere la prima richiesta del tutore.
– Non c’è il ritratto del compagno Stalin alle pareti.
Seguí un silenzio sgomento. Il compositore si accese una sigaretta e prese a vagare per la stanza come se cercasse di localizzare la causa del suo odioso errore, o come se potesse scovare l’indispensabile icona dietro un cuscino, sotto un tappeto. Infine assicurò Trošin che avrebbe provveduto immediatamente a procurarsi il miglior ritratto in commercio del Grande Condottiero.
– Bene, tutto a posto, – ribatté Trošin. – Mettiamoci al lavoro, allora.
Di quando in quando gli era richiesto di stendere un testo che riassumesse la formidabile saggezza di Stalin. Glikman fu lieto di occuparsene per lui, e dunque le riflessioni patriottiche del compositore riguardo all’opera del Grande Giardiniere gli venivano regolarmente recapitate per posta da Leningrado. Di lí a qualche tempo l’elenco dei testi irrinunciabili fu accresciuto di ulteriori volumi, come I requisiti della creatività nell’arte di G. M. Malenkov, una ristampa del discorso tenuto al XIX Congresso del Partito.
La presenza indefettibile e zelante di Trošin nella sua vita ebbe da parte di Dmitrij Dmitrievič un’accoglienza che mescolava garbata elusività e segreta irrisione. Interpretavano i rispettivi ruoli di istruttore e allievo ostentando espressioni serie: senz’altro Trošin non ne avrebbe avuta un’altra da mettere a disposizione. Credeva con sconcertante indiscutibilità all’intento virtuoso del proprio compito, e il compositore gli riservava un trattamento educato, consapevole che quelle visite indesiderate gli garantivano in fondo una sorta di protezione. Cionondimeno entrambi sapevano che la loro pantomima poteva avere conseguenze anche gravi.
In quel periodo giravano due frasi – una in forma di domanda e l’altra di affermazione – capaci di far cacare sotto e sudare copiosamente anche omoni robusti. La domanda era: «Stalin lo sa?» E l’affermazione, ancor piú allarmante, era: «Stalin lo sa». E giacché a Stalin erano riconosciuti poteri sovrannaturali – non commetteva mai errori, dominava ogni cosa ed era dappertutto –, le semplici creature sublunari sotto il suo potere condividevano la percezione, o la fantasia, di avere il suo sguardo costantemente puntato addosso. Dunque, che succedeva se il compagno Trošin falliva nel veicolare in modo soddisfacente i precetti di Carletto Marx e di tutti i suoi epigoni? Che succedeva se il suo pupillo, all’apparenza compreso dal ruolo ma in cuor suo irriducibile, falliva nell’apprendimento? Che ne era in quei casi dei vari compagni Trošin del mondo? Se il tutore offriva protezione al pupillo, il pupillo aveva a sua volta una certa qual responsabilità nei confronti del tutore.
C’era poi una terza frase fatta che la gente mormorava sul suo conto, come in passato era accaduto con altri, per esempio con Pasternak: «Stalin dice che non lo si deve toccare». La dichiarazione poteva essere una realtà, come pure una teoria campata in aria o un’ipotesi carica di invidia. Come aveva potuto sopravvivere un protégé del traditore Tuchačevskij? Come era sopravvissuto all’affermazione «Questo scherzo può finire molto male»? Come mai era vivo dopo essere stato definito nemico del popolo dagli organi di stampa? Come mai Zakrevskij era scomparso nel nulla tra un sabato e il lunedí successivo? Come mai Dmitrij Dmitrievič era stato risparmiato quando tanti intorno a lui erano stati arrestati, esiliati, assassinati o erano svaniti in una nebbia destinata a diradarsi solo decenni piú tardi? Era una sola la risposta a tutti questi interrogativi: «Stalin dice che non lo si deve toccare».
Se cosí stavano le cose – e non aveva modo di saperlo, non piú di coloro che pronunciavano la frase fatta – sarebbe stato un pazzo a credere che questo gli garantisse protezione a tempo indeterminato. Il solo fatto di essere notato da Stalin costituiva un pericolo di gran lunga maggiore rispetto a un’esistenza di oscuro anonimato. I favoriti di rado conservavano il favore, era solo questione di quando sarebbero caduti. Quanti ingranaggi essenziali della macchina sovietica avevano col tempo rivelato, al minimo mutamento della luce, la propria natura di ostacoli al funzionamento degli altri ingranaggi?
L’auto rallentò a un incrocio, e subito dopo si sentí il clangore del dente d’arresto mentre l’autista tirava il freno a mano. Gli tornò in mente l’acquisto della loro prima Pobeda. Al tempo, il regolamento imponeva che il compratore fosse presente alla consegna della vettura. Avendo ancora una patente rilasciata prima della guerra, si era recato da solo al garage a ritirare l’auto. Lungo il tragitto verso casa, le prestazioni della Pobeda lo avevano lasciato alquanto tiepido, tanto da domandarsi se non gli avessero rifilato una fregatura. Parcheggiò e prese ad armeggiare con la chiave quando udí un passante urlargli: – Ehi, dico a lei, con gli occhiali, che problema ha la sua macchina? – Dalle ruote sboccava fumo: aveva guidato dal garage fino a casa con il freno a mano inserito. La verità è che le macchine non andavano d’accordo con lui.
Ricordava un’altra ragazza che aveva esaminato in veste di professore di Ideologia bolscevica al Conservatorio. L’esaminatore capo si era momentaneamente allontanato dalla stanza lasciandolo unico responsabile della procedura. La studentessa, un fascio di nervi, si torceva tra le mani il foglio delle domande di cui doveva conoscere a memoria le risposte, e lo aveva impietosito.
– Allora, – le disse, – mettiamo da parte tutti i quesiti ufficiali. Le voglio domandare invece: che cosa è il Revisionismo?
Perfino lui avrebbe saputo rispondere. Quello del Revisionismo era un concetto talmente sacrilego e odioso che la parola stessa mostrava le corna del maligno.
La ragazza rifletté un momento prima di rispondere con sicurezza: – Il Revisionismo è il piú alto livello di sviluppo del marxismo-leninismo.
E, con un sorriso, lui le attribuí il massimo dei voti.
Quando tutto il resto veniva meno, quando sembrava non esserci che assurdità nel mondo, allora si aggrappava a questo: che la buona musica sarebbe stata sempre buona, che la grande musica non era violabile. Si potevano suonare i preludi e le fughe di Bach a qualunque tempo e con qualsiasi dinamica: sarebbero rimasti grande musica, baluardo contro gli scalzacani che suonavano con i piedi. E ugualmente refrattaria a qualsiasi cinismo nell’esecuzione.
Nel 1949, mentre imperversavano gli attacchi contro di lui, aveva composto il suo quarto quartetto per archi. Il Quartetto Borodin lo aveva studiato ed eseguito per il Direttivo degli istituti musicali del ministero della Cultura, incaricato di approvare qualunque opera nuova prima che potesse essere eseguita in pubblico, e prima che il compositore potesse ricevere un compenso. Date le condizioni precarie della sua reputazione, Dmitrij Dmitrievič non si poteva considerare fiducioso ma, con sorpresa di tutti, l’audizione fu un successo: il brano venne autorizzato e il compenso elargito. Di lí a breve cominciò a circolare la storia che il Quartetto Borodin avesse imparato a suonare il pezzo in due modi diversi, vale a dire in modo autentico e in modo strategico. Il primo era quello che rispettava le intenzioni dell’autore, mentre il secondo, messo a punto per superare le forche caudine dell’ufficialità, sottolineava gli elementi «ottimistici» del brano e i punti di accordo con le esigenze dell’arte socialista. Il racconto divenne un esempio perfetto dell’uso dell’ironia come arma di difesa contro il Potere.
Non era mai successo, naturalmente, però la storia fu ripetuta abbastanza spesso da renderne accettata la veridicità. Ma erano tutte sciocchezze: non era, e non poteva essere vero, perché in musica non è dato mentire. Il Quartetto Borodin poteva solo eseguire il brano secondo le intenzioni del compositore. La musica, la buona, grande musica, possiede una purezza adamantina, irriducibile. Può essere amara, disperata e pessimistica, ma non...