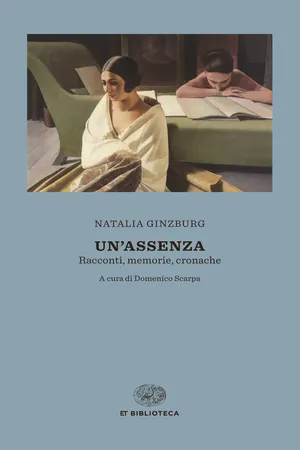![]()
![]()
Gli uomini vanno e vengono per le strade della città.
Comprano cibi e giornali, muovono a imprese diverse.
Hanno roseo il viso, le labbra vivide e piene.
Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso,
Ti chinasti a baciarlo con un gesto consueto.
Ma era l’ultima volta. Era il viso consueto,
Solo un poco piú stanco. E il vestito era quello di sempre.
E le scarpe eran quelle di sempre. E le mani erano quelle
Che spezzavano il pane e versavano il vino.
Oggi ancora nel tempo che passa sollevi il lenzuolo
A guardare il suo viso per l’ultima volta.
Se cammini per strada nessuno ti è accanto.
Se hai paura nessuno ti prende la mano.
E non è tua la strada, non è tua la città.
Non è tua la città illuminata. La città illuminata è degli altri,
Degli uomini che vanno e vengono, comprando cibi e giornali.
Puoi affacciarti un poco alla quieta finestra
E guardare in silenzio il giardino nel buio.
Allora quando piangevi c’era la sua voce serena.
Allora quando ridevi c’era il suo riso sommesso.
Ma il cancello che a sera s’apriva resterà chiuso per sempre;
E deserta è la tua giovinezza, spento il fuoco, vuota la casa.
8 novembre.
Alla memoria di suo marito Leone Ginzburg, morto nelle carceri di Roma il 5 febbraio 1944, ucciso dalla ferocia della Gestapo, Natalia Ginzburg dedica questa poesia. Natalia Ginzburg, nota nel mondo letterario col nome di Alessandra Tornimparte, riprende il suo vero nome che dovette abbandonare, per ragioni razziali, nel periodo dell’oppressione fascista.
![]()
Deus nobis haec otia fecit.
In Abruzzo non c’è che due stagioni: l’estate e l’inverno. La primavera è nevosa e ventosa come l’inverno e l’autunno è caldo e limpido come l’estate. L’estate comincia in giugno e finisce in novembre. I lunghi giorni soleggiati sulle colline basse e riarse, la gialla polvere della strada e la dissenteria dei bambini, finiscono e comincia l’inverno. La gente allora cessa di vivere per le strade: i ragazzi scalzi scompaiono dalle scalinate della chiesa. Nel paese di cui parlo, quasi tutti gli uomini scomparivano dopo gli ultimi raccolti: andavano a lavorare a Terni, a Sulmona, a Roma. Quello era un paese di muratori: e alcune case erano costruite con grazia, avevano terrazze e colonnine come piccole ville, e stupiva di trovarci, all’entrare, grandi cucine buie coi prosciutti appesi e vaste camere squallide e vuote. Nelle cucine il fuoco era acceso e c’erano varie specie di fuochi, c’erano grandi fuochi con ceppi di quercia, fuochi di frasche e foglie, fuochi di sterpi raccattati ad uno ad uno per via. Era facile individuare i poveri e i ricchi, guardando il fuoco acceso, meglio di quel che si potesse fare guardando le case e la gente, i vestiti e le scarpe, che in tutti su per giú erano uguali.
Quando venni al paese di cui parlo, nei primi tempi tutti i volti mi parevano uguali, tutte le donne si rassomigliavano, ricche e povere, giovani e vecchie. Quasi tutte avevano la bocca sdentata: laggiú le donne perdono i denti a trent’anni, per le fatiche e il nutrimento cattivo, per gli strapazzi dei parti e degli allattamenti che si susseguono senza tregua. Ma poi a poco a poco cominciai a distinguere Vincenzina da Secondina, Annunziata da Addolorata, e cominciai a entrare in ogni casa e a scaldarmi a quei loro fuochi diversi.
Quando la prima neve cominciava a cadere, una lenta tristezza s’impadroniva di noi. Era un esilio il nostro: la nostra città era lontana e lontani erano i libri, gli amici, le vicende varie e mutevoli di una vera esistenza. Accendevamo la nostra stufa verde, col lungo tubo che attraversava il soffitto: ci si riuniva tutti nella stanza dove c’era la stufa, e lí si cucinava e si mangiava, mio marito scriveva al grande tavolo ovale, i bambini cospargevano di giocattoli il pavimento. Sul soffitto della stanza era dipinta un’aquila: e io guardavo l’aquila e pensavo che quello era l’esilio. L’esilio era l’aquila, era la stufa verde che ronzava, era la vasta e silenziosa campagna e l’immobile neve. Alle cinque suonavano le campane della chiesa di Santa Maria, e le donne andavano alla benedizione, coi loro scialli neri e il viso rosso. Tutte le sere mio marito ed io facevamo una passeggiata: tutte le sere camminavamo a braccetto, immergendo i piedi nella neve. Le case che costeggiavano la strada erano abitate da gente cognita e amica: e tutti uscivano sulla porta e ci dicevano: «Con una buona salute». Qualcuno a volte domandava: «Ma quando ci ritornate alle case vostre?» Mio marito diceva: «Quando sarà finita la guerra». «E quando finirà questa guerra? Te che sai tutto e sei un professore, quando finirà?» Mio marito lo chiamavano «il professore» non sapendo pronunciare il suo nome, e venivano da lontano a consultarlo sulle cose piú varie, sulla stagione migliore per togliersi i denti, sui sussidi che dava il municipio e sulle tasse e le imposte.
D’inverno qualche vecchio se ne andava con una polmonite, le campane di Santa Maria suonavano a morto, e Domenico Orecchia, il falegname, fabbricava la cassa. Una donna impazzí e la portarono al manicomio di Collemaggio, e il paese ne parlò per un pezzo. Era una donna giovane e pulita, la piú pulita di tutto il paese: dissero che le era successo per la gran pulizia. A Gigetto di Calcedonio nacquero due gemelle, con due gemelli maschi che aveva già in casa, e fece una chiassata in municipio perché non volevano dargli il sussidio, dato che aveva tante coppe di terra e un orto grande come sette città. A Rosa, la bidella della scuola, una vicina gli sputò dentro l’occhio, e lei girava con l’occhio bendato perché le pagassero l’indennità. «L’occhio è delicato, lo sputo è salato», spiegava. E anche di questo si parlò per un pezzo, finché non ci fu piú niente da dire.
La nostalgia cresceva in noi ogni giorno. Qualche volta era perfino piacevole, come una compagnia tenera e leggermente inebriante. Arrivavano lettere dalla nostra città, con notizie di nozze e di morti dalle quali eravamo esclusi. A volte la nostalgia si faceva acuta ed amara, e diventava odio: noi odiavamo allora Domenico Orecchia, Gigetto di Calcedonio, Annunziatina, le campane di Santa Maria. Ma era un odio che tenevamo celato, riconoscendolo ingiusto: e la nostra casa era sempre piena di gente, chi veniva a chieder favori e chi veniva a offrirne. A volte la sartoretta veniva a farci le sagnoccole. Si cingeva uno strofinaccio alla vita e sbatteva le uova, e mandava Crocetta in giro per il paese a cercare chi potesse prestarci un paiolo ben grande. Il suo viso rosso era assorto e i suoi occhi splendevano di una volontà imperiosa. Avrebbe messo a fuoco la casa perché le sue sagnoccole riuscissero bene. Il suo vestito e i capelli si facevano bianchi di farina, e sul tavolo ovale dove mio marito scriveva, venivano adagiate le sagnoccole.
Crocetta era la nostra donna di servizio. Veramente non era una donna perché aveva quattordici anni. Era stata la sartoretta a trovarcela. La sartoretta divideva il mondo in due squadre: quelli che si pettinano e quelli che non si pettinano. Da quelli che non si pettinano bisogna guardarsi, perché naturalmente hanno i pidocchi. Crocetta si pettinava: e perciò venne da noi a servizio, e raccontava ai bambini delle lunghe storie di morti e di cimiteri. C’era una volta un bambino che gli morí la madre. Suo padre si pigliò un’altra moglie e la matrigna non amava il bambino. Perciò lo uccise mentre il padre era ai campi e ci fece il bollito. Il padre torna a casa e mangia, ma dopo che ha mangiato le ossa rimaste nel piatto si mettono a cantare:
E la mia trista matrea
Mi ci ha cotto in caldarea
E lo mio padre ghiottò
Mi ci ha fatto ’nu bravo boccò.
Allora il padre uccide la moglie con la falce, e l’appende a un chiodo davanti alla porta. A volte mi sorprendo a mormorare le parole di questa canzone, e allora tutto il paese mi ritorna davanti, insieme al particolare sapore di quelle stagioni, insieme al soffio gelato del vento e al suono delle campane.
Ogni mattina uscivo con i miei bambini e la gente si stupiva e disapprovava che io li esponessi al freddo e alla neve. «Che peccato hanno fatto queste creature? – dicevano. – Non è tempo di passeggiare, signò. Torna a casa». Camminavamo a lungo per la campagna bianca e deserta, e le rare persone che incontravo guardavano i bambini con pietà. «Che peccato hanno fatto?» mi dicevano. Laggiú se nasce un bambino nell’inverno, non lo portano fuori dalla stanza fino a quando non sia venuta l’estate. A mezzogiorno mio marito mi raggiungeva con la posta, e tornavamo tutti insieme a casa.
Io parlavo ai bambini della nostra città. Erano molto piccoli quando l’avevamo lasciata, e non ne avevano nessun ricordo. Io dicevo loro che là le case avevano molti piani, c’erano tante case e tante strade, e tanti bei negozi. «Ma anche qui c’è Girò», dicevano i bambini.
La bottega di Girò era proprio davanti a casa nostra. Girò se ne stava sulla porta come un vecchio gufo, e i suoi occhi rotondi e indifferenti fissavano la strada. Vendeva un po’ di tutto: generi alimentari e candele, cartoline, scarpe e aranci. Quando arrivava la roba e Girò scaricava le casse, i ragazzi correvano a mangiare gli aranci marci che buttava via. A Natale arrivava anche il torrone, i liquori, le caramelle. Ma lui non cedeva un soldo sul prezzo. «Quanto sei cattivo, Girò», gli dicevan le donne. Rispondeva: «Chi è buono se lo mangiano i cani». A Natale tornavano gli uomini da Terni, da Sulmona, da Roma, stavano alcuni giorni e ripartivano, dopo aver scannato i maiali. Per alcuni giorni non si mangiava che sfrizzoli, salsicce pazze e non si faceva che bere: poi le grida dei nuovi maialetti riempivano la strada.
In febbraio l’aria si faceva umida e molle. Nuvole grige e cariche vagavano per il cielo. Ci fu un anno che durante lo sgelo si ruppero le grondaie. Allora cominciò a piovere in casa e le stanze erano dei veri pantani. Ma fu cosí per tutto il paese: non una sola casa restò asciutta. Le donne vuotavano i secchi dalle finestre e scopavano via l’acqua dalla porta. C’era chi andava a letto con l’ombrello aperto. Domenico Orecchia diceva che era il castigo di qualche peccato. Questo durò piú d’una settimana: poi finalmente ogni traccia di neve scomparve dai tetti, e Aristide aggiustò le grondaie.
La fine dell’inverno svegliava in noi come un’irrequietudine. Forse qualcuno sarebbe venuto a trovarci: forse sarebbe finalmente accaduto qualcosa. Il nostro esilio doveva pur avere una fine. Le vie che ci dividevano dal mondo parevano piú brevi: la posta arrivava piú spesso. Tutti i nostri geloni guarivano lentamente.
C’è una certa monotona uniformità nei destini degli uomini. Le nostre esistenze si svolgono secondo leggi antiche ed immutabili, secondo una loro cadenza uniforme ed antica. I sogni non si avverano mai e non appena li vediamo spezzati, comprendiamo a un tratto che le gioie maggiori della nostra vita sono fuori della realtà. Non appena li vediamo spezzati, ci struggiamo di nostalgia per il tempo che fervevano in noi. La nostra sorte trascorre in questa vicenda di speranze e di nostalgie.
Mio marito morí a Roma nelle carceri di Regina Coeli, pochi mesi dopo che avevamo lasciato il paese. Davanti all’orrore della sua morte solitaria, davanti alle angosciose alternative che precedettero la sua morte, io mi chiedo se questo è accaduto a noi, a noi che compravamo gli aranci da Girò e andavamo a passeggio nella neve. Allora io avevo fede in un avvenire facile e lieto, ricco di desideri appagati, di esperienze e di comuni imprese. Ma era quello il tempo migliore della mia vita e solo adesso che m’è sfuggito per sempre, solo adesso lo so.
![]()
Ho vissuto per tre anni in un paese dell’Italia del Sud. Per tre anni ho veduto tramontare il sole sulle colline tondeggianti e spoglie, per tre anni ho veduto mietere il grano, per tre anni ho mangiato il pane bianco e insapore, impastato con le patate, che fanno laggiú.
Il paese era diviso in due dalla strada. Da un lato c’era la pineta e il castello, vigneti e campi, e piú in alto la linea sinuosa delle brulle colline. Dall’altro lato c’erano gli orti, i larghi pascoli e il fiume. Il fiume era povero d’acque, ma un uomo una volta riuscí ad affogarci. Non so come abbia fatto.
Il castello apparteneva a un marchese che era andato in America. Si diceva che avesse una ventina di stanze, quattro bagni e delle seggiole d’oro. Tutti si ricordavano il marchese con i suoi capelli neri dalla ciocca bianca; tutti ricordavano il tempo che andava a caccia con i cani. C’era un uomo in paese che gli aveva fatto da ruffiano. Adesso i cani li teneva lui. I cavalli del marchese invece li teneva il fornaio, e li portava a bere alla fontana due volte nella giornata. Erano bei cavalli muscolosi, di un color biondo, con la coda bianca.
Il paese era formato da due specie di persone: i borghesi e i contadini. Borghesi erano il brigadiere, il segretario comunale, il dottore e il veterinario. È difficile descrivere il tenore di vita, la forma mentale e morale d’una borghesia in un paese di tremila abitanti. E tuttavia mi sembra che la cosa meriterebbe studio e interesse. Questa gente aveva poco da fare e passava la maggior parte del tempo a scrivere lettere anonime alla questura del capoluogo, denunciandosi scambievolmente. Ho dimenticato di dire che della borghesia faceva parte anche il ruffiano del marchese, un uomo rosso in faccia, col ciuffo sulla fronte. Era il padrone di una autopubblica ed era l’autore piú attivo di lettere anonime.
Il dottore era un vecchio zoppo che puzzava di sigaro. D’inverno portava un pastrano bordato di castorino; d’estate una leggera giacchetta di cascame di seta e un cappello di paglia. I suoi occhi neri e pungenti parevano capocchie di spillo. Da giovane era stato una persona raffinata e colta: gli piacevano i libri e la musica e aveva scritto e pubblicato dei versi. «Ma a vivere in mezzo ai cafoni mi sono perso di coraggio – diceva – mi son perso di coraggio». Qualcuno diceva che da giovane era stato anche un medico bravo. Ma il fatto era questo, che i cafoni lui li detestava e non desiderava che guarissero quando erano malati. Se una donna gli portava a vedere un bambino malato, diceva: «Saranno i vermi, come dite voi», e spingeva in fretta la donna alla porta intascando dieci lire e tre uova. Quando andava in cucina la moglie gli chiedeva: «Hai fetato?» Lui metteva le uova sulla tavola e sedeva a pranzo in silenzio.
La moglie lui la detestava e non le rivolgeva mai la parola. Era una donna che aveva ormai sessant’anni, ma pareva molto piú giovane, e ogni mattina si radeva la barba che le cresceva sulle guance piene e bianche, e quando se ne andava ancheggiando per le vie del piccolo paese, col suo soprabito di seta nera, col viso incipriato e gli occhi verdi e splendenti, ognuno ricordava il tempo che era stata l’amante del marchese e si mangiava i tordi e le pernici che lui prendeva a caccia. Il dottore lo chiamavano «becco cornuto», anche adesso, dopo tanti anni.
Il dottore, quando venivano a chiamarlo di notte, s’arrabbiava e rifiutava d’alzarsi, ma se uno andava a lamentarsi del dottore in giro, la moglie subito lo denunciava per sentimenti antifascisti con una lettera anonima.
Ma la sola passione del dottore erano i parti, quando venivano a chiamarlo per un parto difficile era tutto contento, e si alzava magari anche di notte. Cosí se invece di chiamar lui, chiamavano l’ostetrico della città, gli facevano un’offesa atroce, e la moglie scriveva subito una lettera anonima. Di donne che morivano di parto ce n’erano tante, ma il dottore diceva che era colpa loro per il gran sudiciume che avevano, che non volevano sentir ragione, e al dottore non gli davano retta.
Nelle belle sere d’estate, mentre il sole tramontava sulle colline e le pecore tornavano dal pascolo sollevando una nuvola di polvere, mentre il barbiere suonava la chitarra sulla porta della sua bottega con una frotta di ragazzi scalzi intorno, il dottore, il veterinario e il brigadiere passeggiavano lentamente lungo la strada. A vederli cosí parevano buoni amici, e nessuno avrebbe pensato che passavano il tempo ad accusarsi l’uno con l’altro in questura, di sentimenti antifascisti, di truffe annonarie, di sevizie, di ogni sorta di cose. Camminavano lentamente, parlando: parlavano del tempo che abitavano altrove, in città, parlavano della gioia di abitare in città e del disgusto che provavano a vivere in mezzo ai cafoni. Ma in realtà essi non avrebbero piú potuto avvezzarsi a vivere altrove, non avrebbero piú potuto rinunciare ai cafoni e all’ebrezza del potere. Il brigadiere, alto, pallido, col suo grande mantello svolazzante, il veterinario con i calzoni a sbuffo e i denti guasti, e il dottore appoggiato al suo bastone avevano nelle loro mani le sorti del paese e lo sapevano bene. Camminavano interminabilmente fino a buio lungo tutto il paese, assaporando la propria grande potenza e il timore che li circondava. Il brigadiere aiutava i contadini ricchi ad imboscarsi e riceveva in dono prosciutti e farina. Quintali di farina venivano scaricati di notte sulla porta della caserma, e il ruffiano del marchese stava affacciato alla sua finestra a guardare e scriveva lettere anonime.
Queste lettere anonime non avevano alcun risultato, probabilmente venivano cestinate senza essere lette, ma ognuno ne aveva un sacro terrore e l’incubo oscuro ne pesava su tutto il paese. Soltanto i poveri non avevano paura delle lettere anonime, e vivevano una vita loro, fuori d’ogni intrigo, badando ai quattro cavoli piantati davanti a casa e badando a rubare legna nella pineta senza esser visti dal milite forestale. Il giorno che li chiamavano in guerra ci andavano e crepavano lontano, e quelli che restavano a casa, il dottore non veniva a vederli quando erano malati, dato che non avevano galline. D’estate la dissenteria si portava via sempre sei o sette bambini, e un anno che al dottore gli portarono un bambino con la tosse convulsa, lui disse che non era tosse convulsa e lo mandassero pure a scuola, e tutti i bambini in paese si pigliarono la tosse convulsa.
Un tempo, molti anni prima, i poveri avevano un sussidio dal comune, ma adesso questo sussidio nessuno lo vedeva piú da un bel pezzo, e in realtà se lo mettevano in tasca il segretario comunale e il podestà. Il podestà non era un borghese, era soltanto un contadino ricco con vacche e maiali, ed era anche una persona per bene prima che lo facessero podestà. Il brigadiere e il veterinario l’avevano voluto apposta un podestà che poco sapeva scrivere e non dava disturbo, e in comune ci andava di rado e badava a zapparsi le patate.
Ma poi a fare il podestà ci aveva preso gusto, e anche lui aveva messo un po’ d’importanza, e anche lui aveva imparato a truffare con la farina, a vedere come rubavano gli altri, che era una smania che prendeva ciascuno. Cosí s’era arricchito ancora peggio e i suoi maiali facevano invidia, e a vederli c’era chi diceva: «Tutta la crusca di assegnazione se la mangiano i porchi dello podestà».
Ma la moglie del veterinario una sera mandò la serva a rubare l’insalata nell’orto del podestà, e la moglie del podestà se ne accorse e fecero una chiassata, e allora il veterinario andò di persona alla Questura a dire che il podestà sapeva appena scrivere, e passava i suoi giorni a pascolar le vacche, che non era nemmeno dignitoso per chi lo vedeva; e il nuovo podestà fu allora il ruffiano del marchese, che almeno aveva un’autopubblica e si vestiva come un signore.
Ma i veri abitanti del paese erano i contadini, i cafoni come li chiamava il dottore, e a loro non importava davvero chi fosse il podestà, perché tanto tutti rubavano, e i podestà sono fatti per questo. A loro importava soltanto dei pochi stracci che avevano addosso, e di quei quattro cavoli nell’orto, e della pioggia e del sole: il dottore diceva sempre che erano ignoranti e sporchi, e che per questo morivano tanti bambini, ma loro invece pensavano che non era vero, e che i bambini morivano perché non c’era un dottore bravo. Ogni volta che si trovavano col dottore o col brigadiere, si mettevano subito a parlare della miseria che avevano a casa, ma era solo una vecchia abitudine e in verità non erano scontenti, perché non sospettavano neppure che si potesse vivere in un altro modo, e al freddo ci s’erano avvezzati, alla fame ci s’erano avvezzati, e am...