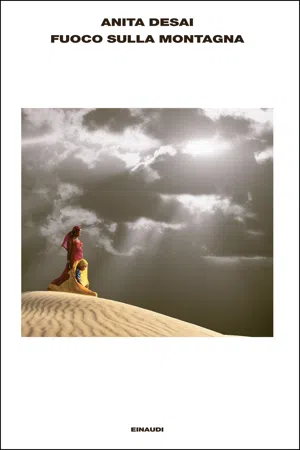![]()
![]()
Raka... un nome veramente poco appropriato, pensò Nanda Kaul, dritta all’ombra degli albicocchi con le mani congiunte sul petto, guardando la bambina varcare il cancello mentre i pini mossi dal vento s’inchinavano ondeggiando bizzarramente come se mimassero il benvenuto in un balletto satirico moderno.
Raka significa luna, ma il viso della bambina era tutt’altro che rotondo, calmo e radioso. Seguiva Ram Lal su per il vialetto strascicando i piedi, con una borsa a tracolla che le faceva inclinare la spalla magra e i piedi infilati in vecchi sandali coperti di polvere. Nanda Kaul pensò che sembrava uno di quei grilli scuri che saltellano spaventati senza cantare, o una zanzara minuta e sottile, su gambe magre e incerte.
Tuttavia la chiamò: – Raka, – sperando in qualche modo di collegare quel nome alla bambina e domandandosi se si sarebbe mai abituata a vedere quell’estranea nel proprio giardino.
Raka trattenne il passo, quindi venne verso la bisnonna senza dir nulla. C’era una sorta di disperazione nel suo atteggiamento, succhiava l’elastico allentato di un logoro cappello, di sghimbescio sui capelli cortissimi, che faceva pensare a una borsa di paglia. Girò un paio d’occhi straordinariamente grandi e leggermente sporgenti inducendo la vecchia signora a paragonarla piú che mai a un insetto.
Guardandosi intorno con quegli occhi, Raka osservò Ram Lal che saliva i gradini della veranda con la sua valigia, le scarpe da tennis troppo grandi che alternativamente squittivano e sciabattavano sul pavimento di pietra. Voltandosi un po’, scorse una gallina dal collo scheletrico che becchettava frammenti di porcellana bianca sotto un cespuglio di ortensie celesti.
Allora sollevò la testolina tosata sul collo sottilissimo e delicato e guardò gli albicocchi, la veranda, Carignano. Con quelle sue orecchie a sventola miseramente grandi, ascoltò il vento tra i pini e il frinire incessante delle cicale sotto il sole pensando che non aveva mai ascoltato prima la voce del silenzio.
Poi non fu piú possibile dilazionare l’incontro ed entrambe si mossero in direzione dell’altra e si abbracciarono perché pensavano di doverlo fare. Si udí un rumore di ossa che si urtano. Tutte due pensarono a quanto l’altra era ossuta, spigolosa e poco accomodante e si separarono rapidamente.
– Bambina mia, sei stata cosí malata! – esclamò involontariamente Nanda Kaul, indugiando un istante sullo scudo duro della spalla ossuta. – Cosí malata. Sei cosí magra.
Raka, a disagio, tirò l’elastico allentato e roteò gli occhi per seguire il volo di un’upupa che si era levata da un albero. La vecchia signora che le aveva sussurrato quelle parole sembrava anche lei un pino, e il suo sari grigio una roccia, tutti elementi della nuda immobilità del giardino di Carignano.
Per Nanda Kaul la bambina restava un’intrusa, un’estranea, una zanzara volata fin lí dalla pianura per disturbarla e tormentarla. Con palese mancanza di calore, sospirò: – Be’, sarà meglio che entriamo, – e lungo le malferme lastre di pietra della veranda la condusse nella sua camera.
![]()
Lasciata a se stessa, nel pomeriggio Raka familiarizzò con la stanza a piedi nudi. Si aggirava come fanno gli animali selvatici appena intrappolati, appena addomesticati, scivolando da una parete all’altra su zampe silenziose, indagatrici. Sfiorava uno spigolo di legno qui, una bordura di stucco là. Vide un ragno che si lisciava la peluria in un angolo, incontrò gli occhi di una lucertola ammiccanti da una fessura buia. Verificò lo spessore della polvere su scaffali e ripiani, diede una leccatina a un vetro per rinfrescarsi la punta della lingua. Si stese sul letto a pancia in giú, con la testa che penzolava dalla sponda, ma il sole le si insinuava negli occhi come un cuneo giallo, impedendole di chiuderli. L’attirò alla finestra, la trascinò lungo il percorso di un raggio fino al davanzale e lei appoggiò il capo su quella confortevole ghigliottina.
Sotto la finestra vide un cumulo di pietre, qualche fiore privo di interesse, un guscio di lumaca abbandonato. Non granché.
Ma qualche metro piú in là, sotto lo sgangherato parapetto di legno, la cengia s’interrompeva e all’improvviso si apriva il burrone rosso disseminato di rocce che precipitava fino alla vasta, densa pianura, che faceva pensare alla pelle polverosa di un animale ansante sotto il sole. Raka socchiuse gli occhi. La conosceva... quella pianura, quella pelle, quella polvere estiva gialla.
Scavalcò il davanzale della finestra, atterrò in un’aiuola di emerocallidi e andò silenziosamente ad affacciarsi al parapetto. Sapeva che la finestra della bisnonna aveva lo stesso affaccio. Avanzò con cautela per non far scricchiolare la ghiaia. Accucciata accanto al parapetto, esaminò i dettagli che davano perimetri, angoli e interesse a quella scena caliginosa.
Cumuli di lattine arrugginite, fasci di giornali sporchi, bucce, stracci e ossa compressi nelle scanalature, nelle cavità, nei crepacci, da cui talora straripavano. Pini dai tronchi bruciacchiati e i rami contorti assumevano posture drammatiche, da palcoscenico. C’erano massi bloccati a metà del pendio, svettanti, o pronti a precipitare. Qui e là, tetti di lamiera luccicanti.
Seguendo con lo sguardo la cengia frastagliata, Raka notò che lungo il bordo si allineavano muri posteriori e alloggi della servitú, baracche di lamiera e cucine da campo. Sulla curva i fabbricati si facevano piú possenti e si gonfiavano negli enormi muri di cemento di quella che sembrava una fabbrica, sottili ciminiere lanciavano infatti guanciali e nastri di fumo nero nell’azzurro lattiginoso del cielo pomeridiano. Dal muro posteriore uscivano dei piani inclinati che parevano fatti per scaricare nel burrone i rifiuti della fabbrica e immediatamente sotto c’erano piccoli edifici bassi che sembravano fornaci di mattoni tra le foglie acuminate e curve delle agavi giganti, la sola vegetazione, oltre ai pini, di quella gola deturpata.
Raka girò la testa sul suo stelo, perplessa. Suo padre e la nonna avevano lodato le bellezze e i piaceri di un luogo di villeggiatura sull’Himalaya, ma non avevano fatto parola di fabbriche. Invece lí ce n’era una cosí enorme che Raka non capiva come la si potesse ignorare. Le sembrava piuttosto che dominasse il paesaggio, un drago quadrato, inscatolato, murato e alimentato.
Come una lucertola, tenendosi stretta al parapetto, scivolò per tutta la sua lunghezza fino alla cucina esterna per vedere se Ram Lal era lí e se poteva illuminarla. Ma era vuota, un antro nero di fuliggine in cui brillava e rosseggiava un fiero occhio infiammato. Una gallina bianca che si era intrufolata di soppiatto in cucina, vedendo ondeggiare il suo abito bianco emise un verso roco e le sfrecciò accanto facendola ritrarre per la sorpresa.
Nello stanzino attiguo, ancora piú piccolo ma in qualche modo rischiarato da innumerevoli immagini ritagliate da riviste e calendari e appese alle pareti, Ram Lal giaceva su una branda, mani e piedi penzolanti ai quattro angoli, il berretto sul naso che si sollevava e abbassava al ritmo dei suoi potenti grugniti e sbuffi improvvisi.
Lasciandolo dov’era, Raka si scostò dalle pareti della cucina per arrampicarsi sulla collinetta aggrappandosi alle felci ruvide e alle rocce sporgenti, fin sulla sommità dove i pini crescevano in cerchio tra le rocce. Soffiava una brezza fresca, asciutta e resinosa.
Raka si addossò a un tronco con la corteccia spessa e bruciacchiata come pane abbrustolito, ne sentiva la superficie rugosa strofinandoci contro le scapole. Piú in basso, sull’altro versante del colle, si vedeva, all’ombra di una deodara gigante, il tetto verde di un vasto edificio basso con vivaci gerani nelle verande e tende di mussola bianca che le finestre alternativamente aspiravano ed espiravano, e sull’altro lato della strada campi da tennis appena spazzati e con le linee tracciate di fresco, deserti, in attesa. Doveva essere il club di cui le aveva parlato la nonna, ma in quel momento sembrava addormentato. Pareva che tutta Kasauli dormisse, tranne le cicale che frinivano senza interruzione. In cielo, enormi avvoltoi volavano in cerchio oziosi e furtivi, galleggiando sulle correnti in cerca di preda.
Raka si accucciò su un masso piatto ai piedi dell’albero. Poggiando i piccoli nodi della spina dorsale contro l’albero, passò in rassegna Sanawar adagiata nell’ombra densa della vegetazione, poi Dagshai e Sabathu, manciate di pietruzze lucenti sulle cime dorate dei colli. Un grillo accanto a lei ruppe raucamente il silenzio e lei passò il resto del pomeriggio sollevando le pietre per cercarlo.
![]()
Quando infine udí Ram Lal che rumoreggiava in cucina preparando il tè – quel tintinnio incerto annunciava l’imminenza del tè, non di pasti piú sostanziosi – Raka lasciò la collinetta e andò a interrogarlo sulla fabbrica.
Mentre disponeva le tazze su un vecchio vassoio di noce, attizzava il fuoco e disperdeva nuvole di fumo con un logoro canovaccio da cucina, Ram Lal raccontava.
– È l’Istituto Pasteur. Dove i dottori preparano il siero per le vaccinazioni. Quando qualcuno viene morsicato da un cane rabbioso, lo portano lí a fare le iniezioni... quattordici, nella pancia. Le ho fatte anch’io. Una volta hanno radunato e portato lí un intero villaggio... un cane si era preso la rabbia e aveva morsicato tutti gli abitanti. Dovettero ammazzarlo. Gli tagliarono la testa e la spedirono all’istituto. I dottori le aprono e ci guardano dentro. Hanno anche conigli e cavie, laggiú, molti animali. Li usano per gli esperimenti.
S’interruppe per versare nella teiera l’acqua di un grosso bollitore nero e Raka osservò il getto sibilante puntellandosi al bordo del tavolo con le unghie.
– Perché c’è tanto fumo? – domandò con voce flebile.
– Oh, bollono il siero in continuazione, là dentro... bollono, bollono. Fanno il siero per tutta l’India.
Uscendo con il vassoio in equilibrio sul palmo di una mano, da vero professionista, sostò accanto alla ringhiera e indicò col capo i muri di cemento dell’istituto che avevano turbato Raka per via della loro mole incongrua e minacciosa in quel contesto. – Vedi quegli scivoli? Svuotano nel burrone le ossa e le ceneri degli animali morti. È un brutto posto. Tieniti lontana.
– Perché?
– Perché di notte gli sciacalli vengono a rosicchiare le ossa. Poi si prendono la rabbia e mordono i cani del villaggio. I cani rabbiosi vanno in giro a mordere la gente. Stai lontana da lí, capito? Specialmente di notte. Di notte si sentono ululare gli sciacalli e qualcuno ha visto dei fantasmi... – abbassò la voce. – I fantasmi delle persone uccise dai morsi dei cani e dei serpenti vagano sulle pendici dei colli. È pericoloso, capito?
Raka strinse la labbra pallide e annuí. Poi lo seguí nella veranda dove Ram Lal depositò il vassoio, e sedette rigida e immobile mentre la bisnonna le versava una tazza di latte con dentro un goccio di tè.
Porgendole la tazza, Nanda Kaul strinse gli occhi e disse: – Come sei pallida, bambina mia. Non hai riposato neanche un po’?
Raka si chinò sulla tazza e se l’avvicinò alla bocca. Che la bisnonna interpretasse quel gesto come voleva.
Dopo che ebbero vuotato le tazze, Nanda Kaul formulò tra sé la domanda «Come occuperai il tuo tempo, Raka?» avendo notato che la bambina fremeva silenziosamente sul piccolo sgabello, fremeva come se fosse fatta di migliaia di zanzare nere, un agglomerato ronzante d’insetti, incerta se contenere o dar sfogo a quell’atroce fermento.
Decise di non dir nulla. Non voleva farsi di nuovo coinvolgere in un mondo infantile: reale o immaginario che fosse, l’avrebbe tradita. Sospirando sotto il peso del proprio destino, si versò un’altra tazza di tè nero bollente e mormorò: – Che caldo! Troppo caldo. Ti piacerebbe fare una passeggiata o è troppo caldo? – Che provvedesse da sola a contenere o sfogare l’irrequietezza, pensò Nanda Kaul bevendo un’ultima sorsata amara.
![]()
Nanda Kaul non scoprí mai ciò che Raka faceva di se stessa. Scoprí solo che la bambina aveva un talento per scomparire, all’improvviso, silenziosamente. Se ne andava, punto e basta, e non tornava per ore.
Di tanto in tanto l’intravedeva mentre si arrampicava su un pendio roccioso aggrappandosi ai ciuffi d’erba o alle ginestre, le mutandine bianche bene in vista mentre puntava disperatamente i calcagni nel terreno. O mentre vagava sul sentiero con quieta noncuranza, fermandosi a spogliare un cespuglio spinoso delle sue poche bacche o a esaminare un insetto sotto una foglia. Poi girava intorno a un masso o saltava dall’orlo di una roccia e si dileguava.
Tornava con le gambe scure coperte di graffi, le ginocchia sbucciate, succhiandosi un dito punto dalle ortiche, uno strato di polvere sulla zazzera bruna, gli occhi fissi e pensosi come se avesse visitato strani paesi e visto cose fantastiche, inverosimili, che indugiavano tuttora nella sua mente.
Era contrario ai metodi della vecchia signora farle domande, tuttavia era terribilmente infastidita di ritrovarsi per l’ennesima volta nei panni di chi è costretto a interessarsi delle azioni altrui ed essere responsabile delle loro conseguenze e dei loro risultati.
Non sarebbe mai finita?
Scrisse una lettera ad Asha con la sua grafia slanciata e molto uniforme, inchiostro verde su grandi fogli di carta bianca, informandola concisamente che Raka era arrivata bene, ma senza dir nulla che lasciasse trapelare il suo risentimento e rammarico.
Mentre piegava il foglio e lo infilava in una grande busta, strinse le labbra e decise di mettere in chiaro con Raka – lei se non altro aveva capito che Raka era una bambina perspicace – che non faceva parte della sua vita e che doveva stare al suo posto.
Vedendola affiorare dall’oscurità come una nottua silenziosa, o ciondolare sul sentiero tenendosi stretta una mano gonfia e arrossata dal contatto con le ortiche, Nanda Kaul si voltava e diceva a Ram Lal: – È pronta l’acqua calda per il bagno della bambina? – e Raka le scivolava accanto dirigendosi verso la stanza da bagno.
Escogitarono cosí un sistema di convivenza ed entrambe ritenevano di fare del proprio meglio per evitare l’altra, ma non era semplice esistere e nello stesso tempo fingere di non esistere.
Nanda Kaul trovava inquietanti le prolungate assenze della bambina almeno quanto trovava irritante la sua presenza. Ogni tanto si sorprendeva ad andare avanti e indietro da una stanza all’altra o da un capo all’altro del giardino non perché cercasse la bambina – non era da lei cercare un altro –, ma perché era turbata dal modo in cui Raka spariva e compariva.
Sembrava il coniglio esibito dal mago: estratta di malavoglia dal cappello magico, sfrecciava oltre la bisnonna e svaniva nel buio di una valigia da prestigiatore.
Nulla era piú insopportabile della magia, per Nanda Kaul.
Perché mai la sua tranquilla esistenza doveva essere sconvolta dalle congetture sui vagabondaggi di quella bambina? Cosí, quando Raka spuntava dal nulla, in ritardo, con le gambe graffiate e le tasche del vestito macchiate di succo di lamponi, Nanda Kaul le rivolgeva un’occhiata piú di rimprovero che di bentornata.
Ma Raka la ignorava. La ignorava in modo cosí pacato, cosí totale da lasciarla senza fiato. La scrutava adesso con apprensione, interrogandosi su quel rifiuto assoluto, cosí naturale, istintivo e spontaneo...