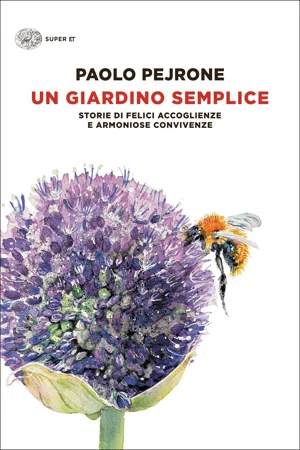![]()
![]()
Pochi spettacoli sono piú belli di un campo di papaveri in fiore. Rossi ed effimeri, sono conosciuti da tutti: da sempre accompagnano la maturazione del grano nelle nostre campagne. Se poi si aggiunge anche qualche fiordaliso, il colpo d’occhio può essere davvero eccezionale, degno della miglior tradizione.
Fiordaliso, frumento e papavero fanno parte di un trio idilliaco che purtroppo è quasi scomparso: non amati dai contadini, considerati alla stregua di erbacce parassite, i papaveri (e i fiordalisi) sono ormai caduti vittime dei sempre piú frequenti e famigerati diserbanti selettivi (e chimici). Come ben si sa, fanno molto piú danno che bene.
Non è facile vedere i papaveri nei giardini: un fiore dalla fioritura tanto breve è assai poco benvoluto, quasi che la bellezza di una pianta e la gradevolezza di un giardino si misurassero in termini di rarità, efficienza e durata. Seminare un prato fiorito di papaveri e altri fiori di campo, se lo spazio lo permette, è invece un’idea semplice ed estremamente piacevole, che riesce a rendere accattivanti e ospitali anche le zone incolte e meno frequentate trasformandole in un luogo brulicante di vita: grilli, farfalle e api in testa. Se seminati in terreni poveri, i papaveri si possono diffondere facilmente e naturalmente. Fin troppo. Non avendo bisogno di terre ricche, assetati di sole piú che di acqua, possono crescere in tutti i giardini assolati, e con esuberante vitalità possono prendere il sopravvento. Se si decide di piantare il papavero di campo, la varietà piú bella è certamente il famoso e comune P. rhoeas Shirley, selezionato dal reverendo inglese William Wilks negli anni Ottanta del XIX secolo. Fiorisce di un rosso talmente rosso da non aver bisogno di alcuna descrizione.
Sempre molto usato nei giardini inglesi per i colori vivacissimi, che vanno dal bianco al rosa shocking, dal vino al rosso fuoco, quasi a sfidare i «tradizionali» cieli grigi di quelle terre, è il piacevolissimo e imponente Papaver orientale, dai fiori enormi e sorprendenti. Mentre sempre affascinante è il P. somniferum, con la sua pesante aura di proibito: belle le foglie, bellissimi i boccioli e i fiori, è pianta di grande ornamento e come tale senza rischi può essere coltivata purché, come richiesto dal legislatore, in esigue quantità.
Immacolata, bellissima e robusta è invece la Romneya coulteri, lontana cugina dei nostri papaveri, che cresce selvatica nel chaparral della California. Nei giardini la R. coulteri si comporta spesso in modo capriccioso e per essere sicuri che attecchisca va «iniziata» con intelligenza: pianta da deserto, esige in giardino tanto sole e un drenaggio meticolosamente efficiente. Qui da anni invade senza remore né dubbi le impietose e assolate balze vicino alla serra fredda, mostrando di gradire oltre misura quei terreni spesso asciutti e sempre ben drenati che erano stati finora colonizzati soltanto dagli iris e dalle euforbie. I grandi fiori bianchi, setosi e solitari, con un gran numero di stami gialli al centro, fioriscono dai primi di giugno ad agosto: sono unici nel loro leggero profumo.
Il sogno segreto di tutti i giardinieri sono però i papaveri azzurri, le mitiche Meconopsis, uniche per colore e per buon portamento, ma purtroppo difficili da coltivare nei giardini italiani, soprattutto a causa del nostro clima caldo e secco: sono piante di montagna dove possono dare facilmente il loro meglio. Originari delle falde dell’Himalaya e degli altipiani del Tibet, abituati all’aria fresca e spesso umida di quelle terre, richiedono terreni ben drenati e piogge frequenti durante l’estate. Arrivarono in Europa all’inizio del Novecento, portati dal botanico inglese Francis Kingdon-Ward, che raccontò la loro scoperta nel suo libro, The Land of The Blue Poppy. Erano le M. betonicifolia, color del cielo e con lunghi stami dorati, che Kingdon-Ward, in una ventosa giornata d’estate, tra sogno e realtà, scambiò per uno sciame di farfalle azzurre. Niente di piú bello.
![]()
Un venticello di mistero l’albero di fico da sempre se lo porta dietro. E pure da lontano: a detta dei pastori dell’antico Regno delle Due Sicilie, in caso di temporali e di lampi e tuoni, ripararsi alla sua ombra poteva essere sicuro e salutare: l’albero «lavorerebbe» infatti come gabbia di Faraday.
In alcune parti del Lazio si diceva pure che per domare un toro fosse sufficiente legarlo (se ci si riusciva) all’ombra di un vecchio albero di fico.
O il venticello sarà forse stato ispirato dal suo traditore e fragile legno? Noto per andare facilmente a pezzi, quasi fosse una ingannevole trappola vegetale?
E infine, a quale albero si appese Giuda: a un fico o a un caprifico?
Pianta da campo, da orto, da giardino, se convenientemente coltivato il fico può diventare anche un eccellente albero da vaso e non solo: sotto i raggi caldi delle canicole anche il profumo delle foglie si fa piacevolmente sentire. Le radici, note per la loro invasiva intraprendenza, amano andare lontano a cercare cibo e freschezza preferendo lavorare in superficie, tanto da mantenersi in vita in posti improbabili e difficili e compiacersi, con tutti i crismi della tradizione, di luoghi poveri e impervi come le antiche mura di monumenti e di rovine.
Federico II, re di Prussia, aveva una vera passione per i fichi, e prima di lui il Re Sole, Luigi XIV. Per loro le serre e le aranciere non riparavano soltanto agrumi: pesche, albicocche e fichi rendevano unici e profumati dessert estivi e autunnali.
Per pittori, antiquari, studiosi e dilettanti il mondo classico non era soltanto fonte di ispirazione: molto importanti erano le meraviglie pomologiche del Sud, con loro l’affascinante e attraente mondo della frutta mediterranea, dall’uva (e dal suo vino) agli agrumi, dai melograni ai gelsi, e dalle angurie ai meloni, dalle mandorle ai pistacchi, tutti facevano parte di un enigmatico, ricco e praticamente sconosciuto universo vegetale. Fichi in testa: furono portati alla ribalta dell’Europa già ai tempi delle crociate. Solo in seguito furono raccolti e diffusi per l’Europa dalle serre e dalle aranciere medicee di Petraia e di Castello. Nella seconda metà del Settecento Federico il Grande si spinse piú in là facendo costruire a beneficio (proprio) e dei suoi amati fichi, nella grandiosa e raffinata Sans souci, una speciale parete a vetri, che captasse il piú possibile il calore del mezzogiorno dei cieli della Prussia occidentale. Per l’occasione vennero importate dalla Spagna, dall’Italia e dalle ricche sponde dei mari ottomani numerose e rare varietà, distinte per colore e per forma, a cominciare da quelli bianchi a quelli verdi, marroni, neri, bruni, da quelli grandi a quelli piccini. I fichi da «serra», con un preciso studio del clima e un attento uso delle pareti a vetro, potevano protrarre a lungo la stagione di fruttificazione. Si diceva addirittura fino a quattro-cinque mesi.
Il fico fu pure albero (e frutto) amato e studiato dal ligure Gallesio che, con passione, ne rilevò le caratteristiche e trascrisse, nella sua splendida e insuperabile Pomona italica, note precise e sempre attuali. Fu proprio Gallesio a individuare il famoso fico dell’osso, un frutto curioso d’aspetto e di consistenza, la cui forma, bizzarra e composta dalla somma di due fichi, è suggellata da un tipico e legnoso granello, chiamato appunto «osso».
Brogiotti o turchi, verdini o bianchi, fioroni o pisani, non è difficile per chi ha un po’ di terreno incolto, drenato e soleggiato, mettere a dimora una veloce e ombrosa collezione di alberi di fico: indenni, per ora, da fastidiose malattie e forse anche grazie al curioso «effetto serra», potrebbero essere un’autentica gioia per chi li coltiva (e per chi li coglie): un fico di buona qualità, ben maturo, raccolto e consumato, non è forse una sublime meraviglia della vista, del tatto e del palato? Bellissima in questi ultimi anni è Berna con le sue strade d’estate affollate di fichi in vaso: il riverbero dei suoi muri e dei suoi selciati fa ben maturare i frutti, e le foglie, cotte dal sole, felici, propagano profumi speciali a zaffate. Se coltivato in vaso il fico «pretende» un adeguato contenitore e una proporzionata terra: è inutile e un po’ arrischiato coltivare fichi in vasi piccoli, mentre da sessanta centimetri di diametro in su piú larghi stanno meglio crescono e fruttificano! Gli alberi in vaso, lo sa bene il bravo giardiniere che in terrazzo deve fare i conti con i pesi e i soliti malevoli pregiudizi degli atterriti coinquilini, hanno bisogno di terra abbondante.
Per anni ho mantenuto in vaso due fichi che, a detta del vivaista dovevano esser nani, e sono stati a vivacchiare allo stretto; confidando nelle sue parole li passai in vasi sempre piú grandi: la sorpresa fu immediata. Liberati da quella stretta prigione i due fichi hanno portato tantissimi frutti, le foglie si sono ingrandite diventando dei veri alberi. Di piccolo rimasero i frutti, per altro ottimi e gradevolissimi: evidentemente l’asserito «nanismo» non era che la legittima reazione alla mancanza di spazio. Mentre una giusta «libertà» ha portato le piante a reagire di conseguenza. Felici.
![]()
Nei giardini italiani l’Althaea, conosciuta anche con il nome di «malvone», non vanta certo una gran tradizione: per esserci c’è sempre stata, cresciuta qua e là, a ridosso dei fossi o lungo i vecchi muri di pietra, ma ben raramente si è trattato di un invito formale. Di solito arrivava e arriva in giardino per conto suo, trasportata sotto forma di semi dal vento e liberamente si sceglie la posizione che ritiene piú adatta e che, se ne può star certi, non coincide quasi mai con quella che avremmo voluto. La sua è una strategia molto intelligente (e libertaria): quando le piace il posto cresce velocissima, in modo da prendere alla sprovvista il giardiniere. L’allegra e prolungata fioritura estiva la rende poi benvoluta da tutti, proprio per l’effetto rustico e naturale che riesce a donare al giardino. Basta un anno e già l’alleanza è siglata: ogni autunno un po’ di semi vengono lasciati liberi di disperdersi nei posti vicini. Tutto sta a incominciare. Almeno in Italia. Altrove l’Althaea è da secoli trattata come una pianta da giardino, seminata e cresciuta dalla mano dell’uomo, addomesticata in vasi, aiuole e bordure. Come nella piccola casa-giardino di Johann Wolfgang Goethe nei dintorni di Weimar, dove lunghi e fitti vialetti di Althaea attraversavano gli ampi e curati prati. Goethe fu costretto a lasciare la casa controvoglia alcuni anni dopo, perché ritenuta troppo semplice e modesta per un uomo del suo stato, ma il giardino di malvoni, personalmente creato e curato, rimase per tutta la vita un rifugio amatissimo. E che cosa dire poi dei rigogliosi e bellissimi orti-giardino che anni fa mi capitò di visitare nel nord della Transilvania, dove l’Althaea fiorisce tra rose e dalie, in un insieme carico e disordinato e incredibilmente attraente. In quelle terre ci sono villaggi nei quali la strada, l’unica strada su cui si affacciano le case semplici e antiche, è interamente bordata di fiori di Althaea, di tutti i colori e di tutte le fogge, doppi, semidoppi e semplici, che spesso poi crescono qua e là negli interstizi del selciato. In Giappone le foglie di Althaea, molto probabilmente la nostra A. rosea, diffusissima anche in Oriente, sono state per piú di due secoli e mezzo il simbolo del potente «shogunato» Tokugawa: portare la sua effige ricamata sul kimono significava onori e ricchezza pressoché illimitati.
L’A. rosea è una specie molto comune nelle nostre campagne e tra tutte è certamente la piú spettacolare: ha fusti altissimi, anche oltre i due metri, grandi foglie chiare che andando verso l’alto si fan via via piú piccole e soprattutto racemi di fiori che virano dal rosa al porpora, dal bianco al giallo pallido. Fino alla famosa A. r. nigra, dai lucidi petali bordeaux, quasi nero, talmente scuri che un tempo venivano utilizzati per colorare il vino. L’A. ficifolia ha invece fiori delle piú belle tonalità di giallo, di oro e di arancio e, provenendo dalle fredde terre della Siberia, è una delle specie piú rustiche e resistenti. Amatissima in passato è stata l’A. officinalis, dai delicati fiori di un rosa quasi bianco: dalle sue radici si ricava l’estratto con il quale un tempo in Francia si preparava la famosa pâte de guimauve, la raffinata progenitrice dei piú commerciali e americanissimi marshmallow.
Come tutte le piante del suo genere l’Althaea sarebbe una perenne, anche se i geli invernali prima e il taglio dei prati poi spesso mettono a rischio la sopravvivenza dei germogli. È molto piú semplice riprodurla per seme. L’Althaea è infatti una pianta con poche pretese: ha bisogno soltanto di luce e di sole, adattandosi a ogni tipo di terreno, purché ben drenato, e resiste alla siccità grazie alle lunghe radici a fittone. Non per nulla è il fiore che piú di tutti occupa con facilità le vecchie ferrovie dismesse.
![]()
Il Calonyction aculeatum (oggi rinomenclato Ipomea alba) è conosciuto in Inghilterra con il nome di Moonflower, il fiore della luna. Niente di piú affascinante ed evocativo. È infatti una pianta che vive nelle notti d’estate, quando si aprono i suoi grandi fiori bianchi, evanescenti e delicatamente profumati. Sbocciano al crepuscolo, nel giro di pochi minuti, ed è subito una festa per le falene, attratte dal candido biancore e da un nettare raro, prezioso e ricercatissimo. Alle prime luci dell’alba i fiori sono già avvizziti, ma basta una giornata di sole perché altrettanti ne prendano il posto la sera successiva. Originario del Messico, il Calonyction aculeatum è un rampicante vigoroso e quasi invasivo: si espande velocissimo nell’arco di un’estate, avvinghiandosi a tutto ciò che trova a portata di ramo. Anche l’apparato radicale tende a diffondersi a dismisura in poco tempo, in modo da riuscire a sorreggere la crescita intensiva della chioma: per evitare spiacevoli sorprese e contenerne la carica dirompente, è certamente meglio coltivarlo in grandi vasi. Sarà cosí possibile riparare il Calonyction in serra durante l’inverno: è infatti una pianta sensibile al freddo, motivo per cui, pur essendo perenne, in Italia viene quasi sempre coltivata come annuale.
![]()
I cisti vogliono tanto sole e pochissima acqua. Sembrano delicati, in realtà sono rustici e forti. E bellissimi. Esalano sotto il sole un finissimo aroma: è il profumo estivo della Sardegna, assolata e arida.
Cistus è il nome scelto da Linneo per questa piccola meraviglia delle nostre coste. Circa venti sono le specie provenienti dall’Africa settentrionale, dalle Canarie, dalle zone dell’Egeo e dall’Europa: bellissimi sono i loro fiori, stropicciati, bianchi e rosa, di varie tonalità. Visti in natura, sopraffatti dal sole e dalla siccità, tutto ci si aspetterebbe ma non un aspetto cosí evanescente e delicato.
I primi ad accorgersi del loro valore giardiniero, come spesso è accaduto nella recente storia del giardino, furono gli inglesi. Un po’come fecero per le lavande, i rosmarini e le santoline, non smentendo la loro fama di curiosi ed eccellenti «cacciatori di piante».
Fatti crescere nei posti meno irrorati dalle piogge, e soprattutto ben alloggiati in terre ghiaiose e «iperdrenate», i cisti sono diventati, con il tempo, parte del «paesaggio» giardiniero del XX secolo: giardini dall’aspetto «borghese», quelli del vero e appassionato giardiniere (nuova figura, per l’epoca, che prevede un proprietario attivo, lavoratore e presente) e che, per prima, la grande Gertrude Jekyll studiò, propose e costruí.
Giardini moderni fatti di piante adatte per posti adatti. Dove è essenziale avere delle piante «libere», non obbligate a vivere in luoghi dove un proprietario (o peggio un architetto) si interessi di piú agli effetti immediati che alla vita delle piante. Facendo diventare i giardini degli effimeri allestimenti. E non dei duraturi compagni di vita.
Quello di Gertrude era un giardinaggio sapiente che prevedeva per le piante anche il loro giusto periodo di riposo. Un giardinaggio fatto giustamente di pause e di silenzi «botanici» e, nel caso dei cisti, riposi piuttosto prolungati. L’importante era (ed è) prevedere alternativi e magistrali «colpi di scena» giardiniera atti a distogliere la vista delle parti «noiose». Maestra ne fu Rosemary Verey che nel suo giardino del Gloucestershire, con l’uso attento di pochi ma significativi interventi, con quasi nulla, riusciva a creare una speciale atmosfera emotiva. Rosemary, sapiente, agí sulle ali delle vivaci esperienze inglesi e scozzesi del Seicento, introducendo senza timori le piante che da tutto il mondo periodicamente arrivavano nei bulimici vivai d’oltre Manica. Fu elegante e unica propositrice del poco (del resto il suo giardino era fatto di tocchi piú che di masse). I cisti vi comparivano qua e là nelle loro robuste e gradevoli forme ibride, come il Cistus x Alan Fradd, bellissimo per i suoi cinque petali bianchi, in leggera e aperta coppa, sigillati da cinque piccole gocce di color porpora-bordeaux. Le belle foglie e l’armonico arbusto sono coperti da giugno ad agosto da decine e decine di fiori leggeri, eterei ed effimeri sia nell’aprirsi che nello scomparire. Belle sono pure le loro minute e rugose foglie un po’ simili a quelle della salvia: un lungo periodo «sottotono» che accompagna il riposo necessario a recuperare le energie per la fioritura dell’anno dopo. In giardino l’importante è dividere i rischi e i ruoli e molto saggio è non mirare a grandi effetti massivi ma affidarsi invece a poche pennellate decise e leggere. Anche Gertrude Jekyll la pensava in questo modo dirigendo (nonostante la sua forte miopia) il balletto dei colori dall’alto della sua variopinta tavolozza botanica. Non per nulla il grande successo delle sue idee (e dei suoi apprezzatissimi e ormai storici giardini) riesce a influenzare ancora il giardinaggio consapevole (e sostenibile) di mezzo mondo.
![]()
Quelli della Magnolia delavayi, originaria della Cina meridionale, sono fiori belli, grandi, rari ed effimeri, i cui petali si schiudono normalmente in piena estate e soltanto di notte: leggermente profumati, sono il simbolo della città di Chongqing, dove gli antichi la pianta...