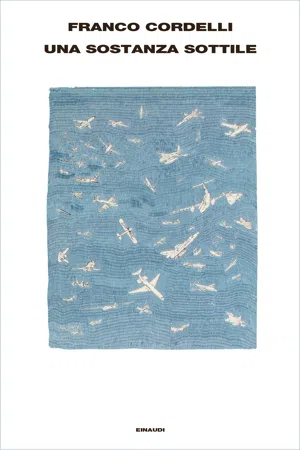![]()
Quando la rincorsa finí, quell’attimo beffardo in cui il rombo dei motori sembra venir meno e l’aereo si solleva, pensò ad Agnès: «Sí, proprio a lei». Mi rendeva difficile l’accesso, non riuscivo a vederti, non ti toccavo mai, non ti abbracciavo, ti alzavi sulla punta dei piedi – come ora si solleva questo aereo che mi porterà al nostro appuntamento. «Ma oggi», continuò, «ti prego Irène – no, Irene, figlia mia quanto di lei, Agnès: tua madre dimenticala per un poco. Devi essere piú buona di sempre, piú innocente di quanto tu non sia; e come non sei, né inconsapevole, né ignara. Ti chiedo di ascoltare ciò che non ti ho raccontato, eri troppo giovane, troppo figlia, non potevo, non ero capace».
Subito dopo vi fu l’oscillante, decisa virata verso nord-ovest, verso Marsiglia (magazzinieri, farmacisti o noleggiatori d’auto da Marsiglia in su, mormorava, tutti sono arroganti, da sempre; eppure se la sono conquistata, quell’arroganza: o come noi o niente). Guardò attraverso il finestrino, già si vedevano la bruno-rossastra costa tirrenica, le case dei pescatori e, in fondo, le strade sconvolte dalla luce. Gli piaceva pensare nella luce chiara del cielo, fredda anche d’estate: una luce tutt’affatto diversa da quella di Provenza o, poniamo, di Grecia. «Ma se in questa luce vedo tutto con chiarezza non è grazie alla luce, ma grazie all’altitudine – e alla separazione». Rivedrò Irene, le racconterò.
Ci si può ribellare contro la propria madre, si possono uccidere i rivali, si possono rubare gli amori degli altri, si può tradire ogni amore ma – distolse lo sguardo – libertà è condizione di figlio, i genitori sono solo custodi dei figli che hanno generato. Che cosa dopotutto smaschera l’anima – che ci divide, ci separa? Tutto è inadeguato; la fraternità o l’uguaglianza piú subdolamente ch’ogni altra faccenda. Le lacerazioni, le rotture, le divisioni sono provocate dall’anima – se la lasciamo quassú, nuda e sola. La malattia stessa del resto è tutto un simulare, recitare una parte, dare spettacolo. Lo sapevi? lo avevi sospettato? Parlava ancora con me, che sono sua figlia e che, questo è il mio uffizio, debbo dire di lui – o di noi – o di tutti.
Il desiderio di sprofondare (come lui si esprimeva) gli venne all’imbocco della Galleria Giovanni XXIII. C’era da pochi anni, non la percorreva mai; o l’aveva fatta poche volte, era un’eccezione. Del resto non guidava lui, guidava un autista, lo portava a Fiumicino. Da poco tempo aveva preso l’abitudine di volare.
Ricordava benissimo i viaggi in macchina per tutta Europa, come un pazzo, uno scervellato, cinquecento o mille chilometri al giorno, da Monaco a Barcellona (era il 1972, lasciò le Olimpiadi, i palestinesi con le maschere sul volto li vide in televisione), o da Roma a Parigi senza sosta, o fino alle Highlands, o fino in Danimarca; fermandosi, a volte, solo una notte.
Non parliamo di quell’anno, mi disse piú tardi, stordito dal sole, dal vento, il furioso mistral, non parliamo del 1985, quando andai e tornai da Avignone due volte – come fossi non so che Clemente XII o XIII in carrozza, come non sapessi piú distinguere tra ortodossia ed eresia, come non capissi la differenza tra il mio alto ufficio e le circostanze, la politica sovrana, quella pastorale, e le circostanze che a tanta perplessità c’inducono –, due volte in otto giorni, quattromila chilometri per compiere non si sa bene cosa. «Non lo sapevo, non lo sapevo piú, non lo ricordo».
E insomma: entrò nel buio della Galleria e subito gli vennero incontro – prima come massa indistinta, poi come frammento di un insieme che nella coscienza era ancora fecondo – le persone (gli amici, uomini e donne) che per tre mesi, con pazienza, con dedizione, con smarrimento (cosí supponeva, ebbro per la luce, proprio come me), e con ansia, con gioia repentina, con fretta, la mia stessa – di raggiungerlo, là dov’era – gli vennero incontro le persone ch’erano ogni pomeriggio entrate in quella Galleria: si trattava d’un passaggio obbligato, quasi nessuno di quanti conosceva la conosceva – prima d’allora. Inoltre, ricordò mio padre, esisteva da pochi anni: otto o nove – chissà. Lui non era (non è) tipo da raccogliere simili informazioni. Questo è compito mio, che pure a Roma non vivo.
Apparve un’archeologa, morta in Inghilterra non ancora sessantenne, in un incidente automobilistico. L’ammirava. Aveva scritto della grotta di Chauvet-Pont-d’Arc. «Ti ricordi? Andammo due estati fa, non riuscimmo a vedere nulla». A distanza di cinquemila anni gli uni dagli altri vi avevano lasciato i loro disegni – bisonti in fuga, rinoceronti, mammut, lupi, renne. C’era chi aveva lasciato la firma, l’impronta della mano, un mignolo spezzato. L’archeologa descriveva una venere paleolitica, con i suoi larghi fianchi, c’erano le tracce delle torce, il carbone. Aveva avuto la fortuna di vedere quasi tutto. Aveva scritto: La montagna che dipinge è lo spirito. Noi siamo prigionieri della storia, quegli uomini no. Era un’osservatrice austera e triste, benché, cosí ponderava, avesse una figlia. Cosa sei, tu? Senza dubbio, si disse – scrutando l’autista, per cogliere nel suo profilo immobile e privo di sentimento, se avesse per caso voglia di parlare e lui fosse scortese a non avergli rivolto la parola –, senza dubbio quella donna, al contrario degli usi suoi, si documentava su tutto, su ogni minimo episodio storico o geografico, per porre un argine alla tristezza.
La tristezza è un nemico indocumentabile, e si impossessa di noi esseri umani; ma mio padre (papà) rifiutava gli stati d’animo. Perché si preoccupava di quel tizio? Avere tristezza, o avere malinconia, o ripiegarsi su di sé, in qualunque modo ciò accada, e per qualunque ragione, non voleva nel modo piú assoluto. Si può non volere?, si chiedeva. Sí, si può, rispondeva, bisogna allenarsi, la vita non è che un piú o meno interminabile allenamento a non avere desiderio – o ad averne (non averne è peccato), esso mantenendo alla giusta distanza. È quel Clemente XII o XIII che avrebbe detto: eliminarli, gli stati d’animo; scacciarli come il diavolo, ove se ne coltivasse l’inclinazione, se ne fosse insidiati – ignaro, il vecchio pontefice, di cosa essi fossero, i desideri – che stati d’animo non sono.
«Questo», gli dissi un giorno, «consideriamolo un residuo, una traccia di virtú antiche, cristiane». «Penso semmai», mi rispose, «a un mio immortale professore di storia e filosofia: un uomo che era stato studente a Torino, con compagni di classe che, come lui, avevano partecipato alla Resistenza. Erano tutti laici; molti, tra loro, erano marxisti. Anche se la maggior virtú è quella della parabola, i talenti, non sprecare i propri talenti. Il pensiero che non vi sia consolazione è una colpa. Tutti hanno talenti». Dalla Galleria per l’aeroporto uscirono piú avanti, a sinistra – per l’ospedale nel 2009 giravano a destra, tutti quelli cui aveva pensato.
![]()
Avrebbe collocato il San Filippo, l’ospedale San Filippo Neri, tutto sulla destra. Esso è situato quasi fuori della città, in un suo confine a nord-est: diceva «in un suo confine», come ce ne fossero tanti, e in effetti cosí è, o almeno cosí percepiva i confini di Roma, come illimitati, difficili da definire. E poi, per quanto la conoscesse, questa città, per quanto, per anni e decenni, l’avesse attraversata, di giorno e di notte, piú di notte che di giorno, poiché non aveva l’intenzione di esaminarla, né possedeva il talento, istintivo e brutale, dell’esploratore, non pensava di conoscerla, non gli interessava, non diceva mai a se stesso: sono diventato il re di Roma, la domino.
Quando si chiede ai tassisti se la conoscono (e lui sempre glielo chiedeva, quasi imponendogli una prova: Lei, la città la conosce in ogni suo angolo, non è vero?), rispondono situandosi su una soglia: tra l’orgoglio e la modestia, quello specifico tratto che non possiamo giudicare altro che di falsa modestia. Come sopportare la falsa modestia? Se si riflette è un aspetto della specie umana – della sua malattia, della sua aberrazione – tra i piú insostenibili. Alcuni vi dimorano, se ne lasciano consolare, con essa convivono. Altri, smaliziati, superano l’ostacolo di slancio, situandosi nella pienezza di sé, come niente fosse; e altri ancora, ancor piú maliziosi poiché dotati di un pizzico di furbizia che i primi non hanno, l’ostacolo non lo superano affatto, non lo vedono neppure, prudentemente se ne tengono al di qua.
I tassisti, che non sono comunque un argomento del nostro racconto (o dei nostri appunti, della nostra memoria, della mia compiacenza, del mio amore), i tassisti, gli ingenui, abbracciano il proprio slancio emotivo, ciò che di sé pensano – rispetto al mestiere che esercitano e, nella fattispecie, al luogo nel quale ciò accade.
«Per lei, Roma non ha segreti. Dico bene?»
«Ma no, lo nego, c’è sempre da imparare. Proprio poco fa, uscendo da casa sua, non mi ha detto di girare subito a sinistra? Per me, sarei andato dritto e avrei fatto il giro di tutte le palazzine per riprendere la Cassia».
Cosí, almeno nei primi passi, appena usciti di casa, dei tassisti, o di ciò che alcuni possiedono, il cosiddetto navigatore, finiamo per essere noi stessi le guide. Quell’anno il navigatore non esisteva, non ve ne era neppure l’immaginazione. Si procedeva, fermandosi ogni momento, a una quantità di passanti chiedendo informazioni. Al San Filippo andò in lambretta, era (cosí gli sembrava) il 1964, aveva dunque ventun anni.
Ne sapeva la causa. Non ricordava, per contro, chi lí lo avesse spedito. Di sicuro, un medico. Vada al San Filippo Neri, c’è un collega (di cui ignorava il nome) che saprà dirle che cos’è questa tumefazione, questo rigonfiamento.
Era proprio all’altezza dell’inguine, o poco sotto. Lo toccava in continuazione, lo palpeggiava, lo soppesava. Temeva s’ingrandisse, un millimetro al giorno. A vent’anni si vive nella paura, e vi si vive anche dopo, a trenta, a quaranta, a cinquanta. Quando finisce la paura? Possiamo supporre che a un certo punto dello sviluppo non ve ne sia piú, neppure una briciola? La paura, un giorno diremo, è un remoto ricordo. «Quando penso che avevo paura dell’aereo mi viene da ridere».
Il San Filippo lo situava alla sua destra, come se avesse bloccato la lambretta là di fronte e attraversato la strada, cinque o sei metri in tutto. Poi, e questo era il momento culminante, l’indimenticabile, aveva salito quei pochi gradini che immettono nell’ingresso principale toccandosi di nuovo, e di nuovo, come se con un ultimo, estremo accertamento, volesse essere sicuro che ciò cui si apprestava, sottoporsi a una visita di controllo, ossia a un responso conclusivo, non fosse cosí indispensabile, non fosse la cosa giusta.
Ma salendoli, proprio lí, nella piena luce del giorno e nel clamore del traffico di tutti coloro che irrompono nella città, o ne escono per recarsi a un qualche lavoro in luoghi lontani, quaranta o cinquanta chilometri al giorno, salendo quei gradini fu colto da uno spasimo: sospettava di avere un tumore. Di fronte a un che d’estraneo nel proprio corpo chi non penserebbe a un tumore? Di tumori, nel 1964, tutto ignorava. Non era che una risonante parola. Tutto ignorava anche adesso, almeno da un punto di vista medico, tattile, sensoriale, sub-sensoriale – come se i sensi potessero dirci qualcosa in proposito. Non è cosí che i tumori si manifestano, questo credeva di saperlo – che sono in specie silenti, reconditi, subdoli: i tumori come fantasmi.
Tuttavia, questo sí, adesso, se avesse sospetti, essi avrebbero la parvenza di un fondamento sensibile e, soprattutto, avrebbe già formulato una quantità di ipotesi, in specie psichiche, che gli farebbero salire quelle scale con piú saldezza, con piú energia – sebbene invalicabile la soglia della paura, come per Euridice quella del ritorno tra noi.
Allora, tremava (un poco), palpitava, si fermò, si girò a guardare cosa si lasciava alle spalle – quasi che entrando là dentro non ne dovesse piú uscire, o ne potesse un giorno uscire trasformato, del tutto mutato, non piú lui. Ormai un rottame umano, senza troppe speranze di vita, non molti fatti davanti a sé – né si può dire che questo timore fosse lacerante, abietto, e che riguardasse qualcosa, della vita, in generale e sua, di piú o meno preciso. Era un timore puro, cristallino: esso non aveva che una gloria, di non avere oggetto.
![]()
In effetti, mi disse (eravamo nel luogo piú tranquillo di Saint-Rémy, mai nessun avventore, il caffè des Alcools), parlami – e nient’altro, come tu non sapessi niente. Somiglia a un vecchio sogno, nel 1978 scrissi un romanzo fatto cosí, solo con domande e risposte, colui che poneva le domande ne aveva il diritto e l’autorità; nessun diritto e nessuna autorità coloro che rispondevano – un personaggio si rifiutava di rispondere, o meglio non aveva alcuna possibilità di risposta. Era un romanzo difficile da finire, non c’erano osservazioni dell’autore; non c’erano, come si direbbe per un copione teatrale, didascalie.
Ricordo che ne accennai a un tizio, proseguí, piú grande di me, cioè piú vecchio, piú navigato. Lo avevo conosciuto quello stesso pomeriggio, facemmo una lunga passeggiata, gli enumerai tutte le mie difficoltà e perplessità, pensavo che quest’uomo avesse esperienza, gli riconoscevo un prestigio (era un letterato), mi stupii in modo enorme, tanto che, come vedi, sono qui a raccontarlo, quando tutto il suo commento fu: «Se per caso non dovesse riuscirle, se non lo finisce, potrei utilizzare io la sua storia?» Persone come quelle, prima mi stupiscono, poi mi innervosiscono. Che intendeva per utilizzare?
In effetti quel romanzo io lo riscrissi una quantità di volte, poi vi rinunciai. Ma un anno dopo, lo ripresi e cominciai in tutt’altro modo, senza domande e risposte nude e crude; e lui, il letterato milanese, un collezionista di libri, fece davvero come aveva chiesto, utilizzò il mio canovaccio, ma sarebbe meglio dire la mia piccola storia. Quando lessi il suo libro, che mandò con riconoscente dedica, tornò lo stupore. Lo ha fatto, lo ha fatto davvero. Era un signore già avanti con gli anni, un uomo sofisticato – eppure, mi dicevo leggendo, costui è un ingenuo, crede nel potere salvifico di un dialogo e d’una storia, ogni argomento è buono, ci crede fino a questo punto.
«Tu ci credi?», mi chiese.
«No, io no, per niente, cosa sono i dialoghi, o i commenti? Certo, si danno storie in sé significative, ma ho capito (da te) che quasi sempre ciò che conta, conta per come è scritto, per l’anima sua. Perché me lo chiedi?»
Ci eravamo spostati nella sala piú interna del caffè. Davanti a noi c’erano i nostri due calvados, che avevamo ordinato per puro feticismo; e dalla finestra si vedeva un ulivo, appena toccato dal vento, il mistral lo si indovinava da quella cima in lieve ma permanente agitazione: era bello intuirlo senza sentire. Hai ragione, ripeteva, il punto vero, anzi l’unico, è: dire la verità o non dire la verità? Una tizia mi ha spiegato che non è sempre stato cosí – almeno nel caso di fatti della propria vita. I primi che s’erano giocati questa carta, tendevano a barare, erano giocatori con un asso nella manica; quelli, diceva la tizia, abbellivano, si dipingevano migliori, come fossero eroici, o valorosi; o, al peggio, sfortunati: maledetti dalla sorte. Quanti racconti del genere abbiamo letto nel corso del tempo? Oggi è tutto diverso, gli scrittori che vogliono dire la verità la dicono, si dipingono come sono, se sono ladri confessano d’essere ladri. Se sono omosessuali dicono d’essere omosessuali – che problema è? e se sono puttanieri se ne fanno un vanto.
Ma ecco, questo è il punto, lo fermai, non è normale che di ciò che sono costoro, cioè tutti, si vantino?
«Persino di me», rispose d’un fiato, «che sono stato tre mesi in ospedale, tra la vita e la morte, se di ciò scrivessi, si potrebbe dire che mi sto vantando d’essere caduto in stato di malattia. La faccenda è complicata – la mia idea è che se la nostra coscienza di questi meccanismi (dell’inganno e dell’autoinganno) è cresciuta, s’è fatta sottile fino allo spasimo, ciò non ci rende migliori, o meno equivoci – ci espone a rischi gravissimi. So come vanno queste faccende: piú e meglio scruti l’evoluzione della consapevolezza di te, ossia dell’umana condizione, piú si è ammirati. Ma piú si è ammirati, piú si cade nella convinzione che la tua coscienza ti salverà. Salvarsi da che, poi?» Fece una pausa, finse di bere. Si guardò intorno solo per un attimo. Poi riprese, come avesse raccolto un pensiero che gli era sfuggito.
«Come se l’idea della salvezza, che sta in fondo a tutto, avesse un senso». Mi sento di dire, precisò, che per capire possiamo contentarci di usare una terminologia convenzionale: chi ha cominciato è un rivoluzionario; chi ha rovesciato le carte, chi crede d’aver scoperto il trucco, è un controrivoluzionario.
«Ma c’eri anche tu, ieri. A casa della psicanalista, intendo. A me sembrava che si chiudessero (si saldassero in modo drammatico) due esperienze: quella mia, dei miei rapporti con Avignone; e quella sua, di questa donna gentile. Lei diceva d’essere felice della propria solitudine: solo pazienti, niente mariti, niente figli, niente gatti. Era del pari felice d’avere noi due lí, nel suo studio, ove si accatastano quadri, spartiti, libri, tappeti, vasi, tazze d’evidente pregio – in quella sua casa che fu d’un cardinale al tempo di Petrarca, quando costui diceva d’odiare la città ed era sempre sul campo, in conversazione: vestito di rosso robone e la fronte coronata di lauro capitolino».
Lei lo aveva detto subito: Sono una psicanalista lacaniana. In Francia non si può non esserlo, non si avrebbe credito. «Lo ha dichiarato con un sorriso benevolo: te ne sei accorta?»
Infine ripetemmo quanto ci aveva stupito, ma quanto ce ne eravamo compiaciuti, che avesse sussurrato (poiché era un sussurro) il suo nome, Michèle Jung – un nome incredibile: per una psicanalista, per una psicanalista del suo genere, e in assoluto. In quanto a mio padre, sentii che era sul punto di ricevere un briciolo di ricompensa, da quella donna, rispetto al fatto che un’altra donna, che d’un suo libro s’era infatuata, era poi sparita. L’aveva abbandonata lui, o ne era stato abbandonato? La nostra anziana ospite gli chiedeva di scrivere titolo e editore di quel romanzo concepito nel 1978 e tradotto dieci anni dopo in Francia: «Ormai, disse, nulla piú si perde». Ma anche si chiedeva, scendendo le scale, se per caso vi fosse un sublime e imperscrutabile nesso tra quel nomade, il poeta aretino, che era sempre dov’era i...