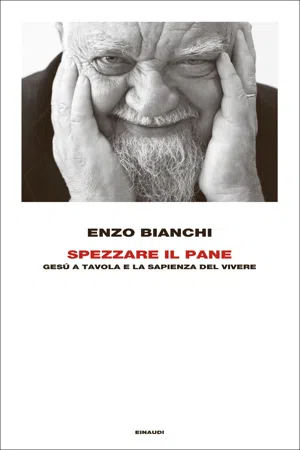La tavola del popolo di Dio.
Chi legge con assiduità la Bibbia sa quante volte in essa si raccontano pasti, cene, banchetti, si menziona lo stare a tavola, si parla di cibi, di alimenti per la nutrizione dell’essere umano. Testimoniando la storia dell’umanità e la vita di uomini e donne, la Scrittura non può non parlare di cibo e di pasti; e proprio le parole bibliche sul mangiare e sugli alimenti gettano luce su queste realtà umanissime, inerenti alla vita. Per questo nella Bibbia si trovano indicazioni su cosa mangiare, come mangiare e anche con chi mangiare. La tradizione ebraica e poi quella cristiana, volendo essere vie di senso per l’umanità, hanno tentato di rischiarare la realtà del cibo, del pasto e della tavola in rapporto sia alla persona che alla società. Ecco perché la tematica del cibo attraversa tutta la Bibbia, dalle prime pagine della Genesi al libro finale dell’Apocalisse: perché nutrimento, cibo e tavola dicono qualcosa di fondamentale sulla vita umana, sulla sua vocazione, sulle sue sfide e anche sul Dio creduto e confessato.
Come si è già ricordato, ogni pasto narrato nell’Antico Testamento aveva un carattere sacro, i sacrifici offerti al Signore erano anche pasti in cui gli offerenti condividevano il nutrirsi delle vittime o dell’offerta con i sacrificatori, i sacerdoti. E certamente va anche rammentato che la festa principale di Israele, quella che celebrava la sua origine, cioè la liberazione dall’Egitto, era vissuta in un pasto preso la vigilia di Pasqua, pasto in cui si mangiava l’agnello come zikkaron, memoriale del riscatto del popolo di Dio12. Di generazione in generazione – dice la Torah – Israele mangerà l’agnello immolato dalla comunità con pani azzimi ed erbe amare, come rito perenne, festa del Signore. La Torah precisa inoltre che il pasto pasquale, essendo per Israele un pasto memoriale, non potrà essere condiviso da incirconcisi: «Nessuno straniero ne deve mangiare», «non ne mangi nessuno che non sia circonciso» – si afferma –, proprio subito prima di attestare che «vi sarà una sola legge per l’ebreo e per lo straniero». Il pasto pasquale, di fatto, è paradigma di ogni pasto consumato dal popolo di Israele: sarà sempre condivisione dei frutti della terra e degli animali, uno strumento di comunione, segno dell’alleanza.
Nel libro della Genesi, al momento di creare l’umano Dio dice:
Facciamo l’umano a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra [Gen 1,26].
Poi, dopo la famosa affermazione:
E Dio creò l’umano a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò [Gen 1,27],
si torna a ribadire:
Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che si muove sulla terra» [Gen 1,28].
Una chiara eco di questi testi è il salmo 8, che presenta l’uomo «poco meno di Dio», con tutte le creature animali sottomesse ai suoi piedi. Ma di quale dominio si tratta? Subito dopo, infatti, la Genesi afferma: «Dio disse: “Ecco, io vi do ogni erba che produce seme su tutta la terra e ogni albero il cui frutto produce seme: saranno il vostro cibo”» e, parallelamente, agli animali della terra e del cielo Dio «dà come cibo ogni erba verde» (Gen 1,29-30), la verdura. L’uomo dunque sarà agricoltore e pastore, non predatore. Nutrendosi di vegetali, rispetta gli animali, sui quali deve sí dominare, ma con dolcezza, senza essere mai per loro una minaccia, né dare loro la morte.
È la catastrofe del diluvio13 che segna il passaggio da un comportamento a un altro. Proprio perché l’uomo ha conosciuto un crescendo di violenza dall’uccisione di Abele da parte di Caino14, allora Dio, tenendo conto di tale impulso violento, gli permette di mangiare gli animali, nella speranza che almeno cessi la violenza dell’uomo sull’uomo. Dio afferma: «Quanto si muove sulla terra e tutti i pesci del mare sono dati in vostro potere. Ogni essere che si muove e ha vita vi servirà di cibo». Ma significativamente pone un preciso limite: «Soltanto, non mangerete la carne con la sua vita, cioè con il suo sangue» (Gen 9,2-5). È un chiaro segno della necessità di rispettare la vita: bere il sangue dell’animale è incorporare in sé la sua vita, e ciò non è possibile, è oltre il limite! Queste regole non sono meramente alimentari, ma vogliono indicare un comportamento etico dell’uomo verso i suoi simili, un cammino di pace e di convivialità, come il testo precisa con grande sapienza: «Del vostro sangue, ossia della vostra vita, io domanderò conto; ne domanderò conto a ogni essere vivente e domanderò conto della vita dell’uomo all’uomo, a ognuno di suo fratello», dice il Signore.
Dio fa dunque questo dono di creature buone e salutari, un dono che certo chiede all’uomo responsabilità, consapevolezza di ciò che mangia, rispetto per il cibo e condivisione, perché tutte le creature sono destinate a tutta l’umanità, non ad alcuni privilegiati o «rapinatori». Occorre inoltre ricordare che, quando l’umano si ciba, introduce in sé vegetali e animali, doni della terra, «ciò che la terra contiene, racchiude»15, e cosí realizza e manifesta la sua consustanzialità con la terra16 da cui è stato tratto. La terra nutre noi umani, è nutrice e, in questo senso, nostra madre! Tutti gli alimenti sono «salutari, portatori di salute e di salvezza» (cfr. Sap 1,14), tutte le creature sono giudicate da Dio molto belle e buone17, tutte addirittura hanno una voce18, cioè compongono un’orchestra che canta e suona una musica che oggi non sappiamo ascoltare, ma che ascolteremo in un giorno al di là dei giorni.
Ora, questa intenzione di Dio, il Donatore di ogni cosa bella e buona, non è stata compresa fino in fondo dagli umani, che ben presto sul cibo hanno introdotto le categorie del puro e dell’impuro, hanno giudicato alcuni cibi salutari e altri maledetti, finendo per innalzare muri di separazione che impedivano il pasto come azione comune, come gesto di accoglienza e di partecipazione condivisa. Piú precisamente, proprio in ambito alimentare – ambito culturale che decodifica in vario modo il rapporto tra cibo e società – si sono elaborati divieti e prescrizioni, facendo attenzione soprattutto alla categoria della «separazione» come fonte di ordine, idoneità e adeguatezza19. L’attenzione a tali regole alimentari non significa soltanto salvaguardare alcune norme igieniche, o mantenere una tradizione, ma ha anche il senso di «separare», cioè «santificare». Ovvero, preparare e consumare cibo kasher favorisce un miglior rapporto con gli altri esseri umani, insegna il rispetto per gli animali e per la natura. L’interrogarsi su ciò che si mangia e su come lo si prepara, «santifica», cioè rende altro il rapporto con il cibo, con la terra, con tutte le creature di Dio, stimolando in tal modo una ricerca interiore che si traduce immediatamente in una determinata prassi. In virtú di tali istanze, la tradizione sacerdotale di Israele si è impegnata nell’elaborazione di norme per dare al popolo di Dio una precisa identità, che lo distinguesse dai gojim, dalle altre genti. Per questo si distinguono animali puri e impuri, si vietano mescolanze addirittura nei tessuti, si condanna la condivisione della tavola con i pagani. Il tutto a partire dal bisogno di distinzione dagli altri popoli, motivato anche da ragioni teologiche:
Sarete separati per me, poiché io, il Signore, sono separato e vi ho separato dagli altri popoli, perché siate miei [Lv 20,26].
Questo bisogno di identità e di differenza dagli altri, pur originato da intenzioni salutari, in epoca post-esilica divenne una vera e propria ossessione, quando la lettura della Torah, della Legge, finí per essere interpretata come principio di separazione all’interno dello stesso Israele, avviando una sorta di «pulizia etnica»!20. L’impurità fu intesa anche a livello genealogico, al punto che non solo gli alimenti ma anche le persone furono giudicate pure (i giudei) e impure (i gojim, i samaritani…) Sorsero poi movimenti religiosi che, seppur composti da laici, volevano obbedire rigidamente alle norme di santità osservate dai sacerdoti: il gruppo piú conosciuto portava il nome emblematico di perushim, farisei, cioè «separati». Contro ogni tentativo di assimilazione, opponevano resistenza fino al sangue e diventarono sempre piú intransigenti, aumentando e rendendo piú severe le prescrizioni riguardanti la purità/santità. E cosí l’identità dei credenti era cercata in norme sui cibi e, di conseguenza, nell’esclusione dalla propria tavola di chi non seguiva tali norme: i pagani, i peccatori pubblici, gli uomini e le donne ritenuti indegni di stare a tavola con quanti si consideravano gli unici definibili come figli di Dio, orgogliosamente distinti da quelli che erano pubblicamente impuri, a causa della loro non osservanza della Legge. Il pasto divenne progressivamente sempre di piú un luogo di esclusione, di separazione. I rabbini precisavano con crescente minuzia le prescrizioni al riguardo; i farisei, volendosi interpreti della Legge e amando la Legge piú del Legislatore, erano attentissimi alle regole dietetiche e alle frequentazioni conviviali; i letteralisti, gli osservanti ascetici con il loro rigorismo e la loro predicazione intransigente mettevano in guardia i credenti da ogni mescolanza con i costumi dei gojim.
È in questa situazione culturale e religiosa che si colloca e si inserisce il rabbi di Galilea, l’ebreo Gesú di Nazareth, il quale mostra ben presto un comportamento «altro» rispetto a quelli degli uomini religiosi e delle autorità giudaiche. Proprio nel suo stare a tavola, accettare l’invito a tavola opera una rottura, uno strappo con l’etica religiosa dominante. Gesú giudica la separazione tra puro e impuro come una barriera che deve cadere, in...