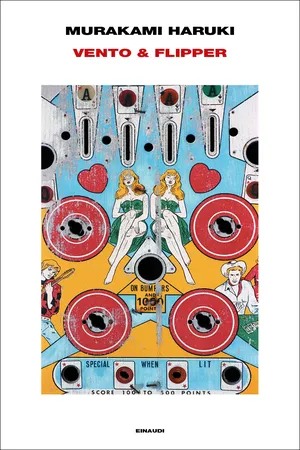![]()
Adoravo ascoltare storie di posti lontani, era quasi patologico.
C’è stato un periodo, una decina di anni fa, in cui attaccavo bottone con tutti quelli che mi capitavano a tiro e chiedevo loro di parlarmi dei posti dov’erano nati e cresciuti. Le persone disposte a prestare orecchio ai fatti altrui devono essere veramente poche, perché la gente reagiva in modo davvero gentile e accettava con entusiasmo di dirmi quel che volevo. Tipi mai visti né conosciuti, venuti a sapere di me, si presentavano alla mia porta.
Mi raccontavano di tutto, come se gettassero pietre dentro un pozzo prosciugato, e una volta terminato se ne andavano via soddisfatti. Mentre parlavano, alcuni sembravano contenti di farlo, altri si infuriavano. C’era gente che andava dritto al punto, altra che mi confidava in modo sconclusionato vicende senza capo né coda. C’erano storie noiose, storie tristi che mi facevano venire le lacrime agli occhi, storie strampalate al limite del verosimile. Cionondimeno io ascoltavo attentamente, con tutta la serietà di cui ero capace.
Per qualche ignota ragione, ognuno aveva qualcosa che non vedeva l’ora di dire a qualcun altro, o di gridare al mondo intero. Mi facevano l’effetto di un branco di scimmie ammassate in uno scatolone. Una alla volta le tiravo fuori, le spazzolavo bene, davo loro una pacca sul sedere e le mandavo libere a scorrazzare nei campi. Dove andassero dopo, non ne avevo la minima idea. Probabilmente a rosicchiare ghiande fino alla fine dei loro giorni. Era il loro destino, dopotutto.
A essere sincero, era un lavoro faticoso che in cambio non dava quasi nulla. Quando ci ripenso, mi dico che se quell’anno avessero indetto un concorso mondiale per «chi sa ascoltare gli altri con piú attenzione», lo avrei vinto alla grande, senza contestazioni di sorta. E in premio avrei ricevuto forse una scatola di fiammiferi.
Tra i miei interlocutori, c’era un tipo venuto da Saturno, e uno da Venere. Le loro storie erano davvero straordinarie. Comincerò da quello di Saturno.
– Be’, laggiú fa… fa un freddo tremendo, – mugolò. – Mi sento male solo a pensarci.
Apparteneva a non so quale gruppo politico che aveva occupato l’edificio 9 all’università. Il loro motto era «L’azione determina l’ideologia, non il contrario!» Cosa determini l’azione, nessuno gliel’aveva spiegato. Comunque fosse, nell’edificio 9 c’erano un refrigeratore d’acqua, il telefono e un impianto di riscaldamento, piú una bella sala per la musica al secondo piano, con una collezione di duemila dischi e casse A5 della Altec. In confronto all’edificio 8, ad esempio, dove stagnava un odore di latrine pubbliche, era un paradiso. Il mattino gli studenti si facevano la barba con l’acqua calda, il pomeriggio telefonavano a chi volevano, anche in capo al mondo, e quando calava la sera si riunivano per ascoltare dischi. Ragion per cui alla fine dell’autunno erano diventati tutti degli appassionati di musica classica.
Finché in un soleggiato pomeriggio di novembre, al suono dell’Estro armonico di Vivaldi sparato dalle casse a tutto volume, la terza divisione della polizia antisommossa fece irruzione nei locali. Non so quanto ci sia di vero in questa storia, ma rimane una delle leggende piú rincuoranti del ’69.
Passando con circospezione accanto alle barricate di banchi accatastati, sentivo arrivare le note della Sonata in fa minore per pianoforte di Haydn. Era un suono familiare che mi metteva nostalgia, avevo l’impressione di andare a trovare la mia ragazza lungo un sentiero bordato di fiori sul fianco della collina. Il tipo di Saturno mi offrí la sedia migliore e versò della birra tiepida in boccali presi alla facoltà di Scienze.
– In piú, la forza di gravità è t-tremenda, – fece riprendendo il discorso su Saturno. – C’è gente che s’è rotta la pianta del piede sputando una gomma da masticare. Un inferno, ti dico!
– Ma guarda… – commentai dopo qualche secondo. In quei giorni avevo a mia disposizione forse un trecento risposte irrilevanti da intercalare in una conversazione.
– E poi il so-sole è troppo piccolo. Come un mandarino posato in mezzo a un campo da baseball. Per questo fa sempre buio, – concluse lui con un sospiro.
– Ma perché non se ne vanno via tutti? – chiesi. – Ci sono molte stelle su cui è piú facile vivere.
– Non lo so. Forse perché sono nati lí. Sí, dev’essere questa la ragione. Anche io, appena mi laureo torno su Marte. E co-costruisco un paese fantastico! Sí, fa-faccio la rivoluzione.
In ogni caso, a me piaceva sentir parlare di posti lontani. Mi ero fatto una bella scorta di questo genere di descrizioni, come un orso prima di andare in letargo. Mi bastava chiudere gli occhi, per veder sorgere strade e formarsi file di case, per sentire la gente parlare. Percepivo le ondulazioni lente e costanti delle voci di persone lontane, persone che probabilmente non avrei mai incontrato.
Anche Naoko mi raccontava spesso di lei. Ricordo ogni parola che mi ha detto.
– Non saprei proprio come chiamare quel posto, – esordí con un sorriso imbarazzato. In un angolo soleggiato nel lounge dell’università, teneva i gomiti sul tavolo e il mento sulle mani. Attesi che proseguisse. Lei parlava sempre lentamente, cercando le parole giuste.
Eravamo seduti a un tavolo in plastica rossa, uno di fronte all’altra, un bicchiere di carta pieno di mozziconi di sigaretta fra noi. I raggi del sole che entravano da un’alta finestra dividevano il ripiano del tavolo in due zone nettamente separate, una buia e una illuminata, come in un quadro di Rubens. La mia mano destra era nell’ombra, la sinistra nella luce.
Avevamo vent’anni, nella primavera del ’69. Nel lounge, affollato al punto che non si riusciva quasi a camminare, c’era un andirivieni di matricole che calzavano scarpe nuove di zecca, portavano sotto il braccio guide ai corsi nuove di zecca, nella testa avevano cervelli nuovi di zecca. Studenti che si urtavano di continuo gli uni con gli altri, scambiandosi saluti o insulti, ci passavano accanto.
– In ogni caso, non la si può nemmeno definire una città, – proseguí lei. – C’è una lunga via tutta dritta, e la stazione. Una stazioncina che nei giorni di pioggia il capotreno rischia di non vedere.
Annuii. Poi restammo entrambi in silenzio per una trentina di secondi, a guardare distrattamente il fumo delle sigarette che faceva giravolte nei raggi di sole.
– E c’è sempre un cane che va su e giú per il marciapiede, da un’estremità all’altra. Quel genere di stazione insomma. Hai presente?
Feci cenno di sí.
– Appena esci c’è una piccola rotatoria, e la fermata degli autobus. Alcuni negozi, piccole botteghe polverose. Di fronte ci sono dei giardinetti, con solo uno scivolo e tre altalene.
– E il quadrato di sabbia?
– Il quadrato di sabbia? – ripeté lei. Cercò bene nella memoria, poi annuí: – Sí, c’è.
Tacemmo di nuovo. Spensi scrupolosamente il mozzicone della mia sigaretta nel bicchiere di carta.
– Una città di una noia mortale. Non riesco a immaginare per quale motivo abbiano costruito un posto cosí noioso.
– Dio si rivela sotto forme diverse, – le dissi.
Naoko scosse la testa e sorrise. Era il genere di sorriso che hanno spesso le studentesse brave a scuola, ma per qualche strana ragione mi rimase a lungo impresso nella mente. Come quello del Gatto del Cheshire in Alice nel Paese delle Meraviglie.
Oltretutto, avevo una voglia tremenda di incontrare quel cane che camminava lungo il marciapiede della stazione.
Quattro anni dopo, nel maggio del ’73, andai in quella stazione da solo. Unicamente per vedere quel cane. Per l’occasione mi feci la barba, misi una cravatta per la prima volta in sei mesi e tirai fuori le mie scarpe in cordovan.
Scendendo dal treno locale – due tristi vagoni che sembravano sul punto di sfasciarsi da un momento all’altro –, la prima cosa che mi colpí fu l’odore familiare dell’erba nei campi. L’odore di antichi picnic. Il vento di maggio mi portava piú di un ricordo… Se alzavo il viso e tendevo le orecchie, potevo persino sentire il verso delle allodole.
Feci un lungo sbadiglio, mi sedetti su una panchina della stazione a fumare una sigaretta, annoiato. L’energia provata quel mattino presto uscendo di casa era già svanita. Tutto era un’eterna ripetizione di qualcos’altro, o perlomeno cosí mi sembrava. Una sensazione di déjà vu ogni volta piú sgradevole.
C’era stato un tempo in cui vivevo con alcuni amici e dormivamo tutti insieme. All’alba, qualcuno mi camminava sempre sulla faccia. E invariabilmente diceva: «Oh, scusa tanto!» Poi lo sentivo orinare. Sempre la stessa cosa.
Allentai la cravatta, e con la sigaretta fra le labbra strofinai sul cemento del marciapiede le suole delle scarpe, cui non avevo ancora fatto l’abitudine. Per lenire il male ai piedi. Non era un dolore insopportabile, ma mi dava la spiacevole sensazione che il mio corpo fosse smembrato.
Il cane non si vedeva.
La spiacevole sensazione di essere smembrato…
Ogni tanto mi succede. Mi sento come se fossi stato messo insieme coi pezzi di due puzzle diversi. In quei casi, butto giú un bel bicchiere di whisky e me ne vado dritto a nanna. Per svegliarmi il mattino dopo in condizioni anche peggiori. Sempre la stessa cosa.
Quando mi svegliai, mi ritrovai fra due gemelle. Quel genere di cose mi erano già accadute diverse volte, ma una gemella per parte, era una novità assoluta. Tutte e due serenamente addormentate, il naso contro la mia spalla. Era domenica, una bella mattina di sole.
A un certo punto aprirono gli occhi praticamente nello stesso momento, si infilarono con qualche contorcimento le magliette e i jeans che la sera prima avevano buttato sotto il letto, poi, senza dire una parola, andarono in cucina, prepararono il caffè e dei toast, tirarono fuori dal frigo il burro e misero tutto sul tavolo. Come se fossero a casa loro. Al di là della finestra, degli uccellini di cui non sapevo il nome si erano appollaiati sulla rete del campo da golf e si scambiavano un fuoco di fila di cinguettii.
– Come vi chiamate? – chiesi. Dopo la sbornia della sera prima, mi sentivo scoppiare la testa.
– Non è che valgano granché, i nostri nomi, – disse la ragazza seduta a destra.
– No, sono insignificanti, – confermò quella a sinistra. – Sai com’è, no?
– Già… – dissi.
Mi sedetti di fronte a loro, e insieme ci servimmo di toast e caffè. Il caffè era davvero ottimo.
– Ti crea problemi, se non abbiamo un nome? – chiese una delle due.
– Mah, voi che ne dite?
Le ragazze ci pensarono un po’ su.
– Senti, se proprio ti servono dei nomi, dacceli tu, qualcosa che ti sembri adatto, – suggerí l’altra.
– Dei nomi che ti piacciano.
Parlavano sempre a turno, come in fase di controllo di un impianto stereo. Il mio mal di testa andava peggiorando.
– Ad esempio? – chiesi.
– Destra e Sinistra, – disse una.
– Verticale e Orizzontale, – disse l’altra.
– Sopra e Sotto.
– Recto e Verso.
– Est e Ovest.
– Entrata e Uscita, – proposi alla fine io, per non essere da meno. Le ragazze si guardarono e risero contente.
Se c’è un’entrata, c’è anche un’uscita. La maggior parte delle cose funziona cosí. Le cassette delle lettere, gli aspirapolvere, gli zoo, i flaconi di plastica per condimenti. Non tutte le cose, però, è ovvio. Le trappole per topi, ad esempio.
Una volta piazzai una trappola per topi sotto il lavello di casa mia. Come esca misi della gomma da masticare alla menta. Dopo aver cercato in tutto l’appartamento, era l’unica cosa che assomigliava a del cibo che avessi reperito. Nella tasca del mio cappotto pesante, insieme a un biglietto del cinema strappato a metà.
La mattina del terzo giorno, un piccolo topo si infilò nella trappola. Era del colore di quei golf di cachemire che si vedono accatastati nei negozi duty free di Londra, e doveva essere molto giovane. Quindici o sedici anni, se fosse stato una persona. Un’età difficile. Un pezzo di gomma morsicato era rotolato sotto le sue zampe.
D’accordo, l’avevo catturato, ma ora cosa dovevo farne? Il mattino del quarto giorno era morto, una zampetta posteriore ancora pizzicata nella molla. Vederlo lí stecchito mi insegnò una lezione fondamentale: ogni cosa necessita di un’entrata e un’uscita.
Proprio cosí.
La ferrovia che costeggiava le colline sembrava tracciat...