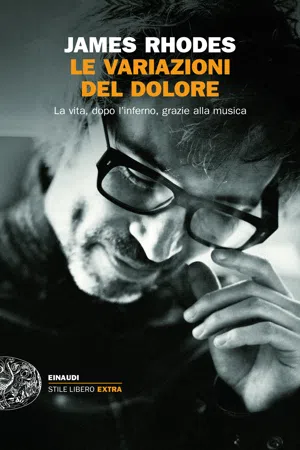![]()
Nel 1741 un facoltoso conte lottava contro i malanni e l’insonnia. Come soleva a quei tempi, prese in casa un musicista che suonasse il clavicembalo mentre lui restava sveglio tutta la notte a combattere con i propri demoni. L’equivalente barocco della radio.
Il musicista si chiamava Goldberg e il conte lo portava a prendere lezioni da J. S. Bach. In una di queste occasioni il nobiluomo disse che avrebbe gradito se Goldberg avesse avuto qualche nuovo brano da suonare, sperando che gli risollevasse il morale alle tre del mattino. Ancora dovevano inventare lo Xanax.
Fu cosí che Bach compose una delle opere per strumenti a tastiera piú potenti e imperiture mai scritte, divenuta celebre con il nome di «Variazioni Goldberg»; un’aria seguita da trenta variazioni che si concludono, tornando al punto di partenza, con la ripetizione dell’aria di apertura. Il concetto di tema e variazioni è simile a quello di un libro di racconti basato su un solo argomento unificante: un racconto d’apertura che illustra un determinato tema a cui si ricollegano i racconti successivi.
Da pianista le considero una delle opere piú frustranti, difficili, sconvolgenti, trascendenti, insidiose ed eterne che ci siano. Ma quando le ascolto hanno su di me un effetto che riesco a ottenere solo da farmaci di prim’ordine. Sono una «lectio magistralis» sul Prodigio e contengono la risposta a ogni domanda.
Nel 1955 un giovane e brillante canadese iconoclasta di nome Glenn Gould diventò uno dei primi a eseguirle al pianoforte anziché al clavicembalo. Scelse di inciderle per il suo primo album, con orrore dei discografici che volevano qualcosa di piú tradizionale. Diventò uno degli album di musica classica piú venduti di sempre e rappresenta ancora l’eccellenza cui aspirano tutti i pianisti. Senza mai arrivarci.
Sono nel mio appartamento di Maida Vale. La zona cosí cosí vicino a Harrow Road, dove urlano ai bambini e si drogano di Tropicana e fiocchi d’avena. Ho perso la mia bellissima casa nella parte elegante (Randolph Avenue, W9, va da sé) quando è finito il mio matrimonio: duecento metri quadri con uno Steinway a coda nuovo nuovo, un grande giardino, quattro cessi (non dite niente), due piani e l’imprescindibile frigorifero Smeg.
A onor del vero c’erano anche le macchie di sangue sulla moquette, le pareti rimbombavano di urla rabbiose e si respirava il tanfo del tedio, impossibile da togliere a colpi di deodorante. Casa mia adesso è piccola ma con tutte le sue cosine a posto: un solo bagno, niente giardino, un pianoforte verticale giapponese un po’ scalcinato e il profumo infinitamente piú piacevole della speranza e di una possibile redenzione.
Sono qui, tra registi, produttori, una troupe televisiva, dirigenti di Channel 4 e chi piú ne ha piú ne metta, insieme a Hattie, la mia ragazza, mia madre Georgina, il mio manager Denis, e Matthew, il mio migliore amico. Queste quattro persone mi sono state accanto fin dall’inizio, mia madre nel vero senso della parola, gli altri in senso cosmico, o se non altro da parecchi anni.
Sono la mia spina dorsale. Il mio mondo. Insieme a mio figlio, di cui avverto l’assenza in maniera straziante, sono le splendide forze che guidano la mia vita e rappresentano il motivo piú forte per restare vivo nei momenti bui.
Siamo in salotto, con i cartoni della pizza sparsi per terra, pronti ad assistere al mio primo programma televisivo su Channel 4: James Rhodes: Notes from the Inside. È un gran momento per me. Anche per gli altri, credo. Ma per me, che non dovrei essere affatto qui, non si tratta solo di «Mamma, guardami, sono in televisione!», la malattia venerea che ci è stata attaccata dall’Isola dei famosi, il Grande Fratello o Piers Morgan mettendocelo ripetutamente nel culo attraverso i mezzi d’informazione di tutto il pianeta.
Sono quasi sei anni esatti che mi hanno dimesso da un ospedale psichiatrico.
Sono uscito dall’ultima casa di cura nel 2007, strafatto di farmaci, senza un lavoro né un agente, né album né concerti né soldi né dignità. E adesso sto per comparire di fronte a un milione di spettatori previsti, nella fascia di massimo ascolto, in un documentario di Channel 4 con il mio nome nei titoli di testa. Per cui sí, a parte il broncio obbligatorio da vittima sdegnata che si sente nel giusto, è una cosa grossa.
Soprattutto perché poteva benissimo venire fuori un documentario di Channel 5 dal titolo: Ho mangiato il mio pene per non farmi mai piú rapire dagli alieni. Poteva benissimo essere una sequenza girata dalle telecamere a circuito chiuso di un episodio di Crimewatch. Invece no. È qualcosa di brillante, sincero, imbarazzante e scomodo. Come un primo appuntamento, quando ti abbandoni a troppe confidenze ma te ne freghi perché lei è una gnocca stratosferica e vorresti entrarle dentro e morire nell’attimo stesso in cui la conosci.
Abbiamo girato il film partendo dalla premessa che la musica può guarire. Offre una possibilità di riscatto. È una delle poche cose (non chimiche) che riesce a farsi strada nel cuore e nella mente con effetti davvero benefici. E cosí prendo un enorme Steinway modello D (il migliore in assoluto, centoventimila sterline e cinquecento chili) e lo porto in un reparto psichiatrico, incontro quattro pazienti schizofrenici e, dopo una breve chiacchierata, suono per ciascuno di loro. Loro si sentono meglio, io metto su un’aria assorta e tutti insieme partiamo alla scoperta di noi stessi e approdiamo in un luogo migliore.
E fin qui siamo nel sogno proibito del dirigente televisivo: da vomito.
Ma è un film potente. Consigliato da tutti i quotidiani, commovente senza essere strappalacrime come alla tivú commerciale. Il suo punto di forza, a quanto scrivono, è che non mi limito a presentare il documentario ed esibirmi al pianoforte. Tutto assume una dimensione particolarmente struggente (parole loro) perché anch’io sono stato internato e ho passato diversi mesi nei reparti psichiatrici. I giornali ci sguazzano nella merda della vittima-che-ce-l’ha-fatta. Da parte mia, ci vado a nozze. Farò tutta la pubblicità possibile. Darò interviste alla radio e alla televisione, comparirò su tutti i paginoni centrali e le riviste.
E mentre il fenomeno monta, userò la mia storia e il mio modestissimo talento per vendere album, aiutare le organizzazioni benefiche, andare in tournée, in televisione e cercare di cambiare le cose per quelli che non hanno voce. Che sono alle prese con i sintomi e le situazioni piú buie e disperate, che vengono ignorati, sminuiti e sono soli, sperduti, isolati. Quelli che vedete trascinarsi a capo chino, con lo sguardo spento, chiusi nel loro piccolo mondo, inascoltati e costretti in un angolo terribile e silenzioso.
Ma userò la mia storia anche per me stesso. La userò per fare soldi e comprare stronzate che non mi servono. Per compiere un salto di qualità. Guadagnare visibilità e ritrovarmi al centro dell’attenzione. La mia testa dice che ne ho bisogno. Che sono affamato di queste cose. Perché in fondo credo ci sia una vaghissima possibilità che il successo (commerciale), insieme all’attenzione, risolva finalmente le mie magagne.
In caso contrario andrò a Las Vegas, spenderò una quantità oscena di soldi con una rapidità ancora piú oscena e poi mi farò saltare le cervella.
Guardiamo il documentario tutti insieme. Mi sento esposto, a disagio. È come ascoltare per un’ora la propria voce su una segreteria telefonica dentro una sala gremita di spettatori. Mi sento nudo. È incredibile vedere il tuo nome al primo posto nei trending topic su Twitter mentre vieni sommerso da migliaia di commenti, messaggi, tweet, aggiornamenti Facebook, tutti su di te, che ti fanno venire voglia di stare solo e al sicuro dentro una cella imbottita. È il rovescio della medaglia per noi stronzi vogliosi di attenzione – continuiamo a urlare «guardatemi» e poi quando ci dànno retta entriamo in crisi, ci spaventiamo e ci lamentiamo. Puntate i riflettori su chi agisce con dei secondi fini, di solito vorrà strisciare via per la vergogna.
Fila tutto liscio nel mio disordinato salottino. Ci mancherebbe altro. Mangiamo. Si complimentano con me perché cosí fanno quelli che sanno stare al mondo, dopodiché congedo tutti quanti tranne Hattie e me ne vado a dormire.
E penso solo che alla tele sembravo un cazzone, con quei jeans della taglia sbagliata, i capelli assurdi, le mie dubbie capacità al pianoforte, il tono paraculo. Mi rammarico di non essermi preparato meglio e mi chiedo se domani mi sentirò importante quando mi riconosceranno in metropolitana. Poi mi stufo e me la prendo con me stesso e mi obbligo a pensare ai sei concerti che mi attendono di lí a dieci giorni. Svolgo la mia solita routine notturna e comincio a ripassare mentalmente ogni brano che eseguirò, battuta per battuta. Controllo tutti gli ingredienti fondamentali che compongono un concerto: memoria (riesco a osservarmi mentre suono, a vedere le mie mani che toccano tutte le note giuste?); struttura (qual è il rapporto fra una sezione e l’altra, quali sono i passaggi e i cambiamenti importanti, cosa tiene insieme il tutto?); dialogo (quale storia viene raccontata e come esprimerla nel modo migliore?); voicing (un brano contiene svariate melodie nascoste tra le note: quale scelgo, quella piú evidente o cerco altre voci piú profonde che esprimano qualcosa di nuovo?) e via di questo passo. È come avere nel cervello un cazzo di giradischi con un critico musicale incorporato che dice la sua; comincio ciascun brano dall’inizio e ogni volta che sbaglio o la memoria fa cilecca mi tocca ripartire da capo. E, trattandosi di un concerto di un’ora e un quarto, la faccenda va per le lunghe. Però ha la sua utilità, mi evita di pensare ad altre cose che, se non sto attento, mi portano su strade poco raccomandabili.
Riesco a dormire tre ore. Appena mi sveglio ce l’ho addosso. Questa cosa che è mia compagna fedele.
Esiste una droga distruttiva e pericolosa come nessun’altra, di cui raramente prendiamo atto e tantomeno parliamo. È insidiosa, dilagante, quasi un’epidemia. È la causa principale della cultura del «tutto mi è dovuto», della pigrizia e della depressione che ci circonda. È una forma d’arte, un’identità, uno stile di vita e può contenere una quantità di dolore pressoché senza limiti.
Il Vittimismo.
Il vittimismo diventa, nel giro di poco tempo, una profezia che si autoavvera. E avendolo io assecondato per tanto tempo, mi stringe in una morsa che mi imprigiona ancora di piú nell’inferno della Vittima che ho costruito con le mie mani.
Quando ero piccolo mi sono successe una serie di cose, ho subito una serie di cose, che mi hanno indotto a gestire la mia vita a partire dall’idea che l’unico e solo colpevole di ciò che disprezzo di me stesso sono io. Se avevano potuto farmi certe cose era solo perché ero sbagliato di natura. Tutta la consapevolezza, la comprensione e la gentilezza del mondo non cambieranno mai il fatto che questa è la mia verità. Lo è sempre stata e tale resterà sempre.
Chiedetelo a chiunque abbia subito uno stupro. Se vi risponde in un altro modo racconta solo bugie.
Le vittime conoscono il lieto fine solo in uno squallido centro massaggi di Camden. Non riusciamo a uscire dal tunnel. Ci vergogniamo, siamo arrabbiati, spauriti, e la colpa è solo nostra.
Quel mercoledí, mentre mi guardavo alla televisione seduto nel mio salottino di merda e vedevo solo un mega coglione odioso, mi sono accorto che non è cambiato proprio niente. A trentotto anni suonati ho ancora dentro, come molti di noi, un buco nero che niente e nessuno sembra in grado di riempire. Dico molti di noi perché, be’, guardatevi intorno. La nostra società, le nostre occupazioni, le strutture sociali, le abitudini, i passatempi, le dipendenze e le distrazioni si fondano su un vuoto e un’insoddisfazione endemici e smisurati. Io lo definirei odiare sé stessi.
Io odio la persona che ero e sono diventato e, da bravo bambino, mi fustigo sempre per quello che faccio e che dico. L’intolleranza, l’avidità, le pretese e la disfunzione sono diffuse a livello globale, e non riguardano piú solo una piccola e dolente fetta della società. Viviamo tutti quanti in un mondo di dolore. Magari nel lontano passato sarà stato diverso, ma ormai questa è la norma. E tutto ciò mi fa rabbia quanto il mio passato.
C’è un rancore profondo che alimenta la mia vita e nutre la bestia che mi porto dentro. Una rabbia che, malgrado i miei sforzi, mi impedisce sempre e comunque di diventare una persona migliore. La mia maledetta testa sembra dotata di vita propria, sfugge al mio controllo, non ragiona, non perdona, si rifiuta di mediare. Mi aggredisce come una furia. Da piccolo non capivo le sue parole. Ora che sono adulto mi attende ai piedi del letto e inizia a parlarmi un paio d’ore prima che mi alzi, cosí quando apro gli occhi è già in modalità furia scatenata, e mi urla che è contenta, finalmente sono sveglio, che faccio schifo, che tra poco manderò tutto a puttane, che i miei amici tramano contro di me, che non mi devo fidare di nessuno, che devo sforzarmi di salvare qualcosa della mia vita pur sapendo che è una causa persa. Sono sempre sfinito. È una specie di encefalomielite mialgica: corrosiva, dilagante, penetrante, negativa, insomma il peggio del peggio.
La sento anche in questo momento. Non mi ero reso conto di essere cosí incazzato finché non ho iniziato a scrivere questo libro. Certo che i soldi, l’attenzione e i media possono essere un’incredibile cortina fumogena. Beethoven è un mago a distrarti. Perché tante persone di successo continuano a tirare avanti, cercano di lasciarsi alle spalle i propri demoni accumulando sempre piú oggetti, sempre piú distrazioni, sempre piú rumore finché non sbattono il muso e si autodistruggono? Perché non è possibile rimuovere le cause di una rabbia potente come questa.
Per me non è difficile trovare delle ragioni esterne al dolore che mi porto dentro. Posso spiegare in maniera convincente come mai ogni persona, avvenimento, situazione o luogo della mia vita sono in qualche modo responsabili del fatto che io sia, il piú delle volte, uno stronzo infelice e pieno di rabbia.
Posso anche guardarmi dentro, puntare i riflettori su me stesso e fare festa con l’orrore incessante del senso di colpa.
Ma è come prendersela con i mulini a vento.
Mi capita anche troppo spesso di dare la colpa agli altri. A volte sono cosí folle di rabbia che mi manca il respiro. Non c’è via d’uscita, niente può calmarmi se non qualche palliativo costoso, pericoloso e di breve durata. La rabbia è la ricompensa per la mia condizione di vittima: ogni dipendenza necessita di una contropartita, e la rabbia e il senso di colpa sono ciò che mi sostiene e mi fa andare avanti ogni giorno.
Credetemi, io non vorrei essere attanagliato da questo groviglio lamentoso di autocommiserazione e odio per me stesso.
Lo so.
Chi vorrebbe essere cosí? Figuriamoci ammetterlo.
Vorrei essere umilissimo. Rendere un servizio alla musica, al mondo e ai meno fortunati di me. Essere la testimonianza del fatto che gli orrori si possono sopportare e superare. Aiutare, essere generoso, crescere e prosperare. Sentirmi leggero, libero, equilibrato e sorridere tanto.
Ma ho piú possibilità di scoparmi Rihanna.
In sostanza sono cosí arrabbiato perché so che in questa vita non c’è niente e nessuno che possa aiutarmi a uscirne completamente. Né parenti né mogli né fidanzate né strizzacervelli né iPad né pillole né amici. Lo stupro infantile è l’Everest dei traumi. Come negarlo?
Sono stato usato, scopato, spezzato, trattato come un giocattolo, violato da quando avevo sei anni. Di continuo, per moltissimo tempo.
Ecco com’è successo.
![]()
Sergej Prokof′ev è stato uno dei grandi rivoluzionari della musica. Scrisse la sua prima opera a nove anni e, ancora ragazzo, allievo del conservatorio di San Pietroburgo, si era già affermato tra i grandi «enfants terribles» della composizione grazie a lavori virtuosistici, eccessivi e dissonanti, che abbatterono le vigenti convenzioni sulla tonalità e scaraventarono con violenza la musica in una nuova direzione.
E io lo adoro anche di piú perché il «New Yor...