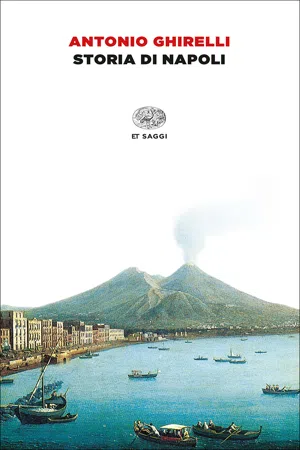![]()
![]()
La conquista spagnola segna per Napoli il trapasso di un’epoca, anzi qualcosa di piú: l’erezione di una grande muraglia tra gli italiani del Sud ed il resto della penisola. Come dirà piú tardi un monarca borbonico, dopo il 1503 il reame comincia davvero a confinare a nord con l’acqua benedetta e nelle altre tre direzioni con l’acqua salata. Vengono a mancare di colpo le premesse per lo sviluppo di una politica «italiana» quale hanno tentato gli aragonesi e, ancor piú, di quella europea che è stata vagamente abbozzata da svevi ed angioini. I rappresentanti del Re Cattolicissimo, vicerè e luogotenenti, stendono una cortina di ferro al confine settentrionale, assicurando al paese oltre due secoli di pace. All’interno, però, la contropartita di tanta tranquillità è molto pesante: all’implacabile annullamento del baronaggio come gruppo dirigente autonomo, corrispondono il piú arbitrario (e talora cervellotico) esercizio del potere, una prassi fiscale particolarmente esosa nei confronti dei poveri, l’organizzazione giudiziaria piú lenta e farraginosa del mondo.
L’esempio di nobili e militari spagnoli alimenta, a tutti i livelli sociali, il culto sfrenato delle apparenze, che con voce tipica i napoletani chiamano anche oggi «ofanità». Il formalismo dei rapporti è minuzioso fino alla pedanteria ed alimenta la religione del «pare brutto», locuzione semidialettale dietro cui si nasconde una fuga dalla realtà che, attraverso i secoli, renderà piú pigra l’evoluzione della piccola e media borghesia, sempre piú nevrotica la sua diffidenza verso la democrazia. Nel periodo viceregnale, la disputa sui pregi e sulle prerogative esteriori assume forme grottesche: basta l’altezza una panca in chiesa o di una sedia a San Lorenzo per scatenare furiosi contrasti fra vicerè e cardinali, tra arcivescovi e duchi, tra nobili di piazza e baroni. La facoltà di tenere il cappello in testa o di essere costretti a cavarselo, di sedere sui guanciali o sulla nuda terra, di portare le aste del pallio durante una processione o di essere esclusi da questo onore, diventa un problema di vita o di morte perché costituisce un metro per la pubblica definizione dello stato sociale.
Per altro verso, i modelli ideologici imposti o importati dalla potenza dominante sono bigotti e retrivi, anche se non riescono a sopraffare nell’ambito delle relazioni individuali la cordialità, la mobilità d’ingegno e il beffardo scetticismo dei napoletani. L’isolamento dalle grandi correnti di pensiero nordiche e la pesante coltre dell’occupazione cagionano un ristagno culturale che durerà oltre centocinquant’anni. Nel 1547 soltanto l’insurrezione popolare eviterà l’introduzione di una variante spagnola dell’Inquisizione, particolarmente temuta per l’incremento delle delazioni e delle false testimonianze. Esattamente un secolo piú tardi, soltanto la furiosa rivolta di Masaniello instillerà nei vicerè un certo salutare terrore nei rispetti della plebe, socchiudendo lo spiraglio ad una lenta e prudentissima ripresa, che prenderà lena dopo la spaventosa epidemia del 1656. Per una sorta di amaro paradosso, la peste che falcidia oltre metà della popolazione, si lascia dietro una scia di effetti positivi: ritrovato, nel miracoloso recupero degli anni successivi, il gusto di vivere e di ribellarsi, Napoli costringerà i vicerè ad accettare entro certi limiti un dialogo con i nuclei intellettuali piú avanzati, in mezzo ai quali l’influenza del pensiero di Cartesio e le prime affermazioni della scienza economica – assai piú che non la personalità, gigantesca ma isolata, di Giambattista Vico – getteranno il seme della fioritura illuministica che germoglia verso la seconda metà del XVIII secolo.
Quando Carlo V, in base alla pace di Cambrai, ottiene anche l’investitura del Regno di Napoli, il suo primo rappresentante nel nuovo possesso ereditario degli Asburgo, è il famosissimo ed eccellentissimo vicerè don Pedro Álvarez de Toledo, secondo figlio del duca di Alba. Toledo, per Napoli, non è soltanto il nome di una strada ma l’inizio di un nuovo capitolo di storia. Con don Pedro, che resta in carica oltre venti lunghi ed operosi anni, dal 1532 al 1553, comincia una trasformazione radicale della città, della sua fisionomia edilizia, delle sue consuetudini di vita, dei costumi, della moralità, persino del dialetto e delle caratteristiche somatiche dei suoi abitanti. Muore, nel ventennio di don Pedro, la capitale mitologica degli angioini e degli aragonesi, lo splendido borgo di Boccaccio, l’idillio quattrocentesco delle «dolcissime aurette» o delle «onde odorose» care a Jacopo Sannazzaro; e nasce, viva, febbrile e verminosa come una ferita, la metropoli moderna che ancora oggi conosciamo. Il mezzo secolo iniziale dell’occupazione spagnola, concentra nelle mura urbane e nei primi borghi che vengono nascendo fuori porta, una popolazione sempre piú numerosa e fitta. L’indice demografico, già elevato prima dell’epidemia del 1527, crescerà ancora dopo la peste del 1656 che pure falcidia una popolazione di 350 000 anime.
Da quando il principe di Orange ha annientato la potenza dei baroni di obbedienza francese, con il principe di Salerno alla testa, per punirli dell’appoggio concesso a Lautrec, la feudalità ha ricevuto un colpo mortale. I baroni, dopo aver accolto «in caruso» e cioè a capo umilmente scoperto la visita di Carlo V nel 1535, si avviano a diventare in gran parte semplici proprietari terrieri, che per giunta vivranno di rendita lontano dai feudi e dissiperanno gli averi in un’insensata smania di rivaleggiare per lusso e magnificenza con i maggiori esponenti dell’apparato spagnolo, politici e militari, corrivi a loro volta a lasciarsi corrompere senza scrupoli per mantenersi all’altezza della situazione. Insieme con le dure condizioni della campagna e con la costante minaccia di incursioni barbaresche sulla costa, il trasferimento di grandi signori nella capitale concorre ad accelerare l’inurbamento di migliaia e migliaia di provinciali, servitori, artigiani, commercianti, curiali, che vengono ad infoltire le file del popolo, mentre nei bassifondi della società pullula una plebe miserrima e pittoresca, disperata e violenta verso cui, come sostiene Croce, popolani e nobili non nutrono altri sentimenti che di paura commista a disprezzo.
Ad aggravare le difficoltà igieniche ed economiche di questo sottoproletariato, interverrà nel 1566 il drastico divieto di edificare fuori delle mura, che sarà assurdamente mantenuto in vita fino al 1716. In questa cerchia resta chiusa, come in una specie di crudele riserva che è la sua stessa miseria, un’immensa mandria di esseri umani dei quali si prendono cura spirituale soltanto i preti, i frati e le monache. Chiese e conventi, infatti, continuano a proliferare. Nei ceti intermedi, l’insensibilità sociale è ancora piú accentuata: i legulei arricchiscono vendendo «fole» ai clienti e dànno la scalata alle magistrature; i mercanti accumulano patrimoni nel supremo intento di acquistare patenti di nobiltà che li renderanno, almeno formalmente, simili ai baroni e ai grandi di Spagna.
Don Pedro di Toledo tiene in pugno con lucida energia questa brulicante massa di uomini e di interessi. Privo di slanci romantici, sta tuttavia piuttosto dalla parte dei vassalli che dei baroni, contro i quali emana una serie di prammatiche intese a combattere gli abusi nell’esercizio della giustizia e del commercio, nonché le usurpazioni cui si sono abbandonati sui demani comunali e statali. Gli effetti dell’intervento del vicerè sono superficiali e provvisori, perché la corruzione è diffusissima tra i magistrati ed i rapporti di forza sono irreversibili, soprattutto in periferia, ma le intenzioni sembrano buone. Nella capitale, don Pedro scatena una dura offensiva contro ladri e briganti, i cosiddetti «campeadores» che terrorizzano la città, assaltano i viandanti isolati, violentano fanciulle, depredano le abitazioni private, penetrandovi spesso mediante lunghe scale. La repressione contro i «campeadores» o i «compagnoni», altra genia di ribaldi che preannuncia la camorra, viene condotta senza troppi scrupoli legalitari: si proclama spesso il coprifuoco; la Vicaria, il tribunale installato nei locali di Castel Capuano e debitamente rinforzato, lavora a tempo pieno irrogando galera, tortura, pena di morte, tanto che in diciotto anni finiscono sulla forca ben 18 000 furfanti indigeni, alla rispettabile media di mille impiccati all’anno.
Meno severa, purtroppo, è la giustizia del vicerè nei confronti dei suoi connazionali dell’esercito, che stabiliscono con la plebe napoletana rapporti di avida e feroce promiscuità, contagiandoli di tutti i difetti spagnoleschi (turpiloquio e superstizione compresi) e di tutte le loro sozze malattie, taglieggiandoli, ricattandoli, compiendo innominabili atti «in perjuycio de la honestad y castidad feminil», acconciandosi volentieri a vivere alle spalle di prostitute e signore del popolo grasso. Il costume, che nell’epoca è abbastanza diffuso in Europa, lascerà a Napoli una gustosa traccia persino nel dialetto. Partendo dalla considerazione che l’arma piú diffusa nell’esercito di occupazione è l’alabarda, «appuggià ’a libbarda» rimarrà sino ai nostri giorni l’equivalente di mangiare a spese di altri e l’«alibbardiere» sarà appunto il cinico sfruttatore della generosità altrui, femminile o maschile che sia. Beninteso non tutti i soldati spagnoli trovano signore disposte ad invitarli a pranzo o cittadini rassegnati a subire le loro prepotenze: è piuttosto facile, anzi, scoprirne qualcuno agonizzante in uno dei mille sordidi vicoli della città, con una misericordia piantata tra le scapole, senza che sia possibile accertare la provenienza di quell’omaggio, anche perché l’omertà imposta dalla nascente camorra leva tra popolazione e polizia un muro di impenetrabile silenzio.
Dove il duca scrive una pagina indelebile nella storia di Napoli è nell’opera di abbellimento della capitale ed in particolare della zona che tuttora ne costituisce il centro. Nel gennaio 1533, il vicerè convoca in casa dell’abate Carafa, a Chiaia, oggi palazzo Cellammare, gli eletti della città ed i «deputati della pecunia», per deplorare a nome di Carlo V lo stato pietoso in cui si trovano le strade e i vichi «di sí nobile città», sostenere l’opportunità di restaurare le mura e sostituire «al vecchio costume delle selci, l’ammattonamento». Don Pedro si preoccupa anche dell’insalubrità e dei pericoli che si annidano tra «supportici» e «pennate», e suggerisce di raccogliere in un solo edificio i diversi tribunali sparsi ai quattro angoli della città. Dalla riunione di casa Carafa, nasce un concreto piano di risanamento edilizio e di bonifica igienica; la nuova murazione, dettata da necessità militari e realizzata nel giro di quattordici anni, allaccia Port’Alba e Costantinopoli al castello di Sant’Elmo ed al borgo di Chiaia, attraverso grandi strade che ancora oggi costituiscono l’ossatura delle comunicazioni cittadine: via dell’Infrascata, verso l’Arenella e Antignano; via Santa Lucia verso Pizzofalcone; e finalmente, sul tracciato dell’antico fosso aragonese, «la nuova strada, detta appunto di Toledo, che ben presto sarebbe diventata il ganglio vitale della città, l’amore e il vanto dei cittadini». Tra via Toledo e le «ubertose pendici» di Sant’Elmo e di San Carlo delle Mortelle, la collina si popola via via di conventi, case e soprattutto caserme spagnole, i cosiddetti «quartieri» che, insieme con la chiesa di Montecalvario, definiranno il nome e la fama piuttosto equivoca della zona, «’ncoppa ’e Quartieri». Nonostante la prammatica del 1566 che vieta l’edificazione di suolo fuori della cerchia urbana, la prepotente spinta demografica va formando nuclei abitati a Mergellina, ai Vergini, all’Avvocata, a Sant’Antonio Abate, a Loreto e in altri borghi, che piú tardi costituiranno parte integrante della città.
Per finanziare l’opera di pavimentazione delle principali arterie, don Pedro decide di imporre una gabella sulla vendita del vino e quando, a nome del sedile del popolo, un certo Fucillo tenta di organizzare l’opposizione, lo fa arrestare ed impiccare ordinando che il cadavere sia esposto ad una finestra della Vicaria. Meno agevole riesce la prova di forza qualche anno piú tardi, allorché Carlo V chiede una contribuzione di ben tre milioni di scudi d’oro per finanziare le proprie operazioni belliche e il Parlamento dei feudatari napoletani resiste tenacemente all’imperiale stoccata. D’accordo con il nuovo eletto del popolo, Gregorio Rosso, i nobili cercano di ottenere la destituzione del vicerè, ma don Pedro sostituisce il Rosso con un notabile meno intransigente, si giova del favore di cui gode presso buona parte della popolazione e rimane tranquillamente in carica, anche se poi finirà per accontentarsi di metà della somma richiesta.
Il successo pungola il duca verso nuovi traguardi: nel 1539 riesce a maritare la sua secondogenita Eleonora con il duca di Toscana, Cosimo; nello stesso anno inaugura una nuova, splendida villa a Pozzuoli, costruita in parte per amore del fasto, in parte per ragioni politiche. Una serie di fenomeni bradisistici e ripetute, paurose scosse di terremoto hanno sconvolto la costa tra Pozzuoli e il lago di Lucrino, con eruzioni cosí violente da formare una collina, il Monte Nuovo, e da trascinare la cenere con l’aiuto del vento fino alle coste della Calabria. Il vicerè si installa in villa per placare le ansie della popolazione, ma vi ha preso appena alloggio che deve affrontare il problema degli ebrei. Si tratta di una cospicua ed influente colonia, costituita in buona parte da famiglie bandite di Spagna nel 1493 e che a Napoli si è conquistata uno spazio economico ed una certa popolarità grazie all’esercizio di prestiti su pegno, pratica disgraziatamente indispensabile in una città caratterizzata da cosí diffusa miseria. Gli usurai israeliti devono essere migliori della loro fama se è vero che, quando Carlo V ingiunge da Madrid al suo vicerè di bandirli anche dall’Italia meridionale, l’opinione pubblica insorge. Nondimeno gli ordini dell’imperatore non ammettono deroghe: don Pedro li esegue fedelmente tra il 1539 ed il 1540, anche se si trova senza scampo di fronte alla necessità di risolvere in altro modo il problema del credito ai poveri. In mancanza degli ebrei, l’unico rimedio possibile è l’appoggio ai piccoli gruppi di benefattori privati che prestano denaro su pegno senza interesse, per puro spirito di carità; fino a quando, nel luglio 1549, i crediti del Monte di Pietà sono dichiarati privilegiati rispetto ad ogni altro, fino all’ammontare di quattro ducati. È la premessa per un cospicuo sviluppo dell’istituto che molto piú tardi, attraverso complesse vicende ed intricate fusioni, diventerà il Banco di Napoli.
L’inflessibile governo di Toledo riesce insopportabile soprattutto ai baroni, ai nobili di piazza ed a quanti cittadini soffrono per la compressione di tutti i privilegi, le autonomie ed anche le libertà locali. Ma don Pedro, che avverte questa sorda resistenza, calca la mano mescolando a preoccupazioni di ordine religioso un preciso e duro disegno politico: nel 1543 sopprime l’Accademia Pontaniana, i cui maggiori esponenti sono sospetti di eresia valdese; nel 1547 decide e appoggia con tutto il peso della sua autorità l’introduzione dell’Inquisizione «alla maniera di Spagna», in forma cioè assai piú esasperata e fiscale di quanto non siano state applicate finora le sanzioni del Santo Ufficio. Questo però è un passo falso, un giro di vite troppo stretto. Il 12 maggio, mentre don Pedro è a Pozzuoli, il «breve» che inasprisce la pratica inquisitoria, affidandola ai padri domenicani, viene affisso alla porta del duomo. Ne nascono furiosi tumulti, nel corso dei quali la «carta» viene «stracciata et levata via», mentre i birri mettono le mani sul capo della rivolta, un ufficiale municipale sorrentino che si chiama Tommaso Anello. L’arresto di questo primo Masaniello inasprisce gli animi anziché ammansirli. Tre gentiluomini, Cesare Mormile, Giovanni di Sessa e Ferrante Carafa, si mettono alla testa del popolo, «uomini donne fanciulli, gente di ogni affare», e costringono il reggente della Vicaria, Geronimo Fonseca, ad ordinare la scarcerazione di Tommaso Anello che viene caricato dal Carafa in groppa al suo cavallo e portato in trionfale corteo per tutta la città. Il 17 maggio, mentre i capitani del popolo destituiscono l’eletto Domenico Terracina, accusandolo di collusione con il duca di Toledo, questi invia loro una lettera in cui sostiene spudoratamente di essere estraneo all’inasprimento dell’Inquisizione e risoluto a combatterlo. È una ritirata clamorosa che tuttavia non basta a riportare l’ordine nella capitale.
Due settimane piú tardi, un altro episodio rinfocola l’indignazione popolare. Nel passare dinanzi al seggio di Portanova, un cittadino che viene condotto in prigione per debiti, chiede aiuto ad un gruppo di gentiluomini e, approfittando della confusione, taglia la corda. Inasprito dalle recenti disavventure, don Pedro ordina la cattura di due gentiluomini del seggio con un loro servitore, li fa tradurre a Castel Nuovo ed ingiunge che vengano scannati «ginocchioni in terra», senza processo. L’indomani, scoppia la fine del mondo: due alabardieri della guardia vicereale sono trucidati e il consiglio comunale decide di non riconoscere piú l’autorità del duca, rinchiuso prudentemente nel castello. La solidarietà di tutti i cittadini trova conferma in un corteo di nobili e plebei che, preceduti da un enorme crocefisso, percorrono le strade principali al grido di «Unione, Unione, in servigio di Dio, dell’imperatore e della città». Il 26, mentre i sedili decidono di spedire il principe di Salerno da Carlo V per chiedere il richiamo del vicerè, appaiono le prime barricate e tuonano i primi colpi di cannone. Soldati spagnoli sono fatti a pezzi negli scontri armati, defenestrati o annegati nei pozzi; incendi e saccheggi sconvolgono la vita della popolazione, che tuttavia si lascia amministrare disciplinatamente dai propri deputati e mantiene l’assedio alle fortezze spagnole fino al 12 agosto.
A questo punto, la rivolta si estingue e con essa si spegne l’ultimo moto di indipendenza della città. Don Pedro, rassicurato dai messi che a sua volta ha spedito all’imperatore, annuncia ai deputati che Carlo si è persuaso essere l’insurrezione rivolta contro il Santo Ufficio e non contro il trono, decide di perdonare agli insorti (salvo i capi) e concede alla città il titolo di fedelissima, beninteso a condizione che cessi ogni atto di ostilità. Il bilancio dei tumulti comprende 600 morti e 112 feriti da parte spagnola, 200 morti e 100 feriti da parte napoletana, senza contare l’incendio di molti edifici e la totale distruzione di rua Catalana, quartier generale delle truppe vicereali. Dei capi della rivolta il solo Giovan Vincenzo Brancaccio finisce giustiziato mentre la «fedelissima» città di Napoli è condannata a risarcire i danni all’autorità di occupazione nella misura di centomila ducati. Sei anni dopo, il 26 novembre 1553, il primo «autodafè» viene celebrato dinanzi al duomo, senza che ne segua neppure una blanda protesta. A quell’epoca, però, don Pedro è già morto da quasi un anno lasciandosi alle spalle uno strascico di accuse piuttosto serie: brutale disprezzo per la legalità, disinvoltura amministrativa, debiti di gioco e trasporto per le belle donne. Nessuno, d’altro canto, disconosce l’efficienza del suo governo e l’inflessibile fedeltà agli interessi del suo sovrano. In città egli ha cercato di inquadrare in una severa cornice sia i rapporti tra i vari ceti, sia i costumi estrosi di una società «bene» che si diletta solo di rumorosi concerti notturni, rischiose avventure d’amore e cruenti duelli.
A reprimere gli eccessi del patriziato, il duca ha messo meno energia che nelle crociate contro le piaghe che affliggono il Regno: le false testimonianze e le delazioni, l’usura, la prostituzione, e su un piano piú ampio il brigantaggio, la minaccia dei turchi, o l’insidia delle terre paludose. I risultati sono mediocri perché il vicerè ha realizzato una pura operazione di vertice, tagliando le unghie ai baroni senza preoccuparsi di rafforzare contemporaneamente l’unico strumento alternativo al loro predominio, che potrebbe essere il Seggio del Popolo, il cui eletto a partire dal 1548 è scelto addirittura con un «biglietto» dello stesso vicerè. Ovviamente i napoletani recano la loro parte di corresponsabilità: i plebei, perché si rassegnano alla condizione servile anche se proclamano che «qua spiritiamo alla fame»; i nobili, perché si estraneano gradualmente, salvo sporadiche eccezioni, non solo dalla lotta politica, ma anche dagli impegni militari e dal processo di produzione, sprofondando nell’ozio, nell’ignoranza, ed in una bonaria quanto generica cordialità verso il prossimo; il ceto medio, infine, composto in gran parte del popolo grasso, dei curiali, degli appaltatori di gabelle, perché si concentra sul momento economico della sua ascesa senza alcuna prospettiva spirituale o ideologica, lasciando per giunta le posizioni-chiave (commercio, industria e banche) in mano agli stranieri. Anche nei fondi agrari, avvocati ed agenti prosperano alle spalle dei feudatari, emigrati nella capitale, ma non fanno avanzare di un passo la condizione delle masse contadine. Per quasi tutto il XVI secolo, uno scarso contributo viene anche dagli ambienti culturali ed artistici. La tradizione rinascimentale continua con una certa sensuale fiacchezza, languono gli studi politici e morali, gli storici sembrano incapaci di documentare le proprie alate ed astratte argomentazioni, le stesse alte testimonianze di Bernardino Telesio e Giordano Bruno, duramente perseguitati, restano senza eco perché manca ogni collegamento tra le avanguardie intellettuali e la cultura ufficiale, verbosa e bigotta. A scuotere gli spiriti bucolici di un ambiente nel quale il sospetto viceregnale ha liquidato perfino le accademie, non basta neppure uno spirito fantastico come quello di Giambattista Della Porta. Filosofo, scienziato, scrittore di teatro, fondatore dell’Accademia dei Segreti, Della Porta sfida un processo per stregoneria ed alterna con geniale irrequietezza gli studi di «magia naturale» con quelli di fisica e chimica, i trattati di chiromanzia con una fitta produzione di commedie e, nel loro contesto, le reminiscenze plautine con le intenzioni moralistiche ed una stravagante passionalità. Piú pericolosa della sua solitaria testimonianza risulta la predicazione del Valdés e dell’Ochino, ma quando la diffusione delle loro idee comincia ad alimentare una allarmante problematica religiosa, Chiesa e Spagna si alleano per falciare l’erba sotto i piedi dei temibili sovversivi.
Per tutta la seconda metà del Cinquecento i successori di Toledo restano molto al disotto del suo livello di governo, impegnati come sono nelle intricate vicende belliche della Spagna e nella difficile, impari battaglia contro le incursioni turche. Nell’agosto 1533, per esempio, il pirata Dragut sbarca impunemente a Capri e vi saccheggia la Certosa dando alle fiamme chiesa e convento. Un anno dopo l’imperatore, stanco e deciso al rit...