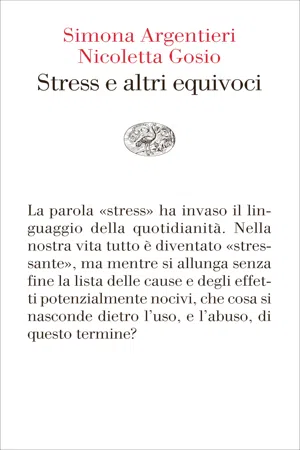![]()
In medicina.
Il termine “stress” è generosamente impiegato anche nella letteratura medica. Nei manuali, nei trattati di medicina generale e specialistica – dalla cardiologia alla dermatologia, dalle malattie autoimmuni a quelle metaboliche – è ormai consuetudine trovare un riferimento allo stress tanto stereotipato quanto generico nel paragrafo della cosiddetta etiopatogenesi, che elenca le cause e concause di ogni malattia.
In psicologia e in psichiatria, legato ad altri concetti altrettanto poliedrici ed equivocabili – adattamento, trauma, difese, somatizzazione – oltre a essere evocato di regola nella insorgenza di qualsiasi disturbo mentale (non solo ansia e depressione, ma anche dipendenze, disturbi del comportamento, disturbi dissociativi), entra direttamente a far parte delle categorie diagnostiche con i cosiddetti «disturbi post-traumatici da stress».
Sulla scia del consenso che raccoglie l’Evidence Based Psychiatry – la psichiatria basata sulle “evidenze” convalidate da questionari e cifre – entrano in campo batterie di test e scale numeriche, cui è affidata la valutazione dello stress negli studi sperimentali, in versioni sempre piú veloci e pratiche che bussano con insistenza alle porte della clinica – dove rischiano di diventare un inaridito surrogato dell’esame obiettivo e dell’anamnesi.
Il successo dell’idea di stress, e la sua diffusione nel linguaggio ambulatoriale, deriva tuttavia in massima parte dal valore attestatogli di traitd’union fra psicologia e fisiologia, nel – tutt’altro che evidente – complesso ed enigmatico campo della psicosomatica. Cosí, nel tormentato arcipelago delle affezioni al confine tra corporeo e mentale, lo stress e i suoi derivati hanno invaso subdolamente tutti i territori della medicina e della psicologia. Ben si addice al nuovo contesto quello che affermava il padre della psicopatologia generale, Karl Jaspers:
Conoscenza scientifica e abilità tecnica si trovano nella condizione di spiegare qualcosa senza nulla comprendere, a meno di non considerare compreso un fenomeno per il solo fatto che gli si è assegnato un nome1.
Quando il malessere denunciato non ha una connotazione oggettiva assoluta, il medico – a partire dai sintomi tradizionalmente noti e precisamente riscontrabili con esami di laboratorio che possano condurre a una altrettanto precisa diagnosi (bronchite, tumore, malattia infettiva...) – completa la sua ipotesi e la sua proposta di cura con una considerazione che ha piú dell’oracolare che dello scientifico: «È anche lo stress». Alibi per gli umani limiti di ignoranza delle cause e di inadeguatezza a fornire rimedi certi. Autorizzati dalla scienza ufficiale, pressoché tutti i medici, sia quelli detti di base sia gli specialisti, anche se non possiedono una specifica competenza psicologica o magari addirittura diffidano di ogni approccio psicodinamico, hanno importato la parola stress nel loro vocabolario e la usano con larghezza nei colloqui diagnostici con i pazienti.
In questo modo lo stress viene a essere una sorta di versione aggiornata di ciò che fino a non molto tempo fa si definiva, in pari semplificazione, «di natura psicologica» o «funzionale»: con alcune sostanziali differenze, e svariati equivoci, in parte vantaggiosi (al livello superficiale delle difese) e in parte controproducenti (al livello autentico dei bisogni). Nel concetto infatti, come dicevamo, è implicito il rimando a un concreto substrato organico che l’ipotesi psicogenetica, ormai storicamente datata2, non contemplava piú; allo stesso tempo – nel solito pasticcio fra stimoli, reazioni e danni – è facilitata l’attribuzione della responsabilità a un “qualcosa” di altro da sé.
In realtà, in taluni casi di disturbi inspiegabili o inspiegati, il ricorso al termine – poiché suggerisce una comune via neurobiologica della mente e del corpo, piuttosto che l’ipotesi esplicita di una concausa di ordine emotivo – può rappresentare una strategia di mediazione e consentire l’avvio di un percorso terapeutico, sia psicofarmacologico che a maggior ragione psicoterapico, altrimenti rifiutato. In genere però lo stress funziona piú come un jolly al servizio delle difese – del paziente, oltre che del curante.
Sappiamo bene quanto tale approccio riduttivo e stereotipato, che collassa in un’unica dimensione la diagnosi, l’etiologia e la patogenesi (il “cosa”, il “perché” e il “come”), faccia leva sulle resistenze sia del medico sia del paziente, orientati – in precisa collusione – a sfuggire a ogni consapevolezza dolorosa, alimentando l’illusione di soluzioni magiche e affettivamente non coinvolgenti.
Per contro, sempre piú spesso sono i pazienti stessi a suggerire al sanitario che alla radice dei disturbi c’è lo stress doloroso. A loro volta sono alla ricerca di una causa, o magari di un colpevole da accusare per i loro mali, con l’autorevole supporto della diagnosi scientifica: meno inquietante per la coscienza, meno colpevolizzante individuare una spiegazione esterna ed episodica, piuttosto che indagare un processo lungo e tortuoso che inevitabilmente rischia di coinvolgere tutta una rete di relazioni, o mettere in discussione l’illusoria certezza di possedere un totale controllo di se stessi.
A parte l’inesattezza e la genericità di tale approccio, è comunque certo che il paziente non potrà farne buon uso, poiché non capisce quale possa essere questo nesso quasi magico tra il sintomo e il suo stato d’animo; anzi, il rischio è che la viva come un’implicita accusa («è colpa tua») deresponsabilizzante per il medico e inutilizzabile da parte sua. Ed è probabile che l’ansia a fronte di tale oscura minaccia aumenterà. Né tantomeno, seppure fattori di realtà stressanti possano esercitare la loro malefica influenza sulla malattia, sarà in grado di eliminarli dalla sua vita.
Sono gli stessi meccanismi che, in un mix di preconcetti e paure, ancora oggi rendono piú accettabile e tranquillizzante la consultazione del neurologo piuttosto che dello psichiatra, quando si è «giú di nervi» o «stressati».
La tendenza spontanea della mente umana, secondo un’esigenza al tempo stesso affettiva e cognitiva, è infatti quella di attribuire un senso all’esperienza. Tendiamo cioè a costruire dei nessi di causa-effetto, a rendere intelligibile ciò che accade secondo spiegazioni semplificate, che ci difendono dalla penosa sensazione di essere in balia di eventi caotici e imprevedibili.
Per lo meno a livello esplicito, è il medico il detentore del sapere, colui al quale viene demandato il compito preliminare della diagnosi, di individuare «il male». Tuttavia, in ogni incontro fra un terapeuta e un paziente c’è sempre anche l’incontro di due teorie che devono venire a patti fra loro. Evidentemente si tratta di sistemi teorici di assai diversa dignità e credibilità; e – per di piú – modulati secondo differenti piani di coscienza.
Nella mente di chi deve curare, accanto alle teorie ufficiali, consce, frutto dello studio e della cultura professionale specifica, convivono, a livello preconscio, le “teorie private”; credenze spontanee che in modo clandestino, talora scisso, senza entrare in conflitto di coerenza con le teorie formalmente abbracciate esercitano la loro sotterranea influenza. Sono credenze sul mondo e sul corpo, sul bene e sul male, che apprendiamo in modo semplice, piú attraverso le relazioni che tramite le parole. Entrano a far parte del nostro sistema di pensiero a seconda di come siamo stati allevati, di come abbiamo ricevuto le cure primarie della mamma o della tata, le raccomandazioni sul non prendere caldo o freddo, i cibi considerati buoni e quelli ritenuti pericolosi, le regole igieniche della famiglia... E, nelle rappresentazioni di sé, nel modo di sperimentare la propria fisicità, si intrecciano ai nostri percorsi affettivi, in un codice imbevuto di valenze metaforiche e simboliche. Non di rado tali credenze non sono compatibili con il sapere ufficiale, ma convivono pacificamente nella penombra della mente. A livello inconscio, infine, si muovono le fantasie sul corpo e sui funzionamenti corporei, radicate nelle esperienze arcaiche della vita. Sensazioni di benessere e malessere, di ritmi e posture molto personali che sono difficilmente traducibili in parole.
A sua volta il paziente – anche il piú semplice e sprovveduto – arriva dal medico con un suo bagaglio di teorie consce, preconsce e inconsce, pregiudizi familiari e culturali, gusti e preclusioni alimentari che interagiranno con quelli dell’esperto fin dalle prime battute del dialogo. Ogni malato infatti – che lo espliciti o meno – correda i suoi sintomi con una ipotesi ingenua “localizzazionista” (il fegato, il colon...) e “deterministica” (il freddo, un alimento, l’ereditarietà, un contagio, e oggi sempre piú spesso lo stress) alla ricerca di un elemento causale che conferisca senso al processo morboso.
Pensiamo che l’impazienza con la quale molte volte i medici ascoltano le elucubrazioni, gli infiniti dettagli della sintomatologia e le proposte di autodiagnosi bizzarre dei pazienti, non dipenda tanto dalla incongruità, quanto dalla qualità di adesione aprioristica a un complesso di leggi che implicitamente entra in competizione con il loro. Le autoterapie, le diete autarchiche, le pozioni magiche comprate in erboristeria, il «mangiare in bianco» come rimedio universale e, di converso, la paura delle tossine, delle sostanze chimiche, del clima… sono elementi che – se il medico non si prende la briga di indagare – possono peraltro restare silenti e celati nella dimensione privata.
Dietro a quella che il modello psicologico attualmente egemone, di tipo cognitivo-comportamentale, definisce in maniera pragmatica e un po’ restrittiva la illness representation – la rappresentazione di malattia associata a schemi ideativi latenti – si agita perciò un ricco mondo personale di componenti sensoriali, emozionali, significati e fantasie, la cui comprensione costituisce una delle principali premesse alla strutturazione di un valido rapporto medico-paziente, di importanza tale da condizionare l’efficacia degli interventi e il decorso della patologia.
Non intendiamo, con tutto ciò, sostenere che sia compito di una medicina di base già oberata da richieste e sale d’attesa affollate – alla quale piuttosto, a nostro avviso, la competenza specialistica tende fin troppo a delegare valutazione e trattamento della psicopatologia – andare a fondo dei messaggi criptati e degli spazi interiori. Ma diffidare della pseudo-trasparenza della parola stress non può che giovare agli uni e agli altri, medici – generici e specialisti – e pazienti.
Il nodo psiche-soma.
Le cause e le conseguenze dello stress oscillano continuamente dal fisico allo psichico e i due livelli si intrecciano costantemente in variabili combinazioni; se l’ambizione frustrata può generare il mal di stomaco, un lavoro muscolare troppo faticoso può essere motivo di ansia oppure di sbalzi pressori. Di conseguenza, per capire e curare lo stress sarebbe necessario illuminare a giorno e unificare le interazioni tra fattori psicosociali e somatici. Eredi di una cultura plurisecolare che dalla caverna di Platone al cogito di Cartesio ha mantenuto separati in casa mondo della materia e mondo delle idee, res extensa (realtà fisica) e res cogitans (realtà psichica), ora piú che mai medicina dell’anima e medicina del corpo si adoperano con alacrità per superare le antiche e deleterie contrapposizioni, in questo caso però passandosi di mano una lucciola forse troppo ottimisticamente scambiata per lanterna in un campo tanto complesso e delicato.
A monte, incombe l’immensa questione filosofica e scientifica (che qui possiamo solo sfiorare) del rapporto fra eventi mentali ed eventi cerebrali, dalla quale discende una lunga tradizione di incontri-scontri fra medicina, psicologia e psichiatria sulle svariate ipotesi interpretative circa le connessioni fra stimoli psicologici e processi organici.
Dal canto suo la psicoanalisi, fin dalle origini, considera impossibile separare l’attività psichica non solo da quella cerebrale, ma anche da quella corporea nella sua interezza. Non possiamo prescindere, difatti, né in clinica né in teoria, da quella globalità psicofisica secondo la quale l’Io stesso, all’origine, è un “Io corporeo”: il corpo è nella mente – come schema, immagine, rappresentazione di sé – e la mente, per contro, abita il corpo in ogni sua parte – non solo nel cervello.
Quando parliamo di “psicosomatica”, però, cominciamo a navigare in acque mosse ed equivoche, al pari di quelle del nostro stress passe-partout. Il concetto, carezzato dai tempi di Ippocrate, può esprimere infatti l’idea che una patologia organica ben definita e oggettivamente riscontrabile (ad esempio un’ulcera) derivi da disturbi psicologici; viceversa, può riferirsi alle ripercussioni psichiche di uno stato corporeo (ad esempio l’ansia o la tensione che derivano – ma come potrebbe essere altrimenti? – da una colite cronica); ma piú di frequente viene adottata come formula svalutante e sbrigativa per catalogare come «malato immaginario» chi accusa sintomi fisici senza base organica riscontrabile, secondo l’accezione meno corretta ma purtroppo a tutt’oggi ancora maggiormente diffusa nella pratica clinica3.
Tutto nell’umano esperire è psicosomatico, in salute e in malattia, poiché la psiche – come insieme strutturale e funzionale – è in continua, dinamica relazione sia con l’ambiente esterno, sia con quello interno corporeo. Ma dire che mente e corpo formano un tutt’uno, non equivale ad affermare che sono la stessa cosa.
Sono molteplici dunque i modi in cui il corpo risponde alla mente e ne trascrive i messaggi, e per contro quelli in cui rispondiamo psicologicamente ai segnali e alle trasformazioni del corpo. Attraversiamo di continuo il nodo mente-corpo, o forse sarebbe meglio dire che viviamo in esso a vari livelli di consapevolezza e di integrazione e mediante costanti regolazioni dei sentimenti e dei pensieri rispetto alle esperienze somatiche, a seconda delle vicende relazionali e dei cambiamenti reali della corporeità nel corso della vita: crescita, pubertà, invecchiamento, malattia. La salute psicofisica dipende infatti dai processi di integrazione, in un costante, mobile equilibrio.
L’area di integrazione delle esperienze mentali con quelle corporee è perciò sede di tante patologie, rispetto alle quali tuttavia le capriole acrobatiche della versatile nozione di stress contribuiscono a far considerare – erroneamente – obsoleto l’invito di Freud alla prudenza dinanzi al «misterioso salto» dalla mente al corpo. Ma, nonostante l’indubbio aumento delle conoscenze, ci sono buoni motivi per non abbassare la guardia, non fosse altro perché in medicina (discorso che vale per qualsiasi scienza) i fatti dati per scontati sono continuamente rivisitati, e non di rado smentiti da acquisizioni successive.
Molti malesseri transitori o sfumati e molte sindromi, attualmente raggruppate nella controversa categoria dei cosiddetti «disturbi somatoformi» – tachicardie, asma, coliti, vertigini, cistiti… – refluiscono cosí, in assenza di palesi e macroscopiche lesioni o cause organiche, nell’area dei cosiddetti disturbi funzionali, vagamente associati a sottostanti generiche problematiche emotive.
Nella pratica clinica, sono equamente distribuiti due rischi. Il primo è quello di “interpretare troppo” le supposte dinamiche psicologiche sottostanti e di proporre ai pazienti “selvaggi” nessi di causa-effetto tra presunte fantasie inconsce rimosse e sintomi patologici del corpo, ignorando magari la presenza di indici di malattie organiche in atto. Il secondo rischio è quello opposto di imboccare la strada di inutili trafile indaginistiche e sovraccarichi farmacologici, inseguendo fantasiose entità morbose senza riconoscere la dimensione psicopatologica sotto le mentite spoglie del sintomo somatico.
Nella teoria, la psicoanalisi – al contrario della vulgata popolare che tende ad assimilarla a un nebuloso regno fatto solo di parole, parole, parole, e a dispetto di tante vecchie e ricorrenti critiche di inconsistenza e non-scientificità – è assai lontana dalle superficiali semplificazioni correnti. Basti pensare quanto all’interno del modello biopsicosociale – che in termini generici mette tutti d’accordo sulla necessità di considerare sempre l’insieme dei sistemi e dei livelli differenti di tipo biologico, psicologico e ambientale – le analisi dei meccanismi intrapsichici e relazionali condotte caso per caso siano distanti da quelle che spesso diventano banali somme di addendi o impoverite giustapposizioni dei fattori in causa. Paradossalmente è proprio lo stress che, compattando significati multipli e galleggiando sulla superficie degli eventi, finisce con l’invalidare l’abbandono del principio di causalità lineare patrocinato dal paradigma multifattoriale.
A dispetto di tante diatribe, è interessante se...