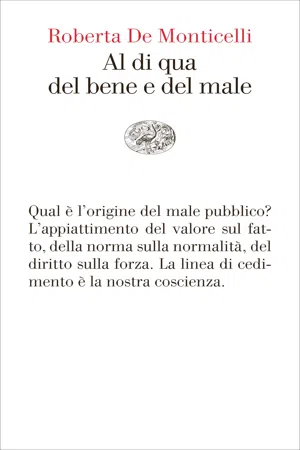![]()
La cultura, infatti, non è il terreno della verità, ma della disputa intorno alla verità.
NICOLA CHIAROMONTE
1. La “Rive Gauche” ieri e oggi.
Il capitolo precedente si chiude su una sorta di accerchiamento in cui il lettore che avvertisse in sé il temperamento del riccio si sarà forse sentito stringere, da parte della fauna filosofica che variamente rappresenta lo scetticismo assiologico. In effetti hanno prevalso in Europa le piú svariate forme di questo scetticismo: determinismi storici, realismi politici, visioni tragiche, nichilismi e fideismi ideologici hanno accompagnato quella che uno storico italiano sulla traccia di Ernst Nolte ha chiamato la guerra dei trent’anni1. E poi il periodo della guerra fredda, mentre l’epoca cosiddetta postideologica ha vissuto fondamentalmente, almeno nell’Europa continentale, di relativismo postmoderno, con la paradossale variante dell’aureola di virtú (cioè della rivendicazione di valore) di cui è parsa risplendere questa mentalità “aperta e tollerante”, contraria al fondamentalismo liberticida.
Il mutismo del riccio in noi non è, purtroppo, una favola. È il paradosso che abbiamo finora provato a descrivere, per il quale il pensiero filosofico non sembra vivere oggi all’altezza delle sue proprie migliori incarnazioni normative, e della parte migliore della civiltà che ha contribuito a creare. E questo è ancora piú particolarmente vero oggi in Italia, forse, che altrove in Europa. Di quale pensiero si nutre ai nostri giorni la «fame e sete di giustizia» che dobbiamo credere alberghi pure, come sempre ha fatto, in cuore a (molti di) quelli che oggi hanno vent’anni?
Fa davvero impressione ascoltare alcuni dei piú giovani filosofi snocciolare senza ombra di perplessità litanie sulla macchinazione globale del capitalismo, condita dagli elogi piú illiberali di quanto di peggio si trova nella politica contemporanea – che si tratti di un tiranno alawita mediorientale, ancorché sanguinario, purché ostile all’imperialismo americano, o delle pulsioni xenofobe dei leader tribali italiani piú impresentabili, purché ostili all’Unione Europea e alla sua politica economica2. Colpisce soprattutto vedere riproposti tutti gli slogan di un marxismo dottrinario, quantunque piú quarantottardo che engelsiano, con il suo corredo di «feticismo delle merci» e «mercatismo»: colpisce anche l’assoluta indifferenza per tutto ciò che la teoria politica e quella economica hanno elaborato fra il 1848 e oggi. Ma soprattutto, a proposito di voler trasformare il mondo e non soltanto contemplarlo, colpisce la volontà di ignorare del tutto la realtà dei miserevoli primati negativi, pochissimo «neoliberisti» e per niente «mercatisti», in cui l’Italia dell’illegalità e della rapina corruttiva basata sulle «grandi opere» (o su quelle meno grandi e spesso ancora piú nefaste delle amministrazioni locali) e sui loro appalti truccati si distingue.
Ma come può sembrare plausibile, ancora, a molti, l’idea di un capitalismo - potenza demoniaca, coi suoi angeli del male, la tecnica o la finanza, da cui tutto ciò che c’è di orribile dipende?
Lo abbiamo visto: l’ignoranza dell’etica pubblica non sta semplicemente nel trasgredirla, ma nell’impulso a una spiegazione globale e acquietante del male che ci porta a ignorare ciò che dipende da tutti noi, piú esattamente da tutti quelli fra i nostri comportamenti e le nostre scelte che cooperano a consolidare i modi in cui vengono distribuiti, esercitati e controllati i poteri. Certo, le conseguenze delle nostre azioni trascendono e tradiscono in generale le nostre intenzioni: ma ragionare lucidamente su questo punto è ben diverso da acquietarsi nell’idea di potenze impersonali che progettano questo e vogliono quello, ci giocano e ci illudono, con «false coscienze» che vanno ancora e sempre «smascherate»…
Come spiegare oggi ai giovani riscopritori del marxismo che questo linguaggio ha già imprigionato prima, e isterilito poi, le menti dei molti fra noi che lo mandavano a memoria nei tardi anni Sessanta? Ed eravamo già in ritardo di venti o trent’anni sull’esperienza, il dolore e il pensiero di padri e madri resistenti, e di tutti coloro che avevano provato a liberare la «mente prigioniera»3 di queste minacciose prosopopee, di queste sostanze fatte soggetti, di questi materialismi storici e dialettici, di questa “scienza” che fondava il dovere non sulla nostra libertà e sulla nostra ragione ma sulle ragioni della storia, qualunque cosa fosse questa divinità dubbia e feroce.
Ma viene il dubbio che sia proprio il postulato dell’autonomia morale possibile delle persone, e la convinzione del valore supremo di questa autonomia, che questo filone di pensiero rigetta. Perché altrimenti salvare, dell’idealismo hegeliano di cui il marxismo si nutrí, proprio la versione italiana piú illiberale, quella di Giovanni Gentile? Come fa una recente monografia su Antonio Gramsci4, ispirata forse a una forma di comunitarismo il cui tratto saliente è l’ambiguità rispetto alla fonte ultima del giudizio morale – la coscienza sensibile e cognitiva dell’individuo o il collettivo a qualche titolo portatore di superiori “ragioni”. Tornano alla mente le parole di Norberto Bobbio su Gentile:
Questa immedesimazione della politica nella morale (che era in realtà una subordinazione della morale individuale alla morale pubblica, e quindi della morale nel senso tradizionale alla politica) conduceva il Gentile a negare ogni distinzione tra la sfera dell’individuo e quella dello stato, cioè a rifiutare uno dei presupposti su cui si fonda lo stato liberale. A questa negazione egli giunse con un’altra delle formule che gli furono familiari, sostenendo che lo stato non è esterno all’individuo, ma è in interiore homine, e ciascuno, voglia o non voglia, se lo porta con sé5.
Non è, mi pare, a questa fonte che si poteva attingere per una vera «riforma intellettuale e morale» degli italiani. Colpisce constatare il largo seguito che questa nostalgia di «uomo collettivo» pare avere fra i giovani. Da questo punto di vista – solo da questo, naturalmente – la situazione non sembra molto cambiata, purtroppo, da quella della generazione di chi scrive. Di chi era adolescente quando la bomba di Piazza Fontana esplose: e può testimoniare di quanto svagata, generosa ma ignara di storia recente fosse la generazione di quelli che vissero il ’68 dal basso di una qualunque prima liceo6. Fu, la nostra, un’entrata nella vita della polis – una seconda nascita, direbbe Hannah Arendt – tanto perentoria quanto ignara della storia e perfino delle speranze, già da un pezzo tramontate ma forse non del tutto rimosse, di quelli che avevano vent’anni nel ’48: i nostri genitori. E nonostante tutta la nostra idealità e il respiro mondiale dei nostri sogni, neppure ci accorgemmo di essere entrati in politica dal lato sbagliato: quello della forza, e non quello della ragione. Quasi nessuno in quegli anni metteva in dubbio la legittimità della violenza «levatrice della storia».
Perché – viene da chiedersi – nessuno dei nostri professori ci aveva fatto leggere il Manifesto di Ventotene? Con l’incipit folgorante in cui si riassumono i vent’anni di carcere, di ascesi e di pensiero di un uomo che era stato un comunista perché aveva fame e sete di giustizia, e come tale era stato chiuso a vent’anni nelle carceri fasciste, e poi in quella lunga ascesi aveva riattraversato l’intero dramma della storia e del pensiero. Eccolo:
La civiltà moderna ha posto come proprio fondamento il principio della libertà, secondo il quale l’uomo non deve essere un mero strumento altrui, ma un autonomo centro di vita. Con questo codice alla mano si è venuto imbastendo un grandioso processo storico a tutti gli aspetti della vita sociale, che non lo rispettassero.
Tutti: e fra questi il contrasto fra la politica concepita sulla base degli Stati nazionali e l’economia globale. Vere democrazie che siano esclusivamente interne ai singoli Stati – soprattutto quelli europei –, oggi, molti sostengono, non sono piú possibili. Quell’uomo visionario, cui come non mancava la percezione del reale, presente e carico di avvenire, lo vide settant’anni fa.
Chi ne dubita vada a rileggersi passi come questo:
oggi lottare per la democrazia significa rendersi anzitutto conto che occorre arrestare questa insensata corsa, non solo italiana, ma europea, verso una società polarizzata in interessi organizzati che si precipitano sullo Stato e lo paralizzano quando sono in equilibrio, e ne rafforzano sempre piú il carattere dispotico, quando un gruppo o una coalizione di gruppi ha potuto sopraffare l’avversario e prendere il potere7.
Sono parole scritte nel 1946, nella Relazione che Spinelli tenne al II Congresso del Partito d’azione. E ci si chiede come abbia saputo cogliere l’essenziale, a tal punto che il suo pensiero sembra attraversare la stagione dei partiti di massa – e da noi della Prima Repubblica – per poi volare alto sulla «liquidità» post-ideologica – e da noi sopra il liquame immobile della cosiddetta Seconda Repubblica – fino a fotografare il perdurante, terribile ingranaggio delle “macchine d’affari” partitiche di oggi e della loro ormai spensierata delinquenza, con il tristo contrappeso delle incombenti rottamazioni della Costituzione del ’48.
E allora bisogna ricominciare a chiedersi il perché di questa tenace rimozione con cui, di generazione in generazione, la “sinistra” – vale a dire la parte politica assiologicamente motivata dalla priorità del valore giustizia – si è lasciata alle spalle il meglio che l’umanità europea moderna abbia saputo costruire. Spinelli ebbe come compagni vicini e lontani, oltre a Ernesto Rossi, a Eugenio Colorni, a Ursula Hirschmann, alcuni fra i migliori europei della sua generazione: da Albert Camus a Ignazio Silone, da Adriano Olivetti a Jeanne Hersch a Czesław Miłosz… Le radici del loro pensiero affondano profonde, come quelle della democrazia, nel socratismo del faccia a faccia e del ragionare dei fini alla luce dell’universalismo morale: molto piú che nella “forza” del “popolo” sulle piazze, a partire da quelle di Atene. Sono pensatori la cui vita è stata piú o meno fortemente segnata dalle forme piú terribili assunte nel secolo scorso dalla dissociazione della politica dall’etica e dalla logica: e sono accomunati da un’aria di famiglia che non si spiega solo con l’esperienza del male e dell’esilio che molti di loro dovettero affrontare, ma anche con la familiarità di tutti con il pensiero assiologico di Simone Weil, di cui furono traduttori, editori o almeno appassionati lettori8. Il pensiero, voglio dire, di quel peggiore dei mali che è la mescolanza del bene e del male fin dentro la nostra mente: l’ambiguità.
Era l’epoca che Nicola Chiaromonte, con Ignazio Silone fondatore di «Tempo presente», aveva chiamato «il tempo della malafede»; e credo si possa intendere con questa espressione proprio quell’ambiguità, quel tipo specificamente novecentesco di «mescolanza di bene e di male» entro il pensiero, che abbiamo chiamato omertà dell’autocoscienza: il fondo psicologico della banalità del male. Quello che Primo Levi chiamava «la zona grigia». Questo pensiero, piú particolarmente, affronta l’enigma di una “metamorfosi” interiore la cui fenomenologia conosciamo da un classico di quegli anni, La mente prigioniera di Czesław Miłosz: la metamorfosi nell’intimo del singolo che al pensiero ideologico sacrifica la propria autonomia morale e intellettuale. Ecco come narra quel tempo Jeanne Hersch, che come nessun altro pensatore socratico del Novecento fece luce su questo enigma. Parlando delle acrobazie della dialettica e della retorica novecentesche, descrive cosí la Parigi dove imperversava il conflitto fra Sartre e Camus, e una maggioranza di intellettuali rimproverava a Camus di non saper sacrificare la propria, di autonomia:
Li si vede ricorrere a tutte le risorse del virtuosismo intellettuale per creare delle parvenze di continuità o di sintesi dove c’è inconseguenza o incompatibilità […]. Fragili articolazioni logiche, sottili giochi di parole, salti precisi sul trapezio della dialettica, paiono riconciliare ormai meglio che in Hegel le opzioni tradizionalmente ostili9.
Ora, il nesso inscindibile fra etica e logica è ciò che definisce la filosofia “socratica”, come ci ricorda anche il passo citato: è anzi il nesso cui direttamente o indirettamente è dedicato questo libro. Anche la breve evocazione del testo di Hersch ci ricorda un aspetto – l’aspetto Rive Gauche, diciamo cosí – delle dimissioni di Socrate ne...