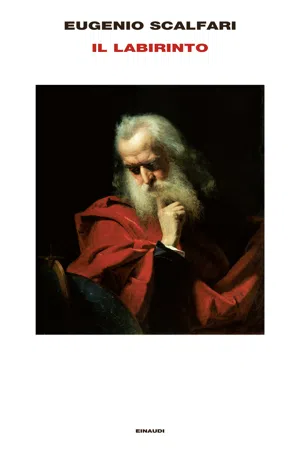![]()
Il mare quel giorno era pieno di vento, vento caldo di libeccio che arrotolava le onde in cavalloni sporchi e piegava le chiome dei pini traendone un fischio fuggiasco che si perdeva dietro le dune e tra i piumazzi del canneto.
Mare di spume a perdita d’occhio, nuvole gonfie, di quelle che opprimono le membra e i pensieri e risvegliano un’ansia torpida, sudata, febbrosa, l’ansia attorta dei sogni quando tutto è possibile ma nulla accade e tu vaghi in un tempo fatto d’acqua e di vapori senza piú sapere di te né della strada che ti conduce né dello scopo che hai smarrito e che non hai voglia di ritrovare.
Cosí il vento di libeccio soffiava sulla casa dei Gualdo avvolgendone i tetti e le mura, facendo girare le banderuole e diluviando dentro le canne fumarie sulla cenere dei camini spenti.
Dietro ai vetri della mia finestra guardavo quel mare e ascoltavo quel vento che mi accorciava il respiro e sbandava i pensieri. «I pensieri non vengono quando vogliamo noi ma quando vogliono loro». Forse non si confanno al vento di sud-ovest; come gli uccelli migratori, anche i pensieri arrivano a stormi rigando il cielo e poggiandosi delicatamente, uno ad uno, sulla nostra fronte.
Qualche cosa – o qualcuno – pensa, ma chi dice che quel qualcuno sia io? Che sia io la causa di quell’effetto? E che io sappia distinguere il pensare da una qualsiasi altra attività della mente? E infine che io sia io, un punto di certezza fissato nel tempo e nello spazio, un punto univoco e consapevole della sua univocità, o invece un’ipotesi, un castello di carta costruito con tenace e fugace superbia, una traccia con la sola funzione di cancellarsi alla velocità della luce?
La sera prima era accaduto qualche cosa di molto strano che ancora non riuscivo a decifrare: quell’improvvisa apparizione di Stefano alla finestra, quel grido «Dio è morto» cosí inaspettato, cosí inaudito. Non mi ponevo neppure il problema di comprenderne il significato ma l’altro – per me assai piú importante – di capire che cosa stesse accadendo nell’animo della persona a me piú vicina, il mio modello e il mio riferimento pur nella differenza delle nostre nature. Qualche cosa di profondo si era certamente verificato dentro di lui, una svolta inaspettata, forse un pericolo? E come avrebbe reagito suo padre ad un mutamento cosí improvviso? E gli abitanti di quel labirinto nel quale passavamo la nostra vita aggrappati alle nostre nature, unico appiglio per non smarrirci tra quelle pareti e non confonderci col caos che sentivamo schiumare alla nostra porta?
Se Stefano stava cambiando nel profondo di sé, tutto sarebbe cambiato, ciascuno di noi avrebbe dovuto cercare una diversa collocazione rispetto a se stesso e agli altri, la natura dei Gualdo e la loro reciproca geometria, i loro ruoli sarebbero diventati elementi mutanti in forme e modi che non riuscivo ad immaginare.
Forse erano queste, assai piú che il vento di libeccio che infuriava il mare, le cause che suscitavano quell’ansia opaca che mi pesava sulla mente e sul cuore.
Dovevo comunque saperne di piú e nessuno in quella casa meglio di Olimpia avrebbe potuto aiutarmi a capire. Attraversai perciò quasi di corsa il vestibolo che portava al padiglione della «principessa madre», come la chiamavamo, e suonai al grazioso portone vetrato che separava il suo alloggio dal resto della casa.
La «principessa» mi aspettava, sapeva che sarei andato da lei e del resto ce l’eravamo detto la sera prima, anche se ora ero premuto da un’altra urgenza e da un’altra ragione. Mi baciò sulla fronte, mi fece sedere su una poltrona accanto a lei, chiamò per il tè e lei stessa me lo serví. «La festa ha proseguito a lungo dopo la mia partenza?», mi chiese. «Oh sí, molto a lungo. Ci furono danze e balletti gitani; poi il nonno ha condotto tutti fuori e credo abbiano cantato e suonato ancora, ma anch’io a quel punto me n’ero andato».
«So che hanno anche pregato. Sai, tuo nonno è proprio adorabile: pagano fin nel midollo, ma ogni tanto gli arriva una folgore dall’alto dei cieli…»
«Non per questo cessa d’esser pagano, come dite voi».
«Appunto; lui riesce ad essere tutto e questo è il suo fascino. Gran personaggio, mio fratello».
«Ho saputo che a un certo punto lo zio Stefano…»
M’interruppe immediatamente con un banalissimo «Prendi questi biscotti, li ha fatti Marietta, sono di casa». Evidentemente di quell’argomento non voleva parlare e, conoscendola, non insistetti. «Mi dicevate d’un libro ieri sera».
«Ma sí, eccolo qui». Lo prese dallo scrittoio che aveva accanto e me lo porse. Molti angoli delle pagine erano segnati. Al di là del bene e del male, Federico Nietzsche.
«Lettura impegnativa», dissi.
«Travolgente, ma ci sono punti che non capisco. Tu lo conosci?»
«Sí, l’ho letto».
«Hai letto altre cose di questo Nietzsche?»
«Qualche altra cosa, sí. È morto qualche anno fa assai malamente. Era impazzito».
«Ma guarda! Si sente, leggendolo, che era una mente vivida ma un’anima molto agitata. Mi ha colpito il suo stile e soprattutto certe fulminazioni improvvise, un capovolgimento delle opinioni correnti cosí radicale come finora non avevo trovato in nessun altro scrittore. Ma è anche vero che io sono una scarsa lettrice per via dei miei occhi: si stancano molto presto».
Sfogliai il libro, mi fermai su alcune pagine segnate. Su una in particolare e su alcune frasi sottolineate accanto alle quali erano stati scritti due punti interrogativi seguiti da un esclamativo: «Che la verità abbia maggior valore dell’apparenza non è nulla piú che un pregiudizio morale… non ci sarebbe assolutamente vita se non sulla base di valutazioni e di illusioni prospettiche e se si volesse togliere completamente di mezzo il “mondo apparente”, ebbene, posto che voi possiate far questo, anche della vostra “verità” non resterebbe nulla! Che cosa ci costringe ad ammettere che esiste una sostanziale antitesi di “vero” e “falso”? Non basta forse riconoscere diversi gradi di illusorietà, ombre e tonalità complessive dell’apparenza – differenti “valeurs”, per usare il linguaggio dei pittori? Per quale mai ragione il mondo che in qualche maniera ci concerne non potrebbe essere una finzione? E se a questo punto qualcuno domandasse “ma non si richiede per ogni finzione un autore?” non gli si potrebbe rispondere chiaro e tondo: e perché mai? Codesto “si richiede” non rientra forse nella finzione? Non è forse permesso alla fine essere un po’ ironici verso il soggetto, come verso l’oggetto e il predicato?»
Avevo letto questo brano ad alta voce e lei seguiva la lettura annuendo con leggeri cenni del capo come per dire «ecco, questo è il punto». Quando alzai gli occhi dalla pagina esclamò: «Ebbene, non ho capito un bel niente salvo che il vero e il falso non esistono, c’è soltanto la nostra orgogliosa interpretazione, quella che ci fa piú comodo e che ci illude con maggior efficacia».
«Ma zia Olimpia, avete capito tutto: questo è esattamente il senso di quanto c’è scritto».
«Sí, ma che vuol dire? La verità è un pregiudizio morale, che vuol dire?»
«Se la verità non esiste in senso assoluto e oggettivo, affermarne l’esistenza è un omaggio ipocrita ad una convenzionale moralità».
«Sí mio caro, ma come si fa a vivere sapendo che la verità non esiste?»
«Già, questo è il punto. Nietzsche ha dedicato la vita a rispondere a questa domanda che lui stesso si era posto».
«Forse per questo è finito pazzo».
«Forse. Sapete, zia Olimpia, che stanotte lo zio Stefano ha gridato dal balcone a tutta la compagnia che era riunita in giardino “Dio è morto”? Ve l’hanno detto?»
Diventò molto seria in volto e abbassò la voce fin quasi ad un sospiro: «Me l’hanno detto, sí».
«Che cosa ne pensate? Lo avete visto?»
«No. L’ho pregato di venire da me; ha risposto che non si sentiva bene e voleva restar solo».
«Quell’esibizione non è da lui».
«È vero. Forse dovresti andare a trovarlo o forse no, aspettiamo fino a domani. Quello era il grido d’un animale ferito e dev’essere una ferita profonda; lasciamola rimarginare».
«Una ferita cosí dolorosa da trasformare la sua natura? Da spingerlo a comunicare a gente sconosciuta, dall’alto d’una finestra a metà della notte, un pensiero riposto e conturbante, un’affermazione gridata e blasfema? Quella ferita dev’essere una voragine».
«È vero, povero caro, deve star soffrendo come un cristo in croce e non sappiamo perché».
Entrò Marietta: «Il signor Stefano chiede di lei, donna Olimpia».
«Come? Dove?»
«È qui».
Stefano era già entrato, dietro di lei.
Aveva l’aria di star benissimo, rasato di fresco, profumato con la sua «lavanda» inglese, gli occhi sorridenti e vivaci. Baciò affettuosamente la mano di Olimpia. Io mi ero alzato di scatto. «Vi lascio», avevo detto. «No, resta. Ti prego», mi disse reciso.
Sedette. Chiese un bicchiere di sherry. «M’avevano riferito che stavi poco bene».
«Stamattina, sí, un po’ di mal di capo, l’aria di stanotte era assai umida e non tutti hanno il fisico di mio padre che ha fatto nottata cantando sotto la luna». Scoppiò a ridere allegro, senza malizia. Zia Olimpia lo guardava con estrema attenzione anche se non perdeva i modi svagati e leggeri d’una dama di buone maniere. Io lo fissavo come mi trovassi di fronte a un oggetto sconosciuto.
Marietta entrò di nuovo e annunciò che due giovani donne accompagnate da due signori desideravano salutare la principessa. Olimpia chiese chi fossero. «Fanno parte di quel gruppo di persone che don Cortese invitò a cena ieri sera».
Olimpia guardò Stefano interrogativamente e ne ebbe un sí col cenno del capo. «Fai passare», disse a Marietta. I quattro vennero introdotti.
Erano per l’appunto le due giovani bellezze che la sera prima avevano ballato il flamenco, il torero che le aveva guidate nel ballo e un altro dei lunatici che non avevamo notato prima. Indossavano vestiti civilmente sobri. La giovane bruna (sapemmo che si chiamava Fosca) aveva tra le braccia un mazzo di margherite tra le quali spiccavano alcune rose d’un rosso acceso e le porse con molta grazia alla principessa. La bionda aveva portato uno scialle di maglia di seta da lei tessuto. I doni furono accettati con sincero slancio, furono serviti sherry, vino di marsala, biscotti.
«Mi hanno detto che ballate come delle vere andaluse. Tu le hai viste? – disse donna Olimpia rivolgendosi a me e senza aspettare risposta: – Io mi ero ritirata qui a riposare, gli acciacchi dell’età tiranneggiano purtroppo».
S’informò dove avessero imparato a danzare un ballo cosí difficile ed espressivo, le giovani risposero, anche i loro accompagnatori entrarono nella conversazione, fu chiesto come si trovavano nella nostra casa e se avessero fatto amicizia con «i nostri giovani, che sono tutti molto spiritosi e cordiali». «Quasi tutti», aggiunse Olimpia. Risposero che si trovavano benissimo e che la nostra famiglia era deliziosa, anche se ancora la conoscenza era superficiale.
Stefano ascoltava intento quello scambio di cortesie convenzionali ma sincere. Si vedeva che la giovane bruna gli aveva fatto molta impressione, lo si capiva da come la fissava con i suoi occhi lunghi, animati da una luce cosí fisicamente percepibile che la ragazza dovette sentirla perché si girò verso di lui e a sua volta lo fissò fino a che fu lui a distogliere lo sguardo. Ma poi per quanto durò la conversazione, quel gioco reciproco degli occhi si ripeté piú volte intrecciato alle parole.
«Dove siete nata?», chiese Stefano. Non era andalusa, ma di un piccolo paese dalle parti di Toledo, aveva perduto molto presto entrambi i genitori e Alfonso l’aveva cresciuta come figlia. Stefano guardò il gitano con riconoscenza e continuò a domandare. «Avete studiato?» «So leggere e scrivere». «Quanti anni avete?» «Ventidue». «Che cosa sapete fare?» «La cucina e il cucito». «Nient’altro?» Fosca guardò Alfonso con occhi smarriti. «Nient’altro», rispose. «Bene», disse Stefano.
«Comunque siete deliziosa, – disse Olimpia, – e anche voi», rivolgendosi alla bionda che si chiamava Esther.
Stefano si alzò, promise a Olimpia che sarebbe tornato a tenerle compagnia l’indomani, salutò gli altri con un «arrivederci presto» e a me «vieni?» Uscimmo.
«Vuoi portarmi fino alla tua colombaia? Saranno trent’anni che non ci metto piede e temo che da solo non ritroverei la strada». «È facilissimo, di qui saliamo fino al secondo piano, poi quel lungo corridoio di sinistra fino all’alloggio di Francesco, poi ancora a sinistra passando davanti alle stanze di Umberta, un’anticamera e un passaggio che finisce ad una scala a chiocciola. È lí. Ci arriverete facilmente».
«Voglio andarci con te. È l’ora piú bella da passare vicino al cielo».
L’orologio batteva le sette quando aprii la porta del mio aereo rifugio e già a oriente brillava la stella di Venere.
Naturalmente Alfonso non era il padre adottivo di Fosca o forse lo era stato ma era soprattutto il suo amante. Era anche l’amante di Esther; nella società dei lunatici questi rapporti erano noti a tutti e nessuno se ne stupiva poiché regnava tra di loro la piú ampia libertà; repressione dei sentimenti e degli appetiti era considerata un’ipocrisia contro natura dalla quale si erano liberati. Ma nei rapporti con gli altri entravano in gioco valutazioni di convenienza che suggerivano qualche cautela e qualche piccola o grossa bugia.
Del resto ciascuno di loro custodiva e difendeva gelosamente la propria indipendenza ed era quello il principio che orientava le loro vite. Aveva un prezzo, talvolta alto, l’indipendenza, poiché spesso i desideri differivano dai sentimenti; rinunciarvi o appagarli cagionava comunque sofferenza, nuovi sentimenti nascevano senza che declinassero i vecchi e l’intreccio che ne risultava suscitava dolore e lacerazione.
Discutevano spesso di queste cose tra loro la sera, quando si ritrovavano nei loro attendamenti e, dopo aver passato in rassegna i piccoli eventi della loro giornata girovaga, riposavano talvolta su se stessi, sul loro interrogarsi, sulle speranze – chi di loro ne aveva –, sulle loro malinconie color dell’oliva e sull’abbandonata stanchezza sentimentale che li coglieva attorno ai fuochi nelle notti di primavera.
Non era una compagnia di romantici, ché anzi le voglie, la furbizia necessaria per appagarle, quel tanto di clownesco e d’infido necessari nella loro condizione per campar la vita connotavano la piú gran parte dei loro comportamenti e delle loro avventure. Ma avevano tuttavia nella memoria e nel cuore il momento in cui s’erano strappati dalla loro radice; quello era stato l’atto della loro seconda nascita, di lí veniva la loro ricchezza e la loro ritornante nostalgia, il riso e il pianto che con fanciullesca frequenza si alternavano nell’animo loro, gli umori bizzarri che facevano la loro grazia e talvolta la loro disgrazia.
«Quel signore ti guardava, – disse Alfonso a Fosca mentre rientravano alla tenda nella radura, – e anche tu l’hai guardato». «È vero, – rispose, – ha degli strani occhi e uno sguardo che ti entra nell’anima». «A me piaceva vedere in che modo vi guardavate. Stavate facendo l’amore davanti a noi, era eccitante, una danza degli occhi molto eccitante. Non ci fosse stata la vecchia signora e quel giovane, sai che cosa avrei fatto? T’avrei presa lí, sul pavimento e tu e lui avreste continuato a guardarvi in quel mod...