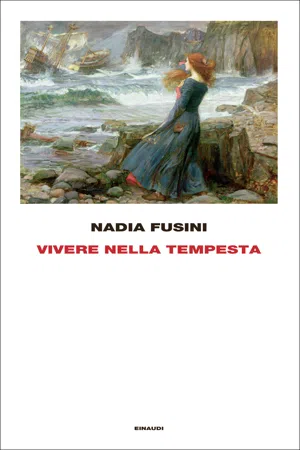![]()
Vivere nella tempesta è un titolo né allusivo, né allegorico. Descrive alla lettera quello che faccio: da anni vivo nella Tempesta di Shakespeare, la leggo, la rileggo. Passano gli anni e io sono qui, immersa in quel che significano la tempesta e il mare e il naufragio e la salvezza in Shakespeare. E nel tempo – che con la tempesta condivide una radice nell’etimo – osservo come il fatto stesso di esistere ci esponga alla tempesta, come ci sia un che di tempestoso nella vita di tutti: stormy is our life.
Non è certo un caso che Shakespeare scelga non la parola piú comune, storm, ma tempest, per intitolare la sua ultima commedia. Nell’etimo sassone storm, che attinge al ricco vocabolario della lingua volgare, la radice (s)twer rimanda a un vortice, dove il tumulto e lo stormo e dunque la violenza dell’assalto in battaglia si confondono in un’origine avvolta nel mistero; nel termine tempest, invece, l’etimo di origine latina rimanda a tempus, all’idea cioè di un taglio (dal greco temno), che seziona e circoscrive e delimita un flusso in periodo, epoca, stagione, finché il senso sfuma in un “tempo” che si fa “temporale” e rima con “fortunale”, e da “tempestoso” precipita in “fortunoso”. La Fortuna cosí entra in campo, come la procella che per l’appunto domina nelle nostre vite e tutti ci rende schiavi del Caso. Come fossimo navi in balia del tempo atmosferico.
Lo cantava Billie Holiday: Don’t know why there’s no sun up in the sky. Sí, ci sono giorni cosí, quando il sole scompare e la vita si fa vuota – life is bare, gloom and mis’ry everywhere… In giorni cosí, cantava Billie Holiday, the blues walked in and met me. Stormy is our life.
Il tempo ci espone al sentimento della melanconia, della caducità. Soprattutto quando al celeste, al sereno, subentra la violenza di un cielo agitato dai venti, oscurato da nubi, e ci scopriamo inermi di fronte a forze piú grandi di noi. È il sentimento della “deiezione” che i poeti romantici hanno ben descritto con Coleridge, e che riscopriamo ogni volta in cui per cause che si impongono a noi dall’esterno abbiamo la dolorosa rivelazione della nostra impotenza. Rinasciamo allora alla consapevolezza che siamo stati per l’appunto “deietti”, espulsi da un grembo, e ora siamo “fuori”, viviamo nel “fuori”, e di questo “fuori”, per quanto cerchiamo di farne un “dentro”, non riusciamo a fissare i confini. E anche se ci pensiamo come isole, in quel pensiero confidando nella speranza di trovarvi l’assoluto dell’interezza, neanche quel pensiero ci protegge, né tantomeno ci rende invulnerabili… Nella solitudine dell’isola crescono semmai l’angoscia della solitudine e la fobia del contatto, e si insinua la verità della condizione umana, che un poeta metafisico come John Donne sa mettere in versi: e cioè che siamo, noi creature, piú che isole arcipelaghi, e nel vasto mare che tutti ci contiene e ci separa siamo legati gli uni agli altri, sí che non serve chiedere «per chi suona la campana»… La campana cui allude John Donne annuncia l’ora della morte, che vale per me come per il mio vicino e tutti ci stringe alla caducità nel generale vincolo della comune mortale natura. La campana è in questo caso lo strumento che segna le ore, divide il tempo in quantità contabili… E insieme, come la clessidra, come l’orologio, è un simbolo.
Il tempo batte, il tempo va e viene, passa e ritorna, osserva il poeta Robert Creeley nella poesia che per l’appunto intitola al ritmo: «Dalla porta che si chiude, | alla finestra che si apre, le stagioni, la luce del sole, | la luna, gli oceani, | come le cose crescono, | e come si rincorrono nella mente di un uomo», tutto è ritmo. E la fine non è la fine, ma si imbatte in un altro ritorno, i bambini crescono e diventano uomini vecchi, e l’erba si secca e la forza svanisce, ma rifiorisce… Cosí il tempo dispiega le sue continuità, «tutto piegando alla propria forza» – la finestra e la porta e il soffitto e il pavimento, «luce in apertura, | buio alla chiusura».
Questo tempo è il ritmo sorvegliatissimo nella Tempesta, dove Shakespeare, che quasi sempre disattende con allegra sprezzatura le unità aristoteliche, ne osserva l’unità con accurata disciplina. Anzi, ne scandisce il transito piú volte, mettendo in bocca a Prospero e ad altri personaggi osservazioni precise riguardo al passaggio degli anni, e all’ora del giorno, quasi avesse accanto a sé una clessidra. Calcola con esattezza le ore che passano, siamo fra la terza e la sesta ora, sono le due del pomeriggio. Tra le due e le sei dovrà accadere tutto quello che accade… A dominare è il tempo dello spettacolo, il tempo del teatro. E in effetti la Tempesta dura poco piú di tre ore e finisce puntuale alle sei di pomeriggio, quando finivano le rappresentazioni nei teatri pubblici, ai tempi.
È come se Prospero misurasse attento la sabbia che nell’accumulo di una stessa quantità si versa e riversa da una parte all’altra dell’ampolla nel gesto della ripetizione. Quasi la ripetizione fosse la sostanza stessa della vita. Ripetizione è in effetti il respiro dell’onda, la pulsazione incessante della enorme massa marina in moto perenne, in stato di agitazione costante, in moto anche quando immota, che circonda l’isola – l’unità di luogo del dramma. Ma ecco che d’un tratto il tempo statico dell’isola si rovescia in temporale, e l’azione prende avvio.
Non accade cosí nella vita di ciascuno? Nella durata di un tempo lento e immoto, che potremmo immaginare eterno, quasi un dormiveglia, d’un tratto irrompe il tempo qui e ora di emergenze interiori improvvise, travolgenti… Sono le nostre tempeste.
![]()
Il murice.
Soprattutto dopo un temporale, il mare abbandonava sulla riva dell’isola che frequentavo da bambina grandi conchiglie dalla forma sinuosa, allungata. Le raccoglievo meravigliata, rapita dal puro incanto che emanava dalla luce di madreperla. Mio padre mi insegnò il loro nome, bolinus brandaris o murice. Ma non era scientifica la mia curiosità; se raccoglievo quei talismani, era per accostarli all’orecchio, e cogliervi il rumore misterioso che li abitava. Sempre mio padre mi spiegò che era un’illusione acustica: accadeva che dentro quel guscio, o scheletro, divenuto ormai vuota cassa di risonanza, io sentissi pulsare il mio proprio sangue; udivo il rumore che fanno i pensieri, perché i nostri pensieri, cosí diceva mio padre, si muovono dentro il cervello come piccoli fiati, aliti brevi, brezze leggere, e mormorano, rumoreggiano, spostandosi tra le sostanze fibrose nel tessuto cerebrale con lievi schiocchi.
Del resto, già nella forma la conchiglia fa pensare a un orecchio. Proprio come nella storia che racconta, la Tempesta di Shakespeare rassomiglia a una creazione marina. Il mare è l’elemento che sostiene la trama e l’isola l’unità di luogo in cui accade l’azione – il suo tempo, lo stesso della radice latina tempus, ovvero quel taglio che nella vita umana scava e recinge la caduta di un tempo opportuno. Un tempo debito. Che nell’isola trova il suo equivalente di taglio spaziale.
In indimenticabili lezioni che ebbi la fortuna di frequentare nell’aula I della facoltà di Lettere della Sapienza, un grande maestro shakespeariano, Agostino Lombardo, parlava della Tempesta come di «una grande conchiglia» che conteneva tutti i suoni del teatro shakespeariano, e in particolare il suono del mare. Quel dramma era un inno al mare, aveva a sua volta scritto W. H. Auden, un poeta che amavo e di cui avevo letto ammirata Gl’irati flutti. Lí Auden citava il Preludio di Wordsworth, altro testo mirabile e meraviglioso, che mi aveva commossa e anche leggermente confusa, dove al poeta compariva in sogno un arabo con in mano una pietra e una conchiglia, simbolo l’una della realtà, l’altra dell’immaginazione. Con quei due amuleti avevo spesso anch’io giocato, da bambina, in modo spontaneo riconoscendo a entrambi, seppure ingenuamente, il medesimo valore.
Seduta nell’aula ascoltavo, e mi meravigliavo. Era proprio come avevo immaginato, accadeva proprio come nella conchiglia che accostavo all’orecchio da bambina; prestavo orecchio alla Tempesta di Shakespeare e vi coglievo suoni misteriosi che si confondevano con i miei propri suoni interiori, fino a trasformare l’ascolto in un esercizio di conoscenza di me stessa. Con gli occhi leggevo e con le orecchie ascoltavo e mi ritrovavo d’un tratto in un mondo di visioni interiori.
In relazione all’opera d’arte, in effetti due organi sopra tutti gli altri primeggiano: l’occhio e l’orecchio. Proprio grazie a un gioco di distorsioni implicite, anamorfosi volute e non volute, l’occhio arriva a mettere a fuoco una capacità di visione che si misura non solo con il visibile, mentre l’orecchio affina un ascolto che sa cogliere le inaudite corrispondenze che si intrecciano tra macro e micro-cosmo, nella consapevolezza che c’è sempre dell’altro… dell’altro ancora da vedere e da udire.
“Saper vedere” e “saper ascoltare” – a questo educa l’arte. La poesia, la pittura, che altro sono, se non esercizi dell’ammirazione? L’opera, che sia un quadro, una poesia, un dramma, è lo specchio non solo della realtà esteriore, ma della psiche, o anima, o mente del lettore. Il quale nello sforzo di sprofondare in quello specchio, come Narciso, si scorderà di se stesso, e proprio cosí scoprirà il fascino dell’esistenza. Quale altro sviluppo piú spirituale e piú ingegnoso delle nostre forze e del nostro io individuale desiderare, se non di perdersi in ciò che non conosciamo? Quale altra avventura inseguire?
Gli spiriti.
C’è una dimensione “spirituale” nella Tempesta, e non a caso di “spiriti” l’isola è popolata. La parola “spirito” vi compare piú volte: ben ventinove, ho contato. Alla lettera, la commedia è percorsa da cima a fondo da presenze le piú diverse che si possono nominare con appellativi quali ombre, demoni, emanazioni celesti, creature evocate grazie all’arte della magia… Che a loro volta rimandano ai vari significati della parola “spirito”. Sí che potremmo dire che la commedia è di fatto immersa in un’atmosfera spirituale, simbolica. Addirittura, è stata letta come il testamento spirituale del suo autore, come un’opera magico-iniziatica, dove la fiction, la materialità della rappresentazione, viene esaltata grazie a un’elaborata mise-en-scène che a sua volta ci affaccia sul mistero stesso del teatro, nel momento in cui il suo protagonista principale lo abbandona; sí che d’un tratto ci ritroviamo in una specie di Truman Show, confusi rispetto ai piani della realtà e dell’illusione.
Se Prospero è mago è perché è artista: la sua magia è poetica – e musicali e teatrali gli effetti. Vaghiamo difatti nell’isola del mago Prospero stregati da suoni e da canti, che come una specie di mantra intessono un tessuto di percezioni auratiche, che liberano all’orecchio fantasmi di parole sospese nell’interiore labirinto della mente, che cosí divagando s’intona all’avventura, sollecitata a cogliere nel tessuto dell’opera echi e rimandi alla sua propria esperienza. Ripetiamo quelle parole e nel profondo del cuore sentiamo l’interiore ricchezza e stranezza di questa cosa qui – la vita, la nostra vita…
Ecco perché sono arrivata a pensare alla Tempesta di Shakespeare come a una conchiglia: la porto all’orecchio e vi sento il suono della vita.
Amore e Psiche.
Accostare un testo del passato all’orecchio come fosse una conchiglia per ascoltarvi i nostri pensieri, le nostre emozioni, è un modo di leggere – un modo all’apparenza possessivo, in cui pare trionfare una volontà appropriativa. Potremmo però anche intendere il gesto in senso opposto, e cioè come l’affermazione dell’incontrastata potenza metamorfica di un corpo di parole che sfugge al possesso di chi l’ha concepito e risponde di sé soltanto a chi legge e si plasma al suo desiderio. In ciò incarnando alla perfezione la volontà sacrificale di un autore, che nel caso di Shakespeare, nel suo testo è pronto a morire, perché esso possa vivere nel lettore. È cosí che un poeta come John Keats, o piú tardi un poeta come T. S. Eliot accostano all’orecchio la Tempesta di Shakespeare.
Né Keats né Eliot hanno dubbi: l’esperienza creativa è la stessa cosa di una vocazione all’«estinzione della personalità»; il «sacrificio di sé» è il passaggio necessario, inevitabile, grazie al quale l’«io» del poeta si immola, perché l’opera nasca. Semmai, l’artista fa di se stesso la cavia del proprio esperimento creativo. Ma cosí fa anche il critico, o almeno cosí fanno il critico e il lettore che ho in mente. Cosí fa chi intende leggere non per distrarsi… ma piuttosto per “centrarsi”.
A loro questo libro è rivolto: a chi legge per “centrarsi”. A chi pensa alla lettura come alla relazione silenziosa e intima di Amore con Psiche; dove chi legge è Psiche, e si arrende ad Amore nel buio. Sí, nel buio: aspettando che “luce sia!” nella sua mente, mentre s’intrattiene nell’amplesso amoroso con il testo che legge. Attendere che si faccia luce è il primo gesto di obbedienza che il lettore dovrà compiere; non si aspetti parole chiare, comuni, convenzionali, non forzi in quella direzione il linguaggio. C’è del mistero nella parola creativa: il lettore lo rispetti. Abbia pazienza. Un’opera d’arte, perché esista, è necessario che entri in circuito con le energie di chi legge, e tanto piú forte sarà la sua potenza espressiva quanto piú nella dinamo dell’opera si accumulano le vibrazioni all’unisono della mente e dell’anima dell’autore e del lettore. Perché ogni opera è anche la storia di un’anima – quella dell’autore, e quella del lettore. Naturalmente se il lettore ne ha una… se ne coltiva una…
Fin dalle origini la natura dell’ispirazione poetica si presenta enigmatica nel modo stesso del suo accadere, e presuppone una sospensione, per quanto breve, delle facoltà razionali. Quanto sa di quello che fa, il poeta? Sa quello che dice o non è, piuttosto, ispirato? E nel caso, da chi? Qual è la differenza tra il veggente, il profeta e il poeta? Proprio perché tale differenza vacilla, il lettore dovrà mettersi nella posizione di chi si lascia sorprendere da una parola che non comprende, e comprenderà solo se si lascerà educare ad essa grazie a un allenamento dell’orecchio al «foco che l’affina».
L’oceano, le Indie.
Non c’è testo shakespeariano che meglio della Tempesta dimostri come il racconto nasca dalla vita e torni alla vita. La storia che qui Shakespeare monta in una trama drammatica è intimamente legata all’attualità, alle cronache di viaggi e naufragi che effettivamente e realisticamente accadono nei tempi in cui scrive. È questa una delle poche volte in cui Shakespeare non attinge a una fonte letteraria, ma piuttosto a ispirarlo sono i fatti, gli eventi. E sono fatti ed eventi che riguardano il mare, l’oceano. Già dagli anni Ottanta del Cinquecento gli elisabettiani si eccitano sempre di piú all’idea di fondare in America plantations – parola che per la prima volta compare nel lessico shakespeariano proprio qui, nella Tempesta: una vera e propria febbre espansionistica assale i piú intraprendenti tra i mercanti e i piú audaci tra i navigatori, all’idea di creare “colonie”.
Capita ora, proprio nel giugno del 1609 – mentre Shakespeare sta concependo la “sua” tempesta –, che una flotta di nove navi guidata da sir Thomas Gates parta da Plymouth con destinazione Virginia; ovvero la prima colonia inglese, che Raleigh aveva fondato sul continente americano nel 1585, nel nome dedicandola alla sua regina Elisabetta, la Vergine. Senonché una delle navi, anzi la nave ammiraglia dal nome profetico Sea Adventure, o Sea-Venture, a bordo della quale c’è proprio Gates, viene separata dal convoglio di otto vascelli e, travolta dalla tempesta, scompare tra i flutti. È il 28 luglio del 1609.
Il resto della flotta giungerà in Virginia, e i marinai racconteranno ai coloni del tremendo viaggio, e insieme piangeranno per le vite perdute. Quando in madrepatria arriverà la notizia, anche lí si estenderà il cordoglio per i morti annegati. In realtà – finale inatteso e ad effetto – la Sea-Venture naufragò sí, ma miracolosamente andò a incagliarsi tra due grandi rocce lungo le coste delle isole Bermuda, sí che pur se in pessime condizioni si ritrovò miracolosamente al riparo in una insenatura, che apparve ai naufraghi quale benefico approdo (haven), e porto celeste (heaven). Scampando sempre miracolosamente alla morte per acqua, i naufraghi – centocinquanta persone tra equipaggio e passeggeri – raggiunsero la riva portando con sé in salvo provviste e utensili.
Toccano terra, ed è una terra fertile e benigna ad accoglierli. Sempre confidando nel loro scopo, fedeli all’intento di raggiungere la destinazione da cui il destino li ha temporaneamente distratti, nei mesi a venire i piú volenterosi tra di loro costruiranno una nuova imbarcazione dal fatidico nome Deliverance, e una lancia dall’altrettanto ineluttabile nome Patience. E nel maggio del 1610, dopo «strane, eccezionali e straordinarie esperienze» (cosí si racconta nelle cronache), accolti dall’aura del miracolo, giungeranno finalmente lí dove erano diretti, in Virginia. A salutare con un’euforia quasi pasquale i morti risorti sono altri marinai come loro, educati alla mentalità protestante, se non puritana, per i quali l’esperienza acquisisce un immediato riverbero figurale. Fatale e profetico insieme.
Grande sarà la sorpresa anche in patria, quando si verrà a sapere della felice risoluzione dell’impresa, e crescerà la meraviglia e si infittirà il mistero intorno alle “isole del Diavolo”, come venivano chiamate le Bermuda: la notizia del fortunoso approdo presso i selvaggi, la descrizione della fertilità del terreno, le dolcezze del clima, il miracolo della ricostruzione della nave e del fortunato ritorno susciteranno un’intensa emozione.
Immensa si farà la curiosità rispetto a quei mondi esotici, e varie saranno le cronache e i racconti che fioriranno intorno all’episodio. Tra di essi una lunga lettera in cui William Strachey compila A True Repertory of the Wracke and Redemption of ...