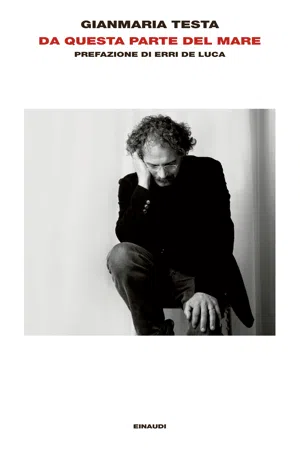![]()
Ho incontrato per l’ultima volta Jean-Claude Izzo nell’autunno del ’99.
Era venuto a Cuneo invitato dagli organizzatori di un festival di letteratura con sua moglie Catherine e con la convinzione di riuscire a vincere la malattia. Facevano progetti per il futuro insieme e aveva, lui, un progetto per un nuovo romanzo sul Mediterraneo.
– Un libro lungo cosí, – mi ha detto facendomi vedere con il pollice e l’indice uno spessore da Guerra e pace.
Non so quale storia avesse in mente di raccontare, non me ne ha parlato e non ho osato chiedergli niente, ho messo nel lettore cd un disco di Roberto Murolo e siamo rimasti per un po’ in silenzio ad ascoltare Munasterio ’e Santa Chiara:
Jean-Claude e Catherine erano seduti sul divano, io su una sedia, guardavamo il lettore cd come fosse un televisore.
Mi è sembrato che Jean-Claude avesse gli occhi lucidi.
– Stai bene?
– La cantava mio padre, – mi ha detto.
Gli ho regalato tutta la raccolta con la scusa che a Marsiglia non l’avrebbe mai trovata e che quelle canzoni e quella voce erano una delle interpretazioni possibili del Mediterraneo: forse gli sarebbero servite da colonna sonora durante la scrittura del nuovo romanzo. Poi abbiamo parlato del mare e di cosa stava diventando.
In quel novembre del ’99, e ormai da qualche anno, erano le coste della Puglia il luogo degli sbarchi piú frequenti, l’Adriatico il mare piú tagliato dalle scie notturne degli scafisti. Avevo in mente, all’epoca, un progetto un po’ faraonico e presuntuoso, volevo scrivere una specie di opera popolare per solisti, coro e orchestra/fanfara che raccontasse di quei viaggi.
– L’Italia sta diventando un Paese d’immigrazione dopo aver riempito di emigranti mezzo mondo, – gli ho detto. – È una situazione nuova per noi e sta provocando reazioni scomposte, come se nel breve spazio di una generazione avessimo dimenticato il nostro partire.
Jean-Claude sapeva bene di cosa stavo parlando, non solo perché era figlio di Gennaro Izzo da Castel San Giorgio, provincia di Salerno, e di Isabelle Navarro di padre emigrante spagnolo, ma perché l’anima stessa della sua Marsiglia era ed è un puzzle incredibile di storie di gente venuta da fuori.
– I soldi e il potere vanno verso nord, – mi ha detto con la sua voce pacata, – ma noi non possiamo permettere che si disperda la cultura che il Mediterraneo custodisce e ricrea da millenni, questa è la forza che ci resta. I soldi e il potere si spostano ciclicamente con il respiro affannoso della storia breve, le identità culturali e quello che sono capaci d’inventare hanno il passo dei secoli, rimangono riconoscibili e uniche per un tempo cosí lungo da diventare sedimento rintracciabile perfino nel DNA delle persone.
Non sono le sue parole esatte, non le ricordo piú, ma il concetto era questo, parlava del suo mare come si parla di casa.
Poi mi ha spiegato la parola rital e quel che significava per lui, bambino a Marsiglia, e piú in generale in Francia e nei Paesi francofoni. Di per sé rital non vuol dire nulla, come non vuol dire nulla terrone o bingo bongo, l’insulto derivava dalla pronuncia della erre all’italiana e non alla francese, a sottolineare il fatto che gli emigranti italiani, anche dopo anni, avevano difficoltà a imparare la lingua del Paese che li ospitava. Si marcava una differenza come si sottolinea una colpa, allora come adesso, loro come noi.
Non so se e quanto Jean-Claude abbia patito le sue origini meticce e straniere, forse soltanto il tempo dell’infanzia, o forse neppure quello, dal momento che lui era del ’45 e suo padre era arrivato in Francia già nel ’29. Non parlava l’italiano e neanche, credo, lo spagnolo, forse dai suoi aveva ereditato non una lingua o una nazione di provenienza, dai suoi e da quella sua città aveva ereditato piú semplicemente il Mediterraneo.
In quei due giorni passati insieme nel novembre del ’99 abbiamo anche avuto il tempo di fare un giro in Langa. Li ho portati ad Alba ad assaggiare i tartufi, Catherine ha fatto delle foto in bianco e nero e abbiamo scherzato sul fatto che nei romanzi di Jean-Claude spesso i protagonisti ascoltavano, fra le altre cose, anche le mie canzoni.
– Dovresti scrivermi un testo che io possa mettere in musica e cantare a titolo di risarcimento, – ricordo di avergli detto.
Il 7 gennaio del 2000 ho ricevuto via fax quella che credo essere una delle ultime poesie scritte da Jean-Claude.
![]()
Plage du Prophète, à Marseille
ils se sont arrêtés.
D’abord la fille aux yeux gris verts
des mers du Nord
et au sourire mûri sur les berges du Nil
L’ami ensuite
le poète des Hauts Pays
attentif aux murmures des passeurs
sur les sentiers arides des exils
Le plus âgé enfin
homme aux semelles de vent
tantôt Afghan, tantôt Mongol
porté par des mondes d’hier entrevus
Plage du Prophète
ils ont porté leurs pas
vers le soleil couchant
Une vague est venue lécher leurs pieds
Bénédiction du Prophète
Prophète anonyme?
de ceux qui croient
aux vérités de la beauté.
Plage du Prophète
Du Prophète
Jean-Claude se n’è andato il 26 gennaio del 2000 e io non ho mai musicato Plage du Prophète perché non avrei potuto fargliela sentire.
L’ho letta, questo sí, l’ho letta cosí tante volte da saperla a memoria, e ogni volta che la leggo penso a lui e a Catherine, la ragazza dagli occhi verdegrigio dei mari del Nord.
Al cimitero di Marsiglia eravamo in tanti di fronte alla sua bara. Qualcuno ha annunciato al microfono che monsieur Jean-Claude Izzo aveva preparato una breve raccolta di canzoni e musiche che gli erano piaciute e ci invitava ad ascoltarle insieme. Non sono riuscito a concentrarmi sulle note che uscivano dagli altoparlanti, avevo un vuoto dentro che mi assordava e la musica era una nebulosa di suoni da Miles Davis ad Abdullah Ibrahim, c’era perfino una mia canzone.
Poi mi sono arrivate, come da lontano, le note di una chitarra e la voce di Roberto Murolo. Mi hanno fatto l’effetto di una stretta di mano, l’ultima.
Jean-Claude non ha voluto lasciare una tomba, ha preferito essere disperso nel suo mare.
Per chi volesse salutarlo c’è da prendere una barca al Vieux-Port di Marsiglia e farsi portare fino alle vicine Îles du Frioul. Da lí, dal Château d’If o da Pomègues o da Ratonneau, guardando verso il largo dentro l’acqua scura, si può immaginare una qualche vicinanza.
![]()
Eppure lo sapevamo anche noi
l’odore delle stive
l’amaro del partire
lo sapevamo anche noi
e una lingua da disimparare
e un’altra da imparare in fretta
prima della bicicletta
lo sapevamo anche noi
e la nebbia di fiato alle vetrine
e il tiepido del pane
e l’onta di un rifiuto
lo sapevamo anche noi
questo guardare muto
E sapevamo la pazienza
di chi non si può fermare
e la santa carità
del santo regalare
lo sapevamo anche noi
il colore dell’offesa
e un abitare magro, magro
che non diventa casa
e la nebbia di fiato alle vetrine
e il tiepido del pane
e l’onta del rifiuto
lo sapevamo anche noi
questo guardare muto