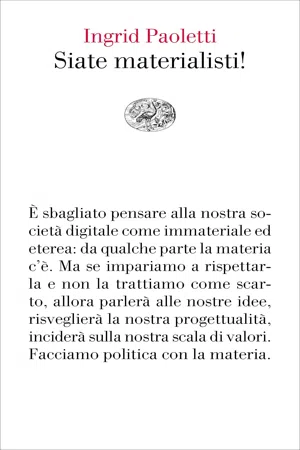Chi è il materialista?
Nel linguaggio comune, il materialista è una persona che persegue fini puramente utilitaristici o vive preoccupandosi soprattutto di godere dei beni terreni, del piacere dei sensi.
Nell’antica contrapposizione tra spirito dell’uomo – mosso da valori o dèi –, e materia, fredda, statica e quasi ostile, in fondo inciampano un po’ tutti i filosofi dell’antichità.
Anche se non è materia strettamente da architetto, sono partita dall’affermazione di Charles Wolfe1, secondo cui ogni materialismo è legato agli avanzamenti della scienza e della tecnologia di ogni specifico periodo storico. In un’accezione dilatata, il materialismo abbraccia non solo ciò che preesiste, cioè il materiale su cui si opera, ma anche chi compie le trasformazioni, la legge che ne permette il compiersi.
La grande domanda che ci riguarda potrebbe essere allora: se la conoscenza delle leggi della natura richiede una continua rifondazione delle teorie e la società muta velocemente nelle sue dinamiche, quale può essere un materialismo nel quale riconoscersi?
Senza addentrarmi in una «materia» che non conosco a fondo, vorrei tentare di mettere a fuoco qualche declinazione contemporanea di materialismo allo scopo di delineare un concetto di materialità che possa guidare le nostre azioni innovative di cittadini e progettisti.
Un taccuino virtuale mi ha accompagnato in questa ricognizione. Con stupore, a ogni ricerca, sono incappata in un aggettivo o prefisso diverso: dal materialismo culturale a quello speculativo, da una rivisitazione di quello dialettico a quello antropologico, dal cosiddetto «nuovo» materialismo sino all’eco-materialismo.
Di questi, tre mi hanno interessato particolarmente, poiché vicini alle riflessioni che sto con voi percorrendo.
Il piú ricorrente è stato sicuramente il «nuovo materialismo».
Esso compare di recente, alla fine degli anni Novanta, ispirato da Alain Badiou e Slavoj Žižek2. Alcuni accenni al nuovo materialismo si trovano già negli scritti di Althusser, che sfuma il determinismo storico di Marx sostenendo la fluidità e l’indeterminatezza delle condizioni relative alla società di allora, cosí come a quella di oggi.
Questa corrente può essere ascritta al material turn, un movimento delle arti e delle scienze sociali e umane che fa riferimento a una svolta di ritorno alla consistenza materica del mondo. Focalizzandosi sulle materialità non solo ontologiche, ma includendo i corpi (umani e non), gli spazi, e anche le forze che agiscono sulla sfera terreste (gravità e tempo), questa corrente si innesta su molte tendenze contemporanee legate al genere.
Su questo materialismo si inseriscono le tesi di Rosi Braidotti e Karen Barad, due femministe molto attive sul tema del nuovo materialismo come propulsore di forza etica. Braidotti nello specifico sostiene un materialismo che non implica una visione della materia inerte o spenta, ma la propone come forza capace di auto-organizzarsi e di accendersi in molteplici movimenti, assemblaggi, connessioni. La vitalità della materia che non è piú solo natura, ma neanche solo tecnologia, in una visione antropologica3.
La seconda forma di materialismo che interessa qui è quella digitale, secondo la quale il software occulta le tracce materiche dell’hardware. La forza del progresso, attraverso i risultati ottenuti con le tecnologie informatiche, riduce la consapevolezza dell’impatto materiale delle stesse sia nelle pratiche quotidiane sia nella piú grande scala ambientale.
La tesi è che i nuovi metodi digitali sfumano la percezione del reale a favore di un’epistemologia che promette di ridefinire le categorie di oggettività e soggettività fondendole attraverso la raccolta dati, l’intelligenza artificiale e gli strumenti computazionali4.
È come se il dato diventasse soggettivo, perdesse la sua connotazione di prodotto frutto della nostra evoluzione e cultura.
Infine, ma il piú importante per il nostro tema, il materialismo denominato «sostenibile».
Il materialismo sostenibile è centrato sull’utente/attore del nostro periodo storico che influenza con i suoi comportamenti “dal basso” la società e di conseguenza la politica. Una ricerca australiana durata quasi cinque anni ha raccolto i comportamenti di attivisti su tre settori, alimentazione, energia e moda, andando a vedere come si instaurano le dinamiche di questi movimenti e il loro impatto sulla società5.
Ne è scaturita una vera e propria ecologia politica dove tutto ciò che facciamo localmente ha conseguenze sul clima globale; d’altro canto le nostre piccole azioni individuali di mitigazione devono essere inserite in un quadro piú ampio per avere un effetto osservabile. Il tratto piú evidente di questa corrente è l’analisi dei comportamenti attivisti come una forza sistemica globale e non solo per l’uso di materiali sostenibili, riciclati o a base naturale come alternativa a catene produttive poco trasparenti6.
Lo sapevamo già che la materia non è ontologicamente informe e tutto il mondo non è che atomi (come nelle teorie riduzioniste) né all’opposto che lo spirito è slegato e superiore. Se il materialismo è legato a doppio filo con la scienza, la cui frontiera è rappresentata oggi dalla fisica quantistica, è impossibile darne una definizione che non sia provvisoria, perché per quanto la carotiamo, c’è sempre un punto nel quale la materia si apre nuovamente e occorre fare altre indagini.
Dove non ci sono risposte certe, è necessario un cambiamento di prospettiva.
Una matericità nuova sostenuta dalla scienza che chiama in causa un nuovo modello sociale. Un modello anche economico, che regola i rapporti umani sia nell’ottica del contenimento della sperequazione della ricchezza che nella creazione del valore e di un rinnovato interesse per un materialismo come elemento centrale delle dinamiche sociali. Mariana Mazzucato sostiene che
per un reale cambiamento dobbiamo andare oltre i singoli problemi e sviluppare uno scenario che ci permetterà di plasmare un nuovo tipo di economia: una che lavorerà per il bene comune7.
Comune nel senso che ci rende simultaneamente umani, sociali, politici. È il capitale sociale che rappresenta la nostra umanità, è l’unico principio che ci permetterà, nel prossimo futuro, di includere l’uomo nel disegno, di considerarlo, con il pianeta e con la materia, un bene comune8.
Il materialismo di oggi non è piú un contropotere come un tempo, in opposizione ad altre ideologie, ma è un vero e proprio ingaggio sociale e politico.
Persiste tuttavia un’ultima ambiguità. Spesso con «Sei un materialista» intendiamo definire il nostro interlocutore come un consumista, un insensibile alla cosa comune. È l’inutile che diventa utile, il soddisfacimento di un desiderio imperante.
Già negli anni Settanta, Ugo la Pietra ammoniva:
il nuovo consumismo sembra quindi un atteggiamento che si va diffondendo rapidamente e senza critiche, senza riflessioni, senza contestazioni, anzi, il vero problema sembra essere quello di capire quali sono e saranno i desideri dei nuovi ricchi e in che misura si potrà creare «in tutti» almeno la sensazione di essere ricchi9.
Consumista come ideale di ricchezza e benessere, talmente radicato – secondo Geoffrey Miller – da avere a che fare con le dinamiche dell’evoluzione della specie. Come racconta in modo spiritoso:
Il genere umano si è sviluppato in piccoli gruppi sociali nei quali immagine e status erano fondamentali, non solo per sopravvivere, ma per intessere relazioni con i propri simili, fare colpo sugli amici e crescere i figli. Oggigiorno noi ci dotiamo di beni e servizi piú per colpire gli altri che per goderne […] In fondo, il capitalismo consumista non è «materialista», ma «semantico». Ha piú a che vedere con il mondo psicologico di segni, simboli, immagini e marchi che con il mondo fisico dei prodotti concreti10.
Il consumismo non è quindi in alcun rapporto reale con la materia.
Perché i materialisti sono cosí diffusi, credo dipenda dalla vita frenetica di oggi, che produce anch’essa come scarto la necessità di sfogare la pressione e la fatica nell’acquisto. Marchi famosi hanno fatto della gratificazione immediata a basso prezzo un successo planetario sostenendo l’economia del consumo. A condizione di avere il denaro per acquistare la merce, ma si tratta comunque di spreco. Quali visioni politiche contiene questo materialismo?
Sulla potenza commerciale le multinazionali hanno costruito grandi ricchezze. Le catene alimentari conoscono tutto di noi, le nostre abitudini di acquisto e i nostri gusti, riuscendo persino a riconoscere la paura del consumatore: quando le persone temono qualcosa cominciano a comperare piú dolci.
Eppure possiamo fare qualcosa. Un caso emblematico è quello di Walmart, che ha deciso di levare dagli scaffali dei grandi supermercati americani le munizioni delle armi semiautomatiche. Forse a un europeo questo sembra un gesto scontato, e facciamo persino fatica a immaginarci che sullo scaffale di un supermercato si possa trovare tra detersivi e biscotti una scatola di pallottole, eppure è il segno di un risveglio del tessuto sociale, cosí forte da pungolare le grandi lobby di potere.
Ecco, riuscite a intravedere la potenza di un altro tipo di attenzione all...