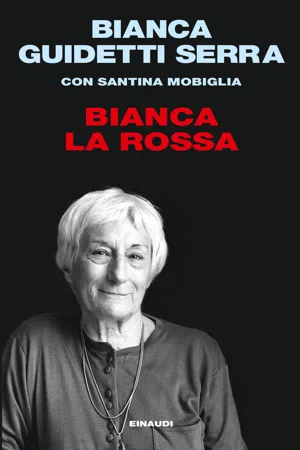Erano i primi d’ottobre del 1967, un appuntamento come tanti nel mio studio. La donna seduta di fronte a me, dall’altro lato della scrivania, si chiamava Argenide Rovoletto: «Ha visto che cosa ha combinato Adriano?» esordí, porgendomi alcuni giornali in cui avevano un gran risalto l’immagine del figlio e dei suoi amici. Titoli vistosi parlavano di «mostri», di «belve umane». «Li ho visti», assentii. Lei scosse il capo e si coprí il viso con le mani; mani forti, segnate dal lavoro di venticinque anni alla Snia Viscosa. Non era vecchia, ma il suo volto incorniciato dai capelli grigi che portava arrotolati dalla nuca tutt’intorno alla testa, fin verso le tempie, appariva provato e stanco. Ci conoscevamo da tempo. Quante volte era venuta a consultarmi (era il 1962?) mentre assistevo il figlio nella causa di separazione coniugale, preoccupata della sorte del nipotino! Ora si trattava di ben altro: mi proponeva di difendere il figlio per quanto accaduto a Milano e altrove. «Siamo pensionati», mi disse, «l’altra figlia non è in salute. Ma per i soldi faremo tutto il possibile».
Quanto accaduto a Milano, il 25 settembre, era stata una sanguinosa sparatoria per le vie della città durante la fuga in automobile di un gruppo di rapinatori che, dopo l’assalto a due banche, si erano visti braccati dalle volanti della polizia lanciate al loro inseguimento. In quella sorta di folle gincana in mezzo al traffico, durata per oltre mezz’ora lungo un percorso di dodici chilometri, ci furono quattro morti e quattordici feriti tra i passanti, otto i feriti tra le forze dell’ordine. Si chiuse cosí, con quel pomeriggio di fuoco e la cattura nel giro di pochi giorni di tutto il gruppo, l’attività della banda anonima (e agli occhi degli investigatori anomala) che per quasi nove anni, prima in modo episodico, poi sempre piú sistematico, aveva messo a segno i suoi colpi muovendosi tra Torino e Milano. Ne facevano parte Piero Cavallero, Sante Notarnicola e Adriano Rovoletto, piú un quarto componente, D. L., non ancora maggiorenne, coinvolto solo nell’ultimo colpo. Al processo i tre principali imputati dovettero rispondere di cinque omicidi, ventuno tentati omicidi, ventitre rapine di cui diciassette a banche, oltre a vari altri reati minori.
Accettai la difesa di Rovoletto, non mi ritrassi di fronte alla richiesta della famiglia e al diritto dell’imputato. C’era anche da parte mia un interesse a capire in quali pieghe sociali aveva potuto trovare le sue radici la banda, che aveva come entroterra l’ambiente operaio di quella barriera di Milano che conoscevo bene.
Quel medesimo pomeriggio, per curiosa coincidenza, un paio d’ore dopo mi trovai ad ascoltare, seduta sulla stessa sedia di fronte a me, Marianna Cavallero, madre di un altro degli arrestati: colui che sarebbe risultato l’ideatore e il capo della banda. Con lei la conoscenza risaliva a tempi ancora piú remoti. Era stata una delle mie prime clienti. L’avevo aiutata per l’affiliazione di una bambina affidatale dagli uffici di assistenza della Provincia. Le si era tanto affezionata che aveva voluto, dopo i tre anni prescritti, rendere piú stretto il legame. Conservo ancora il suo «Libretto di scorta», cosí si chiamava il documento che accompagnava i minori abbandonati, con stampigliati nome e cognome inventati dall’ufficiale dello Stato civile e, sotto, due tratti di penna paralleli a indicare i genitori sconosciuti – già un timido progresso del dopoguerra rispetto alla sigla N.N. (nullum nomen) che nel passato marchiava i «figli di nessuno». «Me la ricordo bene quella bambina», mi avrebbe detto anni dopo Piero Cavallero, «cosí smorta e patita! quando è arrivata a casa nostra, la prima cosa che ha fatto mia madre è stata d’infilarla in una tinozza di acqua calda per lavarla bene. Ne aveva cosí bisogno!» Era il 1951. Ma quel pomeriggio d’autunno del 1967, alla domanda della signora Marianna di assumere la difesa del figlio, dovetti rispondere di no. Avevo appena accettato quella di Rovoletto, le spiegai, eravamo all’inizio dell’istruttoria e sembrava esistere qualche contrasto tra le posizioni dei due coimputati.
Con entrambe le madri, tuttavia, avrei continuato a intrattenere rapporti, frequenti da principio, piú radi con il trascorrere degli anni. Ripeteva a ogni incontro la signora Argenide: «So che l’ha fatta grossa, è giusto che paghi. Gli ho persino scritto che se scappa, lo denuncio io! Ma mi dia una speranza: potrò un giorno o l’altro rivederlo fuori?» Marianna Cavallero era invece assillata da un interrogativo: «Chi può capire perché ha fatto quello che ha fatto?» Morí sola, assistita dai vicini, nel 1977.
Non ho mai conosciuto la mamma di Notarnicola. Tra le mie carte conservo però una breve poesia del figlio intitolata A mia madre. È dattiloscritta, datata San Vittore 1967, dunque poco dopo l’arresto, e recita: «Io il tuo dolore, io le tue rughe. Io il tuo volto tormentato, io | Quel segno sulla fronte: io | I tuoi capelli bianchi: io | Mamma: tu ed io».
Non voglio, con questi accenni, scivolare nel patetico o presentare in una luce edulcorata i ritratti di quelli che sono i «cattivi» della storia. Tento di ricomporne i frastagliati contorni per come ebbi modo di conoscerli dopo la condanna, quando, occupandomi dei risvolti giudiziari e carcerari che li riguardavano, instaurai con loro dei rapporti che mi hanno consentito di seguirne in qualche modo i percorsi di vita nei lunghi anni di galera. Racconto questa storia legando tra loro momenti diversi, attraverso brani di lettere e documenti, frasi a suo tempo annotate o fissate nella memoria, stralci di conversazioni registrate nel corso di vari incontri.
L’istruttoria procedette celermente e già nel luglio 1968 si arrivò alla sentenza, scontata, di condanna all’ergastolo, confermato poi nei successivi gradi di giudizio per i tre principali imputati. Solo il giovane minorenne ebbe una pena piú mite e venne assolto in appello per «immaturità psicologica», attestata dalle perizie. Con gli accertamenti in sede processuale caddero due delle imputazioni di omicidio per la sparatoria di Milano, di cui non erano risultate chiare le dinamiche e le responsabilità nel fuoco incrociato con la polizia; dall’insieme delle attività delittuose della banda emergeva comunque una materia sufficiente a giustificare il massimo della pena.
L’indagine e il dibattimento ebbero una vasta eco mediatica, come si direbbe oggi. Prima che iniziasse il processo era persino già uscito nelle sale di tutta Italia un film, Banditi a Milano, del regista Carlo Lizzani, che amplificava l’onda emotiva suscitata dai tragici fatti. Ricordo che noi avvocati difensori protestammo chiedendo, inutilmente, una sospensione delle proiezioni in attesa del giudizio, che poteva essere influenzato da una ricostruzione spettacolare della vicenda.
Ciò che risultò piú sorprendente nel corso delle udienze fu l’atteggiamento degli imputati i quali, piú che a negare le loro responsabilità rispetto ai fatti delittuosi, sembrava tenessero soprattutto a rivendicarne le motivazioni ideali, in nome di una rivoluzione politica e sociale che passava attraverso gli assalti alle banche, emblematici «santuari del capitale». Al pronunciamento della sentenza, in piedi e levando il pugno chiuso, intonarono Avanti, siam ribelli!, celebre ritornello del vecchio canto di protesta Figli dell’officina. Sulla lunga attività criminosa della banda era stata peraltro fatta piena luce a partire dall’ampia e spontanea confessione, resa il giorno stesso della cattura, da Rovoletto, che elencò anche azioni di cui nessuno lo sospettava. Il suo era stato un ruolo gregario, di secondo piano nel gruppo di cui era entrato a far parte solo negli ultimi tre anni. Era bravo a guidare avendo fatto il carrista durante il servizio militare, e svolgeva la funzione di autista nelle rapine.
Anche i metodi delle loro azioni erano piuttosto insoliti. Due o tre banche assaltate, una dopo l’altra, nello stesso giorno: colpi multipli messi in atto in veri e propri raid fulminei, con ostaggi presi come scudo negli spostamenti; attacchi replicati a distanza di tempo contro le medesime agenzie, non senza far trovare, talvolta, nelle macchine abbandonate dopo le rapine, la segnalazione della banca che sarebbe stata presa di mira la volta dopo; persino l’invio di lettere di preavviso che dettavano le regole di comportamento da tenere al momento dell’irruzione. «Era una specie di sfida militare» commentava Cavallero nel 1991, nel corso di una conversazione in cui rievocammo il suo passato.
Lo chiamavamo il «birillo» l’agente che stava di guardia e la soddisfazione piú bella era di andare a disarmarlo […]. E quando leggiamo che la polizia ha chiesto rinforzi, che ci sono piú pattuglie, che hanno messo gli allarmi contro i rapinatori, che dicono: se arrivano li aspettiamo… E noi: «Come, ci sfidano, e non andiamo?» Vede a che livello eravamo? Rovoletto, che era il piú ragionevole, non voleva mica venire: per carità, voi siete matti, diceva! Lí ci siamo fregati, proprio da stupidi…
E all’origine di questa sfida spavalda e provocatoria c’era una carica sovversiva, un’idea dell’azione esemplare che pretendeva di dare un senso politico alla loro rivolta privata e istintiva. «Fui un precursore della lotta attuale degli estremisti comunisti, cioè i filocinesi», aveva dichiarato Cavallero in tribunale nel 1971. «Il mio fine non era di giungere a commettere, però, atti terroristici. Volevo compiere atti di propaganda scioccanti per l’opinione pubblica».
«È durata nove anni quella nostra storia», mi raccontò poi quando ne conversammo piú di vent’anni dopo. «Ero stato licenziato nel 1958-59, quando licenziavano tutti. Rovoletto, per parte sua, era nella stessa condizione, era disperato […]. E Danilo Crepaldi1 che mi dice: “Sai che mi hanno licenziato alle Ferriere? Mi piacerebbe castigarli”. Come fare? “Ma, sai, alla sera, alle dieci c’è il cambio turno…”». Erano cominciate cosí, con una rapina di sei milioni di lire alle casse della Fiat, le azioni a mano armata del gruppo, che aveva in comune un passato di militanza comunista nel quartiere. Cavallero ne era l’elemento trainante e fascinatore, con il suo eloquio persuasivo e le suggestioni rivoluzionarie che ne facevano «l’idolo dei ragazzini», come disse al processo Notarnicola, arrivato a Torino dalla Puglia nel 1953, all’età di tredici anni. Era venuto con la madre, separata dal padre, dopo un periodo trascorso in collegio: «Fui ospite di un mio zio, ex partigiano comunista. Abitavo in un rione popolare, la barriera di Milano, dove c’era un proletariato attivo; frequentai l’ambiente e mi trovai bene. Cosí mi resi conto delle ingiustizie sociali esistenti». Riprendo ancora le sue parole, sempre tratte dalle deposizioni ai processi di primo e secondo grado, nel 1968 e nel 1971:
In quel tempo conobbi Cavallero. Egli era dotato di una forte personalità – ce l’ha ancora – ed aveva un seguito di giovani che gli giravano intorno. Conobbi anche Crepaldi, il quale per me aveva un fascino particolare essendo stato uno dei piú giovani partigiani; nel 1948, dopo l’attentato a Togliatti, fu il primo operaio torinese che innalzò la bandiera rossa su una ciminiera della Fiat. […] I miei idoli allora erano Lenin, Stalin, Togliatti e non i campioni sportivi o altro. […] Arrivò il 1956, il nuovo corso del partito comunista sovietico; smettemmo di sognare […]. Un giorno mi dissero che Stalin era stato un criminale; Togliatti diceva che non c’era piú la rivoluzione. Nel partito c’era il caos. […] Ero turbato, confuso, erano caduti certi nostri miti. Cominciò cosí un periodo di lunghe discussioni e ripensamenti […]. Intanto Crepaldi, Cavallero ed io facevamo discorsi sulla maniera migliore di scuotere le masse: era necessario ricorrere al terrorismo per scuotere le masse?
Rimasero discorsi teorici fino al colpo alla Fiat, poi ci fu una pausa. Notarnicola era partito militare, al suo ritorno ripresero «i discorsi di natura rivoluzionaria: Cavallero proponeva di assaltare le banche; anche io ritenevo ciò politicamente giusto. […] Poi si decise di rompere gli indugi e attaccammo decisamente». Era il 1963.
Per quanto sempre piú vaga e relegata sullo sfondo, restava nel gruppo l’idea che il denaro accumulato dovesse servire a porre le basi di una fantomatica «organizzazione» rivoluzionaria. I membri percepivano una sorta di stipendio mensile, non particolarmente lauto, ed erano tenuti a mantenere il livello di vita precedente, regola utile anche a non dare nell’occhio. Una parte dei bottini venne investita in imprese economiche (un garage, una carrozzeria, una ditta di penne stilografiche) che non dettero però i frutti sperati in vista del salto «organizzativo» sul piano politico. Cavallero fantasticava anche di attacchi alle caserme dei carabinieri.
Mi intrigava e mi rimordeva, in quegli imputati dietro le sbarre, il richiamo al mito della Resistenza, distorto in termini di un’epica delle armi e tradotto in atti di banditismo contro la società. Anche perché mi ricordava altri casi, di molti che nell’immediato dopoguerra, dopo l’esaltazione del periodo della lotta armata, non erano riusciti a reintegrarsi nella vita normale, proprio come il protagonista del romanzo di Fenoglio La paga del sabato, il «duro» e sbandato che non riesce a riadattarsi alla routine. Nelle personalità e negli atteggiamenti degli imputati, dietro i soliti profili criminali, in quel modo di proclamare le loro motivazioni politico-sociali si sarebbe anche potuto intravedere un sotterraneo mutamento che annunciava delle velleità da «banda armata». Ma era difficile, allora, cogliervi una premonizione di fenomeni che si sarebbero manifestati negli anni Settanta.
Nell’arringa che pronunciai al termine del processo, il 3 luglio 1968, oltre alla difesa tecnica del mio assistito, volli sollecitare uno sguardo meno distratto e infastidito di quello con cui venivano accolte le motivazioni ideologiche addotte dagli imputati nel render conto delle loro imprese. Perché non prenderle sul serio, visto che non potevano sostanzialmente mutare la pena? Non posso riprendere le mie parole di allora perché, ben convinta della maggiore efficacia del parlare a braccio – tanto piú nei processi importanti – come mia abitudine mi ero limitata a fissare in poche righe i punti da trattare, che rivedo in un foglio ingiallito tra le mie carte. Uno di questi era l’idea che meritasse una pubblica riflessione quell’intreccio di sovversivismo e attività criminose presente nella «rivoluzione personale» di Cavallero e dei suoi adepti su una strada, argomentai, che non era priva di analogie con la storia di certe frange anarchiche e illegaliste, da Ravachol alla banda Bonnot, approdate al «gesto» dalle conseguenze funeste. Ero e sono convinta che i casi estremi e devianti vengano da un contesto, e abbiano qualcosa da dirci su ciò che si è inceppato nei normali meccanismi di funzionamento di una società. E che gli imputati, rei confessi, andassero riconosciuti come persone nella loro interezza, il che non diminuiva le loro responsabilità. Conclusi perorando un deciso no all’ergastolo, incompatibile con il principio costituzionale che assegna alla pena una finalità di recupero del condannato, al quale non può dunque essere negata la speranza in un futuro oltre le sbarre. Quando, a sentenza appena pronunciata, nella camera di sicurezza, li vidi stravolti, già ammanettati in mezzo a un fitto cerchio di carabinieri, cedetti all’impulso di salutarli con un abbraccio. Un gesto istintivo e simbolico per esprimere nei loro confronti, e in linea di principio, l’inaccettabilità della condanna a vita, quale che sia la colpa.
Molti furono i commenti, sugli organi di informazione e tra la gente, unanimi nel plauso alla condanna. Un solitario gruppetto sedicente anarchico, con un volantino ciclostilato, espresse solidarietà ai condannati. Me ne giunse copia per posta. Mi arrivò anche, anonima e lapidaria, una lettera: «Lei, una donna, ha difeso quei banditi. Non si vergogna?»
Con la sentenza si voltava comunque pagina. Si chiudeva la prima parte, quella piú drammatica, della storia. Dopo i delitti, era la volta delle pene. Cominciava, fuori dal clamore delle cronache, un secondo atto, quello che piú mi interessa raccontare, relativo alle vite di galera dei condannati con i loro percorsi per molti versi esemplari di quella «rieducazione» di cui parla, all’articolo 27, la nostra carta costituzionale. Al di là del mio ruolo di difensore di Rovoletto, conclusosi con la sentenza di Cassazione del 1973, con tutti loro, per ragioni varie e diverse, continuai ad avere saltuariamente dei rapporti. Fu cosí che frammenti della loro vita di detenuti e della mia vita di lavoro talvolta si intrecciarono. Frammenti che ricompongo per testimoniare, insieme alle singolarità delle loro storie, aspetti della condizione obiettiva e del vissuto soggettivo dell’esperienza carceraria per chi si trovi ad affrontarla.
Qual era stata la prima sensazione all’ingresso in carcere? Alla mia domanda, che gli feci molti anni dopo, Cavallero rispose:
Le confesso, lí per lí è stato come un distendersi, un riposarsi. Eravamo sfiniti non solo fisicamente. Per una settimana non avevamo fatto che scappare, da un paese all’altro, cercando di evitare le strade principali, salendo sui treni secondari, quelli dei pendolari, per non farci notare. No, non era ancora il momento di pensare, di approfondire che cosa era successo. Non vedevamo nessuno. L’unica era leggere. Per me e Notarnicola era sopportabile […]. Piú dura è stata per Rovoletto, lui era stato arrestato subito, era anche stato lievemente ferito a un braccio. A leggere non era abituato. Soffriva molto di piú […]. Sentivo che si lamentava, che gridava: «m’impicco, m’impicco!» È durato fino alla fine dell’istruttoria l’isolamento. Poi ci hanno messo in una sezione normale, le cose sono andate un po’ meglio.
Notarnicola mi parlò invece del suo ingresso ormai da ergastolano, dopo la sentenza di primo grado, nel carcere duro di Volterra:
Era di sera. Arrivo e mi portano in una specie di corridoio […]. C’era un televisorino e una cinquantina di persone, tutte anziane. Vedo tutti questi vecchi ergastolani «senza fine», seduti su sgabelli, in silenzio, che guardano […]. Il giorno dopo vado all’aria per la prima volta: un impatto traumatico. Chiedevo: quanti anni hai? Eh, settanta, settantacinque. Quanti anni hai fatto? trentacinque, quaranta. La media aveva fatto trenta-trentacinque anni, ma c’era chi aveva fatto di piú. Lí vidi l’ergastolo, proprio lo vidi e che cosa significava. Aggiunga piú di venti ore chiuso in cella, la mancanza di servizi igienici, c’era ancora il «bugliolo», il cibo pessimo e scarso […]. Allora non puoi non averne una reazione vivissima. Prima ti dici: no, non posso accettare tutto questo e pensi di farla finita, pensi che vai in cella e attacchi una corda […]. Ecco, passi questo travaglio. Poi viene la ribellione. Cosí cominciai a sentirmi innocente nonostante la pesantezza delle imputazioni delle quali ero cosciente. E cominciai a reagire anche per l’aggressione personale dei giornali, del cinema, di tutto […]. Tutte queste cose messe insieme mi tirano fuori un’aggressività costruttiva, non piú distruttiva come quella che aveva caratterizzato la nostra storia […]. E ci fu un vecchio siciliano, aveva fatto quarant’anni questo qui, e dato che gli facevo sempre delle domande si era creata una specie di simpatia tra noi. Ero il piú giovane ergastolano […], allora mi diceva: «Guarda,...