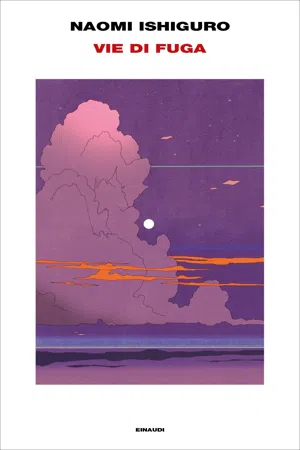Alfie camminava per le dune sassose della spiaggia di Brighton, diretto al chiosco dei gelati, quando un bambino pel di carota con un frisbee gli andò addosso, ed entrambi finirono gambe all’aria. Trattenne un urlo appena in tempo e fece del suo meglio per sorridere, perché il bambino era uno di quelli che aveva visto sguazzare tutti insieme, come cagnolini, al bordo dell’acqua e gridarsi l’un l’altro cose strane e misteriose come «Alla tua faccia!» e «Bangherang!», ridendo apparentemente senza motivo.
– Ciao, – disse al bambino con il frisbee.
– Ehi, – fece quello, che era già in piedi e pronto a schizzare via, gli occhi puntati sul folto crocchio di amici che lo aspettavano sul bagnasciuga agitando le braccia. Lanciò loro il frisbee – una vivida macchia arancione contro l’azzurro profondo del cielo – e poi finalmente si rivolse ad Alfie.
– Perché sei vestito cosí? – disse soltanto. – Sei molto strano.
E tornò dagli altri, lasciando Alfie a tirarsi su da solo da quei sassi scomodi e a lisciarsi i pantaloni e la camicia a righe che la mamma gli aveva comprato apposta per le vacanze.
Ma non importava, si disse. Quei bambini non avevano l’aria divertente, comunque. Tanto per cominciare, probabilmente erano piú piccoli di lui, e quasi di sicuro noiosi, se si grattava un po’ sotto la chiassosità e i sorrisi. I bambini chiassosi lo erano spesso. E poi cos’avrebbe detto la mamma se avesse rinunciato alla «missione gelato» per unirsi a loro? Se guizzando verso le onde si fosse tuffato in quel rumore, in quegli acuti scoppi di risa e in quel caos di ghiaia finissima sollevata a calci? «Te la caccerai negli occhi, – avrebbe detto, – o, peggio ancora, la caccerai negli occhi di qualcun altro». E se fosse corso verso il luccichio dell’acqua che, sparsa nell’aria da dita danzanti, catturava la luce di quella giornata d’aprile di un caldo torrido fuori stagione, avrebbe detto: «Laverà via la crema solare, e sappiamo questo cosa vuol dire, vero? Vuol dire “cancro alla pelle”, Alfie, amore, e chi riderà allora?»
Solo che Alfie non aveva idea di chi avrebbe riso. Probabilmente quei bambini, che avrebbero continuato a sguazzare come una muta di cagnolini lí a riva sulla spiaggia di Brighton, mentre lui giaceva in un letto d’ospedale con indosso un camice a pois, attaccato a uno di quei giganteschi macchinari pieni di tubi, di quelli che si vedono nei programmi televisivi e nei film quando la gente è malata. E poi sarebbe stato calvo come i bambini con il cancro che facevano vedere a Comic Relief e a Children in Need, perché anche lui sarebbe stato un bambino con il cancro, come diceva la mamma, mentre quelli là giocavano ancora.
Ma stava perdendo tempo. La mamma e Wallace si sarebbero chiesti dov’era. Si diede una scrollata e riprese a camminare verso il chiosco dei gelati, anche se era piú difficile di quanto sembrava perché i piedi gli sprofondavano nei mucchi di sassi e c’erano persone, coperte e roba da spiaggia ovunque.
Se succedeva davvero, pensò camminando, se diventava sul serio un bambino con il cancro, doveva solo fare in modo di sopravvivere fino al suo undicesimo compleanno, quando i suoi poteri magici si sarebbero manifestati. Allora sarebbe andato a lezione e avrebbe imparato a guarirsi da solo, perché ai maghi come era destinato a diventare lui (dubitava che fossero maghi anche quei bambini, quei cagnolini ridanciani) il cancro non veniva e, se gli veniva, si riprendevano subito, perché erano dotati di miracolosi poteri di autoguarigione. Quindi di fatto, in virtú delle sue facoltà latenti, la crema solare e il tenersi alla larga dall’acqua non avevano importanza, e la mamma si sbagliava, si sbagliava di grosso.
Ma Wallace dalla faccia rossa l’avrebbe inevitabilmente spalleggiata, e dover spiegare la faccenda e discutere mentre loro gli davano del «testardo», del «disobbediente» e dell’«ingestibile» sarebbe stato cosí faticoso che era meglio lasciar perdere. A essere sincero, forse preferiva aspettare di avere undici anni prima di abbandonare la crema solare, perché non voleva essere un bambino con il cancro senza poteri magici. Avrebbe atteso il suo momento. Sapeva comportarsi in modo saggio. A scuola la signorina Lennox diceva spesso che era molto saggio per la sua età. Gli stava simpatica, nonostante quei denti strani e quel modo curioso di pronunciare la «s». Povera signorina Lennox. Sarebbe stato triste salutarla da lí a dieci mesi, quando sarebbe diventato un mago. Del resto sarebbe stato piú triste salutarla con il cancro, quindi forse gli conveniva obbedire alle regole della crema solare. Niente mare. Niente spruzzi. Niente urla e balli al bordo dell’acqua. Avrebbe aspettato.
Voltate le spalle ai bambini, arrancò per l’ultimo tratto di spiaggia e poco dopo si trovò davanti il gelataio, un uomo con la faccia sciupata e uno spuntone nel lobo dell’orecchio.
– Due 99 Flake, per favore, – disse. – E un sorbetto al limone.
Nella penombra del suo capanno da chiromante, l’indovino Luciano, detto anche Peter – e talvolta pure «amico» e «vecchio» dai fattoni della spiaggia di Brighton, visto che era un ventottenne bianco con i rasta che indossava sistematicamente le infradito a prescindere dalla stagione –, recuperò chiavi, portafoglio, occhiali scuri e bandana. Aveva deciso di chiudere in anticipo per godersi il pomeriggio: prendere un po’ di sole, rilassarsi ed entrare in armonia con la bellezza dell’Universo prima che, con il tramonto, si facesse buio. Non approfittarne sarebbe stato quasi un reato, dal momento che era soltanto aprile eppure faceva magicamente caldo, anche per il Sud dell’Inghilterra, anche per Brighton con il suo famoso microclima. Ah, il microclima di Brighton. Certo, l’indovino Luciano / Peter annuiva sempre con aria saggia ogni volta che qualcuno lo nominava, e come tutti in città ne confermava gli effetti, ma sul serio, a essere sinceri? Brighton gli sembrava grigia quanto qualunque altro posto d’Inghilterra.
Si distrasse un attimo e, canticchiando ad alta voce un pezzetto di The Great Gig in the Sky, si sistemò la bandana sull’imponente capigliatura («Cristo, – disse la vocina nella sua testa che spesso somigliava in modo seccante al padre, – non sei proprio Frank Sinatra, ti pare?»)… ma a cosa stava pensando? Prima dei Pink Floyd, di suo padre e prima di rendersi conto di quanto era stonato? Il microclima di Brighton, il caldo fuori stagione… e l’Universo! Ecco. L’Universo. Quella non era una giornata fatta per preoccuparsi, ma per riconoscere che fortuna, che benedizione fosse avere quella madre – sí, per lui era una madre – universale e amorevole. Era figlio dell’Universo al pari di chiunque altro, e perlomeno quello di buono ce l’aveva, e suo padre poteva andarsene al diavolo se non era d’accordo. Incastrò gli occhiali nel groviglio di rasta e bandana, si mise le infradito e uscí sull’asfalto. E poi amen, pensò, senza sapere di preciso a cosa si riferisse, perché il sole e l’improvviso calore sulla pelle l’avevano disorientato.
L’inverno era stato lungo: il peggiore dal 1996, diceva la gente, quando Giove era stato per l’ultima volta in cattivo aspetto con Saturno per tre settimane consecutive a febbraio, con Mercurio retrogrado. O era Venere a essere in cattivo aspetto con Saturno? Non ricordava bene, ma forse sí. Oppure era solo questione di prospettive, ed era Saturno a essere in cattivo aspetto con Venere, e Mercurio c’entrava poco. Piú tardi avrebbe controllato, ma… gli sembrava sbagliato lambiccarsi il cervello con quei pensieri astrusi, quasi accademici, quando guarda! Ecco Brighton, in tutto il suo splendore. Città leggendaria, punto d’incontro dei rivali mod e rocker, epici in groppa alle loro motociclette (per quanto, ogni volta che ne superava una schiera a un ritrovo, gridasse sempre dallo skateboard: «Amici, quei gas di scarico non fanno bene a Madre Terra»), sede dell’acclamato Royal Pavilion (bizzarro, coloniale, un po’ pacchiano) e fonte di decenni di cartoline sporche vendute alle bancarelle del lungomare, da spedire a parenti e amici sparsi per miglia e miglia all’intorno (con scritte che francamente l’avevano sempre fatto rabbrividire un po’). Ma nell’insieme era comunque un gran bel posto, pensò, mentre abbassava la serranda di ferro del capanno. Brighton, quella città, la sua casa adottiva. Era meglio che si sbrigasse a farsi coinvolgere: al buio mancavano solo cinque ore.
– Ciao, – disse una voce femminile alle sue spalle, proprio mentre girava la chiave. – Chiudi per pranzo, per la pausa caffè o solo un attimo per andare a comprare qualcosa, oppure per oggi basta e ho perso la mia occasione di farmi leggere il futuro?
Era americana e carina. Un sorriso accattivante: era stato fatto un bel po’ di lavoro su quei denti, forse anche sulla faccia. In altre parole, non era esattamente giovane. Neanche vecchia, neanche lontanamente, ma aveva un bel po’ di anni piú di lui, questo era sicuro. Tuttavia, un particolare lo colpí davvero quando se la vide davanti che batteva le palpebre all’ombra del capanno. Era della statura ideale.
Non che Luciano/Peter fosse particolarmente basso. Anzi, se qualche rara volta era capitato, in determinati contesti, che lo sembrasse, era solo perché in Inghilterra erano tutti alti da far paura. In Giappone, per esempio, il paese del mondo che aveva sempre considerato la sua autentica patria spirituale, sarebbe stato tranquillamente di statura media. Certo, a meno che i giapponesi non si fossero messi a mangiare le terribili schifezze capitaliste imbottite di ormoni della crescita che andavano in Occidente. Siccome però non era mai stato in Giappone, non avrebbe saputo dire che cosa mangiassero in realtà, né di conseguenza quanto fossero alti, ma quel che sapeva per certo – era evidente, pacifico e fuor di dubbio – era che quell’americana carina che lo guardava battendo le palpebre era esattamente dell’altezza giusta per consentirgli, qualora in via del tutto ipotetica l’avesse stretta in un tenero abbraccio («Non lusingarti, figliolo, – disse la voce paterna nella sua testa. – Se sapesse qualcosa di te, non ti guarderebbe due volte»), di appoggiare comodamente il mento proprio in cima alla sua meravigliosa testa scarmigliata. Doveva essere californiana, come i Beach Boys, la O’Neill e la fine della Route 66. Erano anime gemelle, naturalmente.
– Oh, – fece. – Piú avanti sul lungomare ne trovi un altro. Sapphire Blue. Anche lui legge il futuro.
Forse erano anime gemelle, ma lui era nervoso, d’accordo? Non capita tutti i giorni che l’Universo ti faccia trovare davanti al posto di lavoro una bella donna della statura ideale, che per giunta vuole parlare con te.
– Peccato, – disse lei, mordendosi l’unghia del pollice. – La mia amica mi aveva consigliato di venire da te. Dice che sei il migliore in tutta Brighton.
Luciano/Peter guardò l’ampia distesa digradante di sabbia e ghiaia scaldate dal sole, e i vacanzieri che si crogiolavano in quella grande libertà godendosi il panorama. Poi riportò gli occhi sulla donna. Si era messa a giocherellare con il ciondolo – un’ametista – adagiato sulla pelle lentigginosa del décolleté.
– È la tua pietra natale?
Lei annuí. – Acquario. Venere in prima casa.
Lui era Bilancia. Perfetto.
Le rivolse il suo miglior sorriso beatifico e si arrischiò a posarle una mano sul braccio. Aveva la pelle calda, soda e lievemente umida, e Luciano/Peter intuí che, se si fosse leccato le dita, avrebbe sentito il sapore del sale. («Che schifo», esclamò la voce paterna). Ma era questo che bisognava fare, no? Nei rari momenti in cui l’Universo ti offriva qualcosa di cosí lampante, giusto, sincronico.
– In tal caso, – disse, infilando la chiave nel lucchetto della serranda e riaprendo il capanno (acchiappasogni, carte celesti, sete indiane di vari colori: sperava che l’avrebbero colpita!), – credo che farò un’eccezione.
Tornato sulla coperta con la mamma e Wallace, Alfie si prese un momento per festeggiare (piano, senza chiassose manifestazioni di allegria) il puro successo dell’impresa. Già, perché aveva riportato i gelati senza spargere né rovesciare niente e senza nessun motivo per farsi chiamare «testardo», «disobbediente» e «ingestibile»! Lode al gelataio con lo spuntone nell’orecchio e al suo ingegnoso affare di cartone che permetteva di trasportare facilmente piú coni per volta. Grazie a lui, lo stato della sua missione era «compiuto». Ed era andata a gonfie vele, per dirla come la signorina Lennox. Gli diceva spesso cose simili, che lui non capiva fino in fondo ma che trovava bellissime, in parte forse proprio perché non le capiva.
«A gonfie vele». Piú avanti un aquilone verde e viola s’innalzò nel cielo azzurro trascinandosi dietro una coda di lustrini argentati. Aguzzando la vista, Alfie individuò il filo – lo spettro sottile di un tratto nell’aria – e lo seguí a ritroso nel disordine della folla fino a una ragazza con un vestito giallo. Era incredibile che li avesse adocchiati, l’aquilone e la ragazza, proprio quando aveva in mente quelle parole: «a gonfie vele»! Sembrava quasi che li avesse fatti apparire per magia, senza averne l’intenzione. La ragazza aveva qualche anno piú di lui. Perlomeno era molto piú alta. Alfie sfocò la vista finché non gli apparve come una semplice macchia gialla che il gioco della prospettiva rendeva simile a un narciso. Attaccò il gelato.
«A gonfie vele». Quando aveva riconsegnato le verifiche, passando tra i banchi nell’aula di matematica che puzzava di disinfettante – l’abituale ticchettio delle scarpe attutito dalle mattonelle verde spento –, la signorina Lennox si era fermata un attimo accanto al suo banco prima di posargli davanti quell’opera perfetta, la sua verifica con i procedimenti e i risultati annotati con calma e in ordine – come se fosse passato da una domanda all’altra con la calma sicurezza di Blofeld in Thunderball (anche se per la verità era nervoso, come sempre quando c’entrava la signorina Lennox, benché l’amasse, ovviamente) – e, accanto, una colonna di spunte rosse perfettamente regolari, specchio dell’affidabile correttezza dei suoi risultati, impilate l’una sopra l’altra come gli appartamenti di un condominio. A quel punto aveva detto: «A gonfie vele». E come aveva ballato Alfie quella sera, in camera sua. Aveva piroettato e si era lanciato trionfalmente sul copriletto, chiudendo gli occhi davanti al noioso soffitto con l’intonaco scrostato come davanti alla radiosità del sole, scoprendo dietro le palpebre l’azzurro e il rosa, il lilla e l’oro, che gli volavano intorno come frustate di pittura infuse di energia, come ali di pappagallo, come la seta del paracadute in quel gioco del gatto e del topo al compleanno di Imogen. Se fosse tornato lí, al compleanno di Imogen, dopo la splendida colonna di spunte rosse della signorina Lennox e le «gonfie vele», avrebbe volteggiato e strillato sotto il paracadute come tutti gli altri, senza preoccuparsi di quello che poteva succedere se scivolava per via dei calzini – se cadendo si fosse rovinato le ginocchia dei pantaloni o si fosse procurato un livido, una sbucciatura o uno strappo alla camicia che avrebbero fatto venire alla mamma quell’aria stanca e delusa –, non si sarebbe preoccupato di nulla e, quando l’avessero acchiappato e avesse perso, avrebbe riso piú forte di tutti. Sempre piú forte, piú forte di tutti quanti, fino a coprirli, allo stesso modo in cui il pensiero della signorina Lennox e delle «gonfie vele» copriva le urla e le risate dei bambini ancora raggruppati sulla riva. Anche quella era una specie di magia: quella capacità di coprire il resto, di volare.
– Alfie, amore. Ti stai rovinando la camicia, – disse Wallace il maldestro. E per una volta aveva ragione. Quelle dolci reminiscenze di gloria l’avevano distratto al punto che aveva permesso al 99 Flake di colargli lungo la manica destra della camicia nuova. Nessuno degli altri bambini in spiaggia aveva la camicia, ovviamente, sicché non importava se sgocciolavano con il gelato. Indossavano il costume da bagno e mostravano il tronco, come gli alberi. Perché lo sapevate che «tronco» è una parola che viene dagli alberi, usata fin dall’antichità per riferirsi al torso, segno che alberi e persone sono magicamente connessi? Alfie non lo sapeva finché non gliel’aveva detto la signorina Lennox, e lo trovava fantastico. Probabilmente, quando fosse arrivato il momento di apprenderla per bene, avrebbe scoperto che la vera magia aveva a che fare con quello: niente di stupido e bambinesco come «bibbidi bobbidi bu», «abracadabra» e altre sciocchezze da semplice animatore di feste, ma incantesimi fondati su perspicaci intuizioni di improbabili corrispondenze fra le cose, e l’anno dopo, durante il suo apprendistato da mago, la signorina Lennox gliene avrebbe insegnate molte altre. Ci sperava tanto. In quel caso forse non sarebbe stato costretto a salutarla. Già, perché che vita sarebbe stata, dopotutto, senza la signorina Lennox? Il solo pensiero lo riempiva di orrore, dato che «a gonfie vele» e tutto quello che evocava, tutto quello che significava, sbiadivano quando lei non c’era, anche solo durante le vacanze.
– Alfie, – disse la mamma. – Sta’ attento.
Alfie leccò il gelato fino a eliminare lo strato superiore sciolto dal sole e cercò di sorriderle. Lei si limitò a fissarlo mordendo con forza la sua pallina di sorbetto al limone, che chissà come era di un colore pallido e acceso allo stesso tempo, e sembrava cosí freddo che Alfie non capiva come facesse a mangiarlo tanto in fretta senza farsi venire il mal di denti, il mal di pancia e senza peggiorare il suo perenne mal di testa. E poi non era certo uno spasso mangiare in quel modo. Voleva dirle di smetterla e raccontarle della signorina Lennox e dei tronchi di alberi e persone, ma sembrava un sacco di roba da dire di punto in bianco, tutta insieme – da ordinare in parole e da spiegare in maniera che non f...