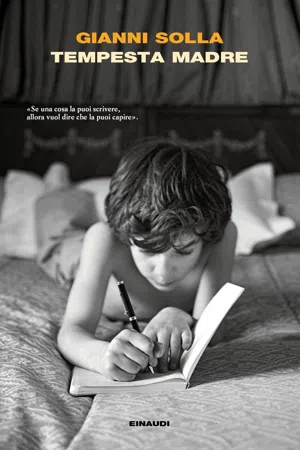A carnevale mia mamma mi vestiva da Hitler. Ma come le saltava in mente. Le mamme degli altri bambini non ci invitavano, e io e lei andavamo a festeggiare all’autogrill a Capodimonte con una finta copia del Mein Kampf appoggiata su un tavolino a forma di spicchio di pizza.
– Io, io, davvero non ci credo. Una totale mancanza di umorismo. Quelle donne cresceranno malissimo i propri figli. Sai che ti dico, Jacopo, mi dispiace per te, saranno quelle le persone con le quali dovrai avere a che fare nella vita.
Non ho mai sentito mia madre pronunciare una frase che non cominciasse per «io».
– Quelle due erano vestite peggio dei loro figli. Per non parlare dell’ombretto che aveva la rossa. Ja’, mi rispondi almeno una volta? Parlare con te è come parlare con un muro.
Lo sappiamo tutti e due che non ci invitano alle feste perché è lei che non vogliono. Le sue battute non piacciono a nessuno. Non vogliono la puzza delle sue sigarette che l’anticipa di cinque metri.
È giovedí, l’autogrill è vuoto, nell’espositore del bancone ci sono le pizzette invendute della mattina. Siamo al tavolino vicino alla vetrata e vediamo le macchine fare benzina. Con un tiro mia madre brucia mezza sigaretta.
Mentre va in bagno l’aspetto nel corridoio a pochi passi dall’uscita. Ascolto il rumore delle ventole che pompano aria calda e mi chiedo se sono sue le mani che si stanno asciugando. Le donne che escono sono stupite nel trovare un piccolo dittatore con i baffi.
Esce poi anche lei dal bagno, fumando e piangendo, le due cose che le vengono meglio. La vedo togliersi le lacrime dalla faccia con la mano aperta. Camminiamo affiancati verso il parcheggio, un dittatore e una donna che piange. Saranno questi i ruoli, nel plot della nostra vita. Anche se lei ha un unico desiderio, che suo figlio diventi un dentista oppure un ortopedico, e invece: sorpresa! Il bambino molesta le sue compagne di classe.
A casa faceva l’imitazione delle suore del Santa Sofia, l’istituto dove andavo a scuola. Usciva dall’armadio avvolta nella coperta scura, il fazzoletto bianco attorno al collo, e diceva con voce stentorea: – Jacopo, devo assolutamente parlare con quella scimunita di tua madre, questa situazione non può andare avanti. Ho detto che non deve fumare davanti al cancello, e che ti deve portare dal dottore perché hai i denti storti, – e poi crollavamo a terra tenendoci la pancia dalle risate.
– I tuoi denti sono bellissimi, – mi rassicurava e mi abbracciava.
Guardavo la corona di smalto bianco che le brillava nella bocca. Eravamo cosí sicuri che mi sarei trasformato in lei, che ci saremmo sovrapposti completamente. Mancavano ancora pochi anni prima di scoprire la verità, e riguardo ai denti, le suore avevano ragione.
Ero pronto a diventare quello che desiderava, la mia intelligenza, ereditata dal ramo della sua famiglia, non dall’altro che vedeva solo falliti e macellai con la terza media, non aveva limiti. Mia mamma, la segretaria della Brahms edizioni musicali, aveva capito che il figlio era un prodigio. Del resto, quando giocavamo a Memo trovavo in un attimo due carte uguali mischiate ad altre cento.
L’unico neo: non parlavo quasi. Emettevo dei versi che la mia genialità plasmava come parole. Ne avevo uno per ogni bisogno. E la segretaria mi capiva al volo, condividevamo un vocabolario amorevole e privato.
– Il bambino apprende con profitto, non ci sono segni di ritardo.
La parola «ritardo», pronunciata nel corridoio del Policlinico, faceva tremare la segretaria.
All’uscita del Santa Sofia ognuno di noi corre verso la propria madre. Ci ricongiungiamo alla carne che ci ha generato ogni giorno all’una. Nella corsa, le bambine della mia classe mi superano, io spingo sulle gambe compresse nei pantaloni di velluto a costine, ma resto dietro di un metro, sento il fiato mancare, supero il portone verde, e infine la vedo. Lei è la ragazza bellissima che fuma accanto al cancello. Mi guarda da sotto gli occhiali da sole con la montatura di celluloide e la seguo verso la macchina dove mi aspetta un sacchetto di patatine che quasi sempre è il mio pasto principale. Sono il figlio, dico. Il primigenio di una madre singola. Le parole che ascolto al Santa Sofia diventano le mie, e trovo continue similitudini tra la vita di Gesú e la mia.
Ma allora perché non le assomiglio? La bellezza, come la pazzia, delle volte salta una generazione.
All’epoca del ricovero di mia madre avevo trentun anni, lavoravo ai servizi sociali del Comune e partecipavo ai corsi di formazione pomeridiani per rimorchiare le colleghe divorziate. Rimediavo pochi appuntamenti ma in compenso ero diventato un mago di Excel.
Quella notte, una vicina di casa la riconobbe mentre vagava per il rione vestita da sposa. Era l’abito appartenuto a sua madre, tenuto come ricordo anche se a un certo punto avevano smesso di parlarsi. Fu mio padre ad accompagnarla in ospedale, rovinandole il matrimonio immaginario che aveva organizzato per sé stessa.
Di loro due insieme ricordo soprattutto i litigi, lei che urla in italiano e lui in napoletano. Litigavano in due lingue differenti, come i mondi da cui venivano. E io, per imitarla, scelsi l’unica lingua che avrei parlato per tutta la vita.
Gli infermieri andarono incontro a una donna sulla cinquantina vestita di bianco, con il velo, e la sigaretta accesa. Difficile credere che la segretaria, attraversando l’ingresso del pronto soccorso, non avesse canticchiato la marcia nuziale.
I medici che la visitarono non riscontrarono alcuna ragione per trattenerla, ma non poteva essere dimessa in quelle condizioni, cosí le trovarono un posto letto a Villa Arby, una clinica dove avrebbero saputo prendersi cura di lei fino a che la situazione non si fosse ristabilita. Una delle bugie che mi avrebbero accompagnato durante quei mesi: che tutto si sarebbe risolto.
Era la prima volta che la vedevo in ospedale. Nei miei ricordi ero sempre io il paziente, e trovai violento il cambio di prospettiva.
Avevo sentito di queste storie in ufficio. Ascoltavo con distacco i resoconti di quelle malattie senili mentre le mie colleghe, al telefono con le proprie madri, ricordavano loro di prendere le medicine. Quelle madri bambine restavano in ascolto delle direttive che le loro figlie madri impartivano. In quel corridoio che puzzava di sciroppo per la tosse, mi chiedevo come avessi potuto pensare che a me non sarebbe successo. E al tempo stesso mi sembrava incredibile.
Erano le sette del mattino quando arrivai alla clinica. Il tulle ormai si era sporcato, in alcuni punti il bordo era nero e lei si era addormentata come una vera sposa sfinita dalla festa. Mio padre le aveva tolto le scarpe e ora le teneva in mano.
Considerato che non si erano mai sposati, il viaggio fino all’ospedale, con lei stesa sul sedile posteriore vestita da cerimonia, fu il loro viaggio di nozze.
– Negli ultimi tempi è successo qualcosa che ha turbato sua madre? Riesce a individuare una causa scatenante? – chiese il medico.
– No, – risposi.
– Prende medicinali?
– Quelli per la pressione.
– Da quanto tempo è in questo stato?
– Non lo so di preciso.
– Quindi non ha mai cominciato nessuna cura?
– Non sapevamo fosse malata.
Era la prima riunione di famiglia da anni. Se solo tutto questo fosse successo di giorno, e mio padre l’avesse accompagnata in ospedale con il camice della macelleria sporco di sangue, allora sí che il colpo d’occhio sulla Sacra famiglia sarebbe stato perfetto: una sposa, un macellaio e un figlio fallito.
– Faremo tutto il possibile, – disse il medico compilando il documento per il ricovero. Non c’era una data presunta di dimissione.
Le assegnarono un letto nella stanza alla fine del corridoio assieme a un’altra donna. Le pareti erano dipinte di giallo come lo sarebbero state quelle di una prima elementare.
Le spiegazioni del medico mi sollevavano da ogni responsabilità diretta e indiretta. Le depressioni che aveva avuto da giovane nascondevano qualcosa di complesso che solo ora stava venendo fuori nel suo splendore piú nero. Non eravamo stati né io né mio padre a ridurla cosí, ci stava dicendo questo. O era quello che io volevo capire.
– Sono lente degenerazioni del sistema nervoso che impiegano decenni prima di manifestarsi.
Ripensai alla nostra cucina con i mobili marroni, all’infinità di mozziconi che le avevo visto spegnere nei piatti con gli avanzi di cibo. Si era preoccupata tutta la vita per me e io non mi ero accorto di niente. Aveva ragione quando mi chiamava il Grande Egoista.
– Ora dovete andare, – disse l’infermiera, – ci pensiamo noi. Piano piano le cose prenderanno il loro ritmo.
Mi sembrò la frase piú spaventosa che si potesse pronunciare in quel momento.
Sistemammo le pantofole e la vestaglia nell’armadietto, e mostrammo a mia madre dove fossero le sue cose senza essere sicuri che stesse comprendendo. Le scarpe andarono nella parte bassa sotto la mensola, il dentifricio in quella centrale. Sopra, un sacchetto di plastica con la carta d’identità.
Intanto lei si era stesa sul letto. Nell’attimo in cui, con gli occhi chiusi, si voltò nella nostra direzione, guardai i lineamenti del suo viso che erano sempre bellissimi. Ma ci diede subito la schiena e si rimise a dormire.
Ci fu il periodo in cui vedevamo decine di pediatri. Al Policlinico dicevano che ero un bambino immunodepresso e dalla scarsa vitalità. Un colpo per la segretaria. Memorizzavo quelle parole e le scrivevo nei temi. Ogni medico che incontravamo, ogni suora con la quale parlavamo, non faceva che confermare i miei limiti.
Da parte mia sognavo una malattia letteraria come la tisi o la peste. Un morbo romantico, una finestra con le tende accostate. Invece avevo l’anemia e perdevo sangue dal naso. Mi succedeva quando ero in classe. Sentivo gli occhi che mi tremavano nelle orbite, le bambine gridavano e si allontanavano.
Quando accadeva dovevo stringere sull’osso, tenere la testa all’ingiú e aspettare che il sangue riprendesse la densità necessaria. Ero stato istruito con delle esercitazioni nel bagno, e giravo sempre con l’ovatta nello zaino.
– Hai preso i cerotti?
– Sí.
– Una Tachipirina se ti sale la febbre?
– Presa.
– Il numero della croce rossa te lo ricordi?
Il mio zaino era una cassetta dei medicinali.
La mia compagna di classe Teresa Iannone, che tentavo invano di sedurre, scoprendo il mio armamentario farmaceutico, lo raccontò a suor Monica, confermando il mio ruolo di bambino strano della classe.
Quando mi ammalavo la segretaria mi lasciava dormire nel suo letto, e io volevo che non avesse altri pensieri all’infuori di me. Instauravo una dittatura tra le lenzuola bianche e dure che venivano lavate una volta al mese. Ero felice di essere in punto di morte perché lei sapesse del mio terribile dolore di vivere. Se solo avessi trovato la maniera di morire veramente per dieci minuti e poi ritornare.
Immaginavo il momento nel quale la segretaria si avvicina per misurarmi la febbre, mi chiama, mi scuote e infine mi scopre senza vita. Lascio il mio corpo immunodepresso per raggiungere in paradiso il posto che merito. E quando la segretaria mi stringe forte chiedendomi scusa per non avermi dato tutto l’amore che poteva, la mia ani...