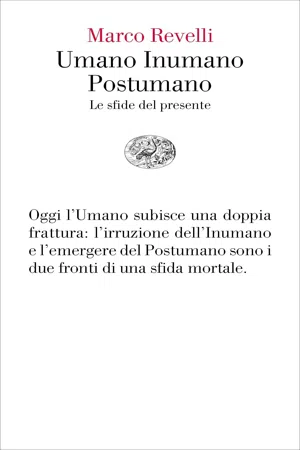Due secoli e mezzo, o poco di piú, è durato quell’Ordine nuovo dei moderni garantito dal confinamento verticale del disumano per permettere all’umano di dispiegarsi nell’orizzontalità della vita quotidiana sotto l’ombrello della Spada e della Legge. Una lunga parentesi, nel corso della quale, certo, quel concetto di Sovranità – nella sua forma piú pura o grezza, assolutizzante, del Leviatano hobbesiano – non durò, come tale, piú di tanto, subendo i successivi assalti della stessa moderna autocoscienza, nel passaggio dalla Monarchia assoluta a quella costituzionale e poi parlamentare o dello Stato liberale rappresentativo. Ma in cui la sostanza di quel «paradigma» sopravvisse, quantomeno nella forma di «sovranità popolare». Poi, il vaso di Pandora è tornato a scoperchiarsi. E lo spettacolo dell’inumano diffuso, pervasivo e interstiziale, dipinto nelle tavole di Bosch, è tornato a occupare la scena del mondo. Potremmo dire che il Ballestero è ritornato. O, meglio, che è ritornato il suo sguardo, posato sui propri contemporanei come su un ammasso di cose, a certificare la «morte del prossimo».
È esattamente questa espressione – La morte del prossimo è appunto il titolo del suo libro – che uno psicanalista nostro contemporaneo, dalla sensibilità e dall’inquietudine quasi altrettanto profonde di quelle di Hieronymus, Luigi Zoja, ha evocato, per sintetizzare lo stato mentale presente, una volta compiuto il passo successivo alla nietzscheana «morte di dio», ricollegandolo, come già si è visto a proposito della rappresentazione crudele di Bosch, allo sguardo e agli «occhi degli altri»:
Dopo la morte di Dio, la morte del prossimo è la scomparsa della seconda relazione fondamentale dell’uomo. L’uomo cade in una fondamentale solitudine. È un orfano senza precedenti nella storia. Lo è in senso verticale – è morto il suo Genitore Celeste – ma anche in senso orizzontale: è morto chi gli sta vicino. È orfano dovunque volti lo sguardo. Circolarmente, questa è la conseguenza ma anche la causa del rifiutare gli occhi degli altri: in ogni società guardare i morti causa turbamento1.
Zoja certificava questa morte osservando il proprio mondo contemporaneo – il nostro mondo attuale, noi post-uomini oltre-novecenteschi –, ma in realtà, come sappiamo, il prossimo aveva incominciato a morire assai prima, pochi, pochissimi anni dopo la proclamazione filosofica della morte di Dio, nel secondo decennio del Novecento, con la strage industrializzata della Grande Guerra, e ancora, un quarto di secolo piú tardi, con l’apertura dei cancelli di Auschwitz, fabbrica meccanizzata della morte di massa, dove mai come prima gli uomini furono «lavorati» come cose. E dove con il medesimo sguardo inerte dei derisori di Cristo si praticò l’«odio secco» – l’«odio senza soggetto» o senza la coscienza di questo – predicato da Hitler quando urlava che «dobbiamo essere crudeli, dobbiamo esserlo con la coscienza pulita, dobbiamo distruggere in maniera tecnico-scientifica»2, come negli inceneritori si smaltiscono «scientificamente» i rifiuti, o negli altoforni si fondono i rottami.
Fu nelle «battaglie di materiali» della Grande Guerra che, come per un ritorno ciclico di un demone ctonio, l’inumano tornò a installarsi nel cuore del tempo, come una sorta di suo mostruoso «spirito», e a dilagare senza freni spirituali. Gli uomini che hanno attraversato l’orrore dei campi di battaglia «lavorati» dalla cordite e dai gas o della trincea («un moloch incandescente che ha via via ridotto la gioventú dei popoli a una scoria», cosí la descrive Ernst Jünger nell’atroce saggio sulla Battaglia come esperienza interiore)3, quegli uomini «forgiati, bulinati» dalla guerra come vera seconda Madre (è ancora Jünger) non hanno piú nulla di umano. Nell’aspetto, nell’antropologia fisica: sotto l’elmetto d’acciaio i tratti si sono tirati, fatti taglienti, «incavati e tesi», il volto «è divenuto metallico, quasi galvanizzato in superficie»4 (come un prodotto di fornace), lo sguardo stesso ha subito la medesima metamorfosi, sguardo «fisso, addestrato a osservare oggetti che devono essere percepiti in condizioni di massima velocità»5. Mutati «fuori», ma mutati anche «dentro» – un’altra antropologia sociale, generatasi nel profondo di quell’inneres erlebnis, di quell’interiore «esperienza vissuta» –, nella commistione del vivo e del morto e nel rapporto con l’«altro» che sta a fianco di te, come corpo vivo o come cadavere, indifferentemente, come «cose» entrambi, gettate tra le scorie di quel «grande laminatoio» che è il fronte:
La carne di alcuni cadaveri diventava verdastra, come quella dei pesci, e risplendeva di notte tra le divise lacere. Se calpestata, gli scarponi lasciavano orme fosforescenti. Altri essiccavano, come mummie calcificate che si spelavano lentamente. Ad altri ancora la carne si staccava dalle ossa come gelatina rossa… Non eravamo forse tutti, vivi e morti, ricoperti di uno spesso tappeto di mosche nere e bluastre?6.
È a questo punto che – nella descrizione gelida dell’orrore senza veli – Jünger inserisce due versi di Baudelaire: «E ditemi se resta ancora qualche tortura | per questo vecchio corpo senz’anima, morto fra i morti»7, che suona a epitaffio generazionale di chi ha visto, dal suo epicentro, compiersi una mutazione epocale nell’emergere di una nuova – e sospesa – waste land: «L’orbe terrestre è coperto dalle macerie di immagini in frantumi. Noi assistiamo a un declino paragonabile soltanto alle catastrofi geologiche»8, annoterà Jünger una decina di anni dopo, in un nuovo visionario libro, L’Operaio.
Auschwitz riprodurrà, nel microcosmo concentrato – e concentrazionario – scientificamente costruito nel cerchio interno dell’altra immane catastrofe umanitaria che fu la Seconda guerra mondiale, come suo estremo punto di caduta, l’orrore massificato dei corpi lavorati come cose in un’immensa fabbrica della morte. Carnefici e vittime morti entrambi – morte nei corpi ischeletriti le seconde, morti nelle anime disseccate i primi – e intorno le cataste di cadaveri anonimi e irrigiditi, come a Verdun o nella Somme, il fumo denso dei crematori, lo Zyklon B irrorato dalle docce, nei magazzini le montagne di capelli, di protesi ortopediche, di occhiali, mentre nelle case degli aguzzini si leggeva Goethe o Hölderlin alla luce di abat-jours di pelle conciata dei deportati tatuati. Annota Primo Levi alla data del 26 gennaio (1945), il giorno prima che i russi arrivassero a liberare il campo:
Noi giacevamo in un mondo di morti e di larve. L’ultima traccia di civiltà era sparita intorno a noi e dentro di noi. L’opera di bestializzazione, intrapresa dai tedeschi trionfanti, era stata portata a compimento dai tedeschi disfatti». E aggiunge: «È uomo chi uccide, è uomo chi fa o subisce ingiustizia; non è uomo chi, perso ogni ritegno, divide il letto con un cadavere. Chi ha atteso che il suo vicino finisse di morire per togliergli un quarto di pane, è, pur senza sua colpa, piú lontano dal modello dell’uomo pensante, che il piú rozzo pigmeo e il sadico piú atroce. Parte del nostro esistere ha sede nelle anime di chi ci accosta: ecco perché è non-umana l’esperienza di chi ha vissuto giorni in cui l’uomo è stato una cosa agli occhi dell’uomo9.
In mezzo, nel tempo sospeso tra quei due estremi infernali – un ventennio o poco piú di supposta «normalità» – si è consumata, con baricentro la Germania, quella che Ernst Bloch ha chiamato «la metamorfosi in demoni» di gente normale (di «gente proletarizzata» scrisse in realtà testualmente)10, documentandone per cosí dire «in tempo reale» la regressione a un’immagine insieme «ridicola e terrificante», in un libro – Eredità del nostro tempo – che è a tutti gli effetti il diario minuzioso di una discesa agli inferi, verso una terra desolata in cui «non è solo l’uomo mite che scompare, scompare tutto quello che reca il nome di uomo»11. Vi è descritta, giorno per giorno, in una sorta di ibrida fenomenologia della vita quotidiana, la progressiva desertificazione del paesaggio interiore, l’abbattimento inarrestabile degli strati di civilizzazione sedimentati nei secoli fino a raggiungere l’osso di un’elementarità crudele, da branco predatore nel momento in cui un popolo intero – o quantomeno la sua parte mediana – «si getta sempre piú nelle braccia della barbarie» e «lo sguardo diventa caparbio, il volto paonazzo, ebete, accanito. Un che di conosciuto, ma irriconoscibile»12, che procede minaccioso su un piano inclinato che rimescola e confonde tempi e luoghi, attraversando tutto il multiversum sconvolto che tiene dentro la nervosità elettrica della metropoli (dove galleggiano scombussolati gli Impiegati di Kracauer) e lo scorrimento lento, lentissimo, dei borghi rurali con le loro «viuzze medievali, il ballo di San Vito, i pogrom contro gli ebrei, l’avvelenamento dei pozzi e la peste, visi e gesti simili a quelli della derisione di Cristo e di altre tavole gotiche»13…
Una moltitudine d’inciviliti uomini del XX secolo impegnati, ognuno per sé e tutti insieme, a coltivare la propria Grausamkeit, ovvero la propria «Crudeltà» (anzi «das gute Gewissen zur Grausamkeit», «la buona coscienza sulla crudeltà», secondo le parole del loro Führer). E a sradicare da sé, spontaneamente, con lo zelo di chi ama la «cose fatte bene», ogni residua traccia di «tenerezza» (Weichmütigkeit) bollata da Hitler come espressione di «filisteismo», di Gemütligkeit (che letteralmente significa «indole buona» ma che potremmo anche tradurre come «buonismo»), e di «nauseante crepuscolarità» (Dämmerschoppenseligkeit)14.
La si vide, dunque, la si toccò e la si patí come una nuova peste nera, quella morte del prossimo. Ma si pensò che quello fosse un unicum, un terribile incidente della Storia: una sorta di caso d’eccezione, irripetibile nella sua abissale inumanità. Invece, fatte le debite proporzioni, in una dimensione in qualche misura «attenuata» del morbo, ce la ritroviamo di fronte – e dentro – quella indifferenziazione tra persone e cose che si fa indifferenza per l’altro – ogni altro – e costituisce la curvatura interiore della morte del prossimo, oggi, peste silenziosa, senza piú nemmeno il frastuono del delirio ideologico, al polo opposto dell’eccezione, come normalità. Stato normale dell’essere.
Zoja ci dice appunto che «col volgere del secolo XX in secolo XXI» si è superata ancora la seconda soglia dopo quella della morte di Dio, si è consumata una rinnovata morte del prossimo: l’«uomo metropolitano» – non l’uomo accecato da ideologie perverse, non l’uomo travolto da una qualche utopia negativa, ma l’uomo «normale» che abita lo spazio centrale dell’universo contemporaneo, quello in cui risiede egemone lo spirito del mondo – «si sente sempre piú circondato da estranei»15. Non porge piú lo sguardo all’altro – non lo «guarda» come fosse un uomo – e non è «visto» (come tale) dall’altro. È l’uomo che ha smarrito anche l’ultimo briciolo di empatia. Che ha ri-fatto dell’egoismo da vizio che era una virtú teologale.
Difficile dire dove e quando abbia avuto inizio quella lunga marcia dell’estraneità egoistica ed egocentrica verso la sua attuale egemonia (intesa, per citare Luciano Gallino, come «potere esercitato con il consenso di coloro che vi sono sottoposti»)16. Forse già nel 1947 – subito dopo la fine della prima ondata di «peste nera» –, come scrive lo stesso Gallino17, sulle pendici di «una montagnola svizzera», il Mont Pèlerin, dove un gruppetto di economisti allora relativamente controcorrente (Friedrich von Hayek, Milton Friedman, Maurice Allais…) aveva fondato la Mont Pelerin Society (Mps), un think tank votato all’affermazione di u...