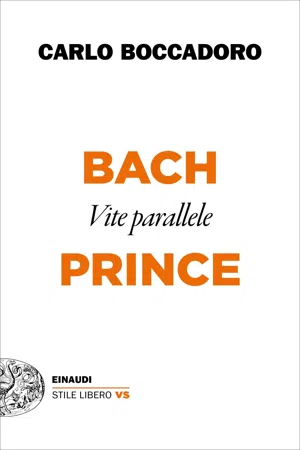La musica di Johann Sebastian Bach è da molto tempo considerata una delle piú universali tra quelle prodotte dalla civiltà occidentale. Il suo linguaggio parla a popoli dalle culture piú diverse, anche opposte tra di loro, ed egli è tra i pochissimi musicisti in grado di commuovere e interessare milioni di persone che normalmente non ascoltano musica classica.
Le sue partiture sembrano comunicare all’istante con ogni tipo di persona, indipendentemente dallo strato sociale, non hanno alcun bisogno di particolari spiegazioni tecniche o estetiche; dall’Europa all’Africa, dalla Cina agli Stati Uniti, il messaggio spirituale e umanistico di Bach attraversa popoli e continenti senza barriere apparenti.
Eppure questo compositore cosí amato in ogni parte del globo non uscí mai dai confini della Germania in cui era nato (a differenza del suo quasi altrettanto celebre collega Händel, che viaggiò moltissimo riscuotendo grandi successi anche in Italia e Inghilterra), e anche all’interno della Germania stessa Bach si mosse poco, stabilendo la quasi totalità della sua vita lavorativa principalmente in tre città: Weimar, Köthen e Lipsia.
Il contrasto tra l’ampiezza di raggio raggiunta dalle note e la dimensione ben piú ridotta dei luoghi dove queste furono composte colpisce immediatamente, cosí come il fatto che opere dal significato poetico cosí alto siano state scritte in realtà per motivi il piú delle volte pratici, anche se oggi le ascoltiamo in sala da concerto: pensiamo al Clavicembalo ben temperato, uno dei monumenti dell’arte musicale, nato per semplice uso didattico (sul frontespizio si legge: «Ad uso della gioventú studiosa e musicale ed ancora a ricreazione di coloro che sono già versati alla musica») oppure all’immenso corpus delle Cantate, che Bach si era impegnato a scrivere ogni settimana per la congregazione dei fedeli a Lipsia in modo da poter essere eseguite in chiesa durante la messa.
All’epoca probabilmente nessuno pensava che questa musica sarebbe sopravvissuta all’uso particolare che ne veniva fatto e forse lo stesso Bach sarebbe stupito di vedere oggi rappresentati lavori come l’Oratorio di Natale e La passione secondo Matteo in forma di esecuzione puramente concertistica, separati dalle ricorrenze sacre del calendario che ne avevano causato la nascita.
Era musica nata per le esigenze quotidiane: una determinata chiesa aveva bisogno di una Messa per il proprio coro, gli allievi di clavicembalo e organo avevano bisogno di esercizi per potersi esercitare, il conte Keyserling soffriva di insonnia e aveva bisogno di una musica che lo aiutasse a passare le lunghe ore di noia (cosí sono nate le celeberrime Variazioni Goldberg per clavicembalo, che presero il nome dal primo esecutore del ciclo); non si pensava certo a sontuose esecuzioni in sale stracolme di pubblico, queste opere sono state ascoltate per la prima volta da un numero assai limitato di persone, nel caso delle Goldberg un ascoltatore solo (teniamo conto che all’epoca di Bach Lipsia non contava piú di tredicimila abitanti in tutto).
Il musicista Andrew Parrott, nel suo libro The Essential Bach Choir, ha avanzato una tesi assai discussa secondo cui gli ampi passaggi corali della musica di Bach, oggi generalmente eseguiti da decine di voci, fossero in realtà stati pensati a parti reali utilizzando solo quattro o cinque cantanti in una dimensione del fare musica decisamente piú intima e, diciamo cosí, «casalinga».
Anche il modus operandi di Bach era improntato a un artigianato che nasceva in famiglia, dato che molti dei suoi figli e la moglie Anna Magdalena lo assistevano durante il lungo e noioso lavoro di copiatura e preparazione delle partiture. Inoltre un flusso ininterrotto di amici musicisti si recava a casa Bach per provare i nuovi pezzi o semplicemente per suonare in compagnia. Tutto era su scala ridotta, la dimensione artistica e quella domestica si sovrapponevano, lo sguardo non si rivolgeva tanto all’infinito quanto probabilmente alla sala da musica adiacente allo studio in cui Bach componeva, spesso di notte.
Il muoversi all’interno di una piccola comunità i cui interessi musical-spirituali venivano soddisfatti con operosità non difforme da quella di chi preparava il pane tutti i giorni o di chi risuolava gli stivali, il rapporto familiare tra creatore e fruitore, tutto questo formava un ecosistema propulsore per la creazione di un’opera colossale la cui profondità di significato è apparentemente inesauribile, in cui ancor oggi ogni generazione riscopre e ritrova nuovi valori e punti di riferimento, un nucleo di opere inossidabile nonostante il continuo alternarsi dei punti di vista, delle mode culturali, dello scorrere del tempo.
Un autentico paradosso, cosí come lo è il fatto che in vita Bach fosse piú conosciuto e rispettato come collaudatore e accordatore d’organi che come compositore: eppure la sua mente creativa traeva nutrimento da questa dimensione di provincia, lontana da città piú grandi e affollate ma probabilmente piú dispersive. Siamo apparentemente lontanissimi anche da qualsiasi ambizione di successo professionale che non fosse limitato alla carica di Kantor o di organista di corte. La diffusione della propria musica presso altri paesi non sembra interessare minimamente Bach; se paragoniamo questo atteggiamento con il cosmopolitismo e i successi finanziari di Vivaldi e Händel (entrambi scaltri impresari oltreché compositori) nel mondo operistico, questa volontà di non attraversare la soglia del proprio paese o poco piú ci appare quasi miope: eppure né Vivaldi né Händel, pur con grandi successi al proprio arco, arriveranno a un grado assoluto di popolarità presso gli ascoltatori come invece ha fatto Bach.
Minneapolis è una citta che conta circa 452 000 abitanti: per gli standard americani si tratta di dimensioni medio/piccole, ben diverse dai tre milioni che abitano a Chicago o dai quattro milioni di abitanti di Los Angeles, per non parlare degli oltre otto milioni che vivono a New York. Un posto tranquillo, lontano dai riflettori dello show business e dei red carpet che precedono l’assegnazione di premi e dischi di platino.
Attorno a Minneapolis ci sono una serie di comuni molto piú piccoli, spesso con poche decine di migliaia di abitanti, dove i clamori della popolarità e l’eco dei commenti sulla stampa risultano ancora piú lontani e attutiti; uno di questi paesini si chiama Chanhassen, ed è qui che sorgono i Paisley Park Studios, un enorme complesso di palazzi (oltre 5000 metri quadri) che costituivano l’abitazione e la sede lavorativa di Prince. Dopo la sua scomparsa questo luogo è diventato un museo che accoglie migliaia di visitatori di tutto il mondo che pagando biglietti dal prezzo alquanto salato possono vedere gli studi di registrazione, il gigantesco palco dove Prince teneva concerti organizzati a sorpresa spesso in piena notte, l’archivio, osservare i costumi di scena, ascoltare frammenti inediti di registrazioni audio e video, fare acquisti di Cd, magliette e memorabilia varie. Le prenotazioni per visitare il sancta santorum dell’artista si snodano lungo parecchi mesi, e sono quasi sempre esaurite in ogni ordine di posti. Dentro Paisley Park c’è anche una sala cinematografica attrezzata con le tecnologie piú avanzate: inizialmente pensata per il solo uso privato di Prince e della sua corte di amici ora vi si organizzano rassegne a tema di film sulla musica afroamericana, da Wattstax ad Amazing Grace. Tutta quest’attività culturale internazionale si svolge non in una grande metropoli ma in un luogo che in Italia corrisponde, come densità abitativa, a Fucecchio (provincia di Firenze).
Nel 1998 Prince acquistò un’enorme villa in Spagna a El Paraíso, vicino a Marbella, per festeggiare il suo matrimonio con Mayte García: trascorreva diversi mesi all’anno in questo luogo e indubbiamente le idee per molte canzoni devono essere nate qui, ma la scrittura effettiva dei brani è stata sempre realizzata negli Stati Uniti.
Nel 2005 decise di vivere una parte dell’anno a Los Angeles, in un altro mega complesso industriale simile a quello in Minnesota. Il suo centro di attività creativa però è sempre rimasto Chanhassen, non solo per la registrazione di dischi ma anche per le attività dal vivo: le prove delle tournée si svolgevano dentro gli studi e venivano occasionalmente organizzati concerti destinati ai fan: nel 2000, 2001 e 2002 le Celebrations at Paisley Park regalarono musica ed eventi ininterrotti per una settimana intera.
Nonostante queste eccezioni la fama di Paisley Park è rimasta sempre quella di una fortezza inaccessibile al pubblico e destinata a pochissimi visitatori, perlomeno fino a quando Prince è rimasto in vita.
In una intervista al canale televisivo Mtv del 1985 ha detto: «Non mi considero una superstar. Vivo in un paesino, e ci vivrò per sempre. Posso passeggiare in giro ed essere me stesso».
Nel 1996, intervistato da Oprah Winfrey, ribadí il concetto: «Vivrò per sempre a Minneapolis: fa talmente freddo da tenere lontane le persone cattive».
Il rapporto tra causa ed effetto, tra micro e macro, tra intimità della concezione creativa e vastità d’influenza della stessa trova nelle figure di Bach e Prince una delle realizzazioni piú compiute: in fin dei conti anche la Liverpool da cui sono arrivati i Beatles non è certo una metropoli come Roma o Parigi, ma con i suoi oltre 572 000 abitanti ci appare vasta come Calcutta rispetto alle strade di Chanhassen e Köthen.
Se il rifiuto di vivere esclusivamente nei grandi centri urbani sembra essere una prima caratteristica comune tra i due musicisti, un altro filo rosso può essere tracciato osservando la loro abitudine di circondarsi unicamente di una cerchia molto ristretta di amici e collaboratori fedeli, rendendosi in qualche modo impermeabili alle influenze provenienti dall’esterno.
Prince cominciò a costruire i propri studi nel 1985 (furono ultimati tre anni dopo) utilizzando la fortuna economica guadagnata grazie al successo planetario dell’album (nonché omonimo film) Purple Rain, che stazionò in cima a tutte le classifiche mondiali per mesi vendendo oltre venti milioni di copie: ma questo album, come i precedenti, era stato realizzato in condizioni molto differenti.
Prince aveva iniziato le registrazioni per il primo album, For You, a Minneapolis, ma l’etichetta Warner Bros. (con cui aveva firmato un contratto per molti dischi) decise che essendo un debuttante di soli 19 anni egli non avesse abbastanza esperienza e gli affiancò il produttore Tommy Vicari, che volle proseguire la lavorazione del disco in California, a Sausalito.
Prince non visse questo sradicamento con facilità e decise di portare avanti il disco interamente da solo suonando tutti gli strumenti e realizzando oltre 46 parti vocali indipendenti.
Ci furono fortissime frizioni tra Vicari e Prince proprio per la tendenza di quest’ultimo a non accettare alcun suggerimento esterno sia durante la fase di registrazione che in quella di mixaggio: per lui era impossibile sviluppare le proprie idee con l’aiuto di qualcun altro.
Cosí quando pochi mesi dopo l’uscita di For You Prince incominciò a lavorare a gran velocità al secondo album si fece trovare dalla casa discografica uno studio a Burbank in California, ma subito dopo affittò un appartamento in una microscopica frazione di Minneapolis chiamata Wayzata, situata sulle rive del lago Minnetonka: rientrato nella quieta anonimità della provincia a lui cosí familiare chiese al tecnico Don Batts di costruirgli uno studio di registrazione casalingo dove poter realizzare da solo i demo tapes per il terzo disco, Dirty Mind (tranne due brevi interventi di Matt «Doctor» Fink al sintetizzatore e uno di Lisa Coleman ai cori).
Dopo aver riascoltato il materiale Prince decise che quelli non erano solo dei provini e dopo un’ulteriore session di mixaggio con Mick Guzauski e Bob Mockler volle pubblicarli cosí com’erano: sinceri, onesti, anche se con delle imperfezioni tecniche.
«Mi sono detto: se potessi mettere la mia circolazione sanguigna sul vinile, sarebbe proprio come questo disco», dichiarerà nel 1986 alla rivista «Ebony».
Da questo momento il metodo di lavoro di Prince sarà lo stesso per molti anni: esercitare un assoluto controllo creativo su ogni aspetto della propria musica e circondarsi di pochissime persone fidate che collaboreranno con lui senza alcuna interferenza esterna (Prince non permetteva neppure alla casa discografica che finanziava i suoi dischi di ascoltare qualcosa prima che il master finale fosse consegnato).
Tra il 1981 e il 1987 Prince ha alternato il lavoro tra la sua casa di Minneapolis e quello che considerava il suo studio preferito oltre il proprio, i Sunset Sound Studios di Los Angeles, ma anche quando si trovava fuori casa la chiusura totale in cui viveva e lavorava gli permetteva di ricreare lo stesso microclima di intimità creativa che aveva in Minnesota e gli era indispensabile per creare la propria musica.
In tutto questo periodo si è affidato quasi esclusivamente a soli due tecnici del suono, Peggy McCreary e Susan Rogers, con cui ha realizzato tutti i suoi dischi da solista e molti progetti diversi (spesso sotto pseudonimo).
Entrambe hanno ricordato come Prince in studio fosse completamente isolato rispetto al mondo esterno e potesse lavorare anche venti ore di seguito senza mangiare e dormire: era in grado di scrivere, arrangiare, suonare, cantare e mixare un brano completo in una giornata di lavoro.
Peggy McCreary in un’intervista del 2019 ricordava che «Prince andava avanti per decine di ore unicamente bevendo ettolitri di caffè e sgranocchiando caramelle alla menta per la gola: mi diceva che se faceva pausa era unicamente per permettere a me di avere qualche ora di sonno»; nella stessa intervista ricorda come una volta Prince la chiamò in piena notte per farle registrare un brano che aveva appena sognato.
La dedizione richiesta a chi lavorava per lui doveva essere totale, ventiquattro ore al giorno; talvolta i suoi tecnici si trovavano a doverlo aspettare per sette o otto ore in studio dopo essere stati convocati: lui poteva arrivare a proprio capriccio, ma loro dovevano essere assolutamente puntuali.
Sul lavoro non dava alcuna confidenza, senza nemmeno salutare quando arrivava o andava via, limitandosi a poche parole e diventando subito impaziente se qualche incidente tecnico rallentava il ritmo continuo di produzione musicale.
Le persone a cui concedeva raramente qualche intervento strumentale o vocale erano tutti suoi amici di vecchissima data; alcuni come il bassista André Cymone, il batterista Bobby «Z.» Rivkin e il cantante Morris Day lo conoscevano sin dall’infanzia.
Diffidente nei confronti di chiunque non facesse parte di questo cerchio magico (e minuscolo), usava l’amicizia di pochissimi come una corazza protettiva per difendersi dal mondo che stava fuori dalle porte dello studio e sino alla fine della sua vita manterrà questa abitudine di segretezza, anche quando formerà gruppi di musicisti piú numerosi (ad esempio i Revolution) per andare in tour.
Ugualmente reclusa e limitata a una cerchia di pochi amici era la vita lavorativa di Bach: abbiamo visto come i familiari lo aiutassero nella copiatura delle proprie ope...