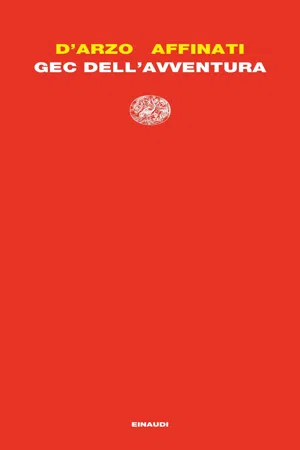Ragazzi, me ne duole. Ma dovrò cominciare con un morto.
Quel giorno, infatti – undici Aprile, credo, del 1727 – nella piú ridente, raccolta ed isolata città della Contea di Fillingtáun, nonostante l’odore delle viole, i peschi appena in fiore in mezzo agli orti, e nonostante fosse, d’altra parte, il piú roseo e amichevole dei Sabati, non si scorgeva un bimbo per le strade. E neanche nel bosco: neanche al mare. Nessun loro grido o richiamo era per l’aria. Eppure c’era il sole: era vacanza.
Tanto che, se non fossero rimasti, bene in vista sugli usci e le pareti, certi strani disegni incomprensibili e certe lunghe parole o intere frasi, cosí signorilmente superiori a ogni norma meschina di grammatica, con tutta facilità si sarebbe caduti nel sospetto di trovarsi a un paese senza bimbi. Il che – né intendo con questo scoprir nulla – di tutte le possibili malinconie di questa terra è certo la piú malinconica e impossibile.
Il vecchio Bidello Gau, a un certo punto della sua canzone, che cantò poi presso il Ponte la Domenica – e con discreto successo anche, mi dissero – assicura di aver visto quel giorno per le strade, tutte bianche di sole e verdi d’erba, quello che nessun uomo ha visto mai: cioè passeggiare lente, petulanti e indolenti le lucertole; a questo – il fatto è chiaro – incoraggiate dall’assoluta mancanza di ragazzi. Ora, con tutta devozione e rispetto al vecchio Gau, la cosa può anche essere o non essere: e forse, da quel poeta che in fondo in fondo egli è, avrebbe potuto vederle, prima o poi, anche in un giorno qualsiasi, mi sembra; e il fatto, insomma, non comprova niente.
Fatto sta, invece, che, quella giornata, nessun ragazzo era fuori, al bosco o al mare: e, se si esclude, abbiam detto, quei disegni e le scritte in carbone sopra i muri, niente ne ricordava la presenza.
Chiusi in casa, colla testa china su un libro o sulla tavola (per non fare vedere che piangevano), coi capelli arruffati come mai e le braccia pendenti dalla seggiola, tutti, tutti i ragazzi di Pictáun ricordavano il Buon Maestro morto. Dopo aver insegnato per venti, per trent’anni (e chi poteva negare, d’altra parte, senza tema nessuna di smentita, che fossero cinquanta e, forse, cento?), egli aveva lasciato sulla cattedra, proprio accanto al vaso di fiori cui i ragazzi rinnovavano l’acqua ogni mattina, una sua breve lettera d’addio. Ma senz’affatto parere, il bello è questo: come l’avesse, e sí, dimenticata: lui, che in vent’anni, in trent’anni e piú d’insegnamento, non s’era mai dimenticato di una penna. Ringraziava i suoi ragazzi sorridendo (ma questo, realmente, i bimbi non capirono): si scusava con loro d’ogni cosa (e questo i bimbi capirono ancor meno) e se ne andava, da solo, il giorno stesso, alla Vecchia Collina di Pictáun, dove i fiori gialli fioriscono al cancello. — Morto, allora? —, si chiesero alla fine, con sgomento stupore, tutti i bimbi. — Morto sí. Anche lui morto, — ammise Gau davanti al cancelletto della Scuola e guardava ogni cosa attorno a sé, che non fosse però gli occhi dei bimbi.
E tutti allora corsero alle case. Presero un libro, un foglio, qualchecosa, tanto per potere chinare un po’ la testa e nascondersi gli occhi con il gomito, senza farsi vedere da nessuno, e si misero a piangere in silenzio. Qualcheduno non ci credeva ancora. Qualche altro – fino a questo può giungere un gran bene – giunse quasi a rimproverare il Buon Maestro che non “doveva” morire in nessun modo, quasi a uno scherzo di cattivo genere: che non doveva farlo no e poi no e che – fatta la debita eccezione del penultimo banco, in fondo a destra, per via forse di quella sospensione – non se lo meritavano davvero. Infine Tom, figlio del Cancelliere, le cui fibbie dorate agli scarpini eran perfino piú belle e piú lucenti di quelle del Reverendo Signor Hum (né si creda che fosse cosa facile), e che era abituato a comandare ad un Gran Maggiordomo e a sei lacchè, fu visto buttare a terra di colpo il suo quaderno, pestare i piedi con rabbia sul tappeto e, fra lo stupore della servitú che l’osservava senza dir parola e aveva intanto tralasciato ogni lavoro, disse tre, quattro volte nei singhiozzi: — Non “voglio”, no, non “voglio” che sia morto.
E che domenica triste, l’indomani.
Fortuna che (come accade, del resto, in ogni cosa) quello che, secondo le loro tristi previsioni, avrebbe dovuto essere il momento di maggior struggimento e nostalgia, cioè il ritorno nella Vecchia Scuola, cosí piena di parlanti memorie e di ricordi ma deserta di lui, del Buon Maestro, si mutò invece, e inaspettatamente, in un’ora curiosa e fin piacevole. Perché, preso che ebbero posto nei loro banchi, tirati fuori i quaderni e aperti i libri, e proprio nel preciso momento che Tukéis stava per alzare gli occhi sulla cattedra (nessuno – debbo dirlo francamente? – ne aveva avuto il coraggio fino allora) e vedervi i “suoi” fiori agonizzanti, fece allora il suo ingresso nella Scuola la persona piú strana, singolare, piú inarrivabile e varia della terra.
Quella persona che, pur senza presentare sulle prime alcun particolare rilevante sia nel corpo e nel viso che nell’abito, e a prima vista del tutto trascurabile, non tarda però a fare certi gesti, a dire certe parole, a fare certi occhi, da svelare in capo a un’ora al massimo la sua completa, precisa identità. Ad ogni modo vi sarà sufficiente un breve tratto, anche per non finire col guastarvi, con indicazioni maggiori, il giusto orgoglio di fare da voi stessi, la scoperta.
Entra improvvisamente in mezzo all’aula, e poi si mette a sfogliare due o tre libri: poi li mette da parte, li riprende: li sfoglia senza guardare un’altra volta; li allontana, infine, deciso con il gomito: allora alza due occhi, a poco a poco, freddamente feroci su di voi e, con voce in realtà quasi terribile (quando basterebbe soltanto essere gentili) vi chiede, a uno per uno, il vostro nome; e ad ogni nome abbassa un po’ la testa, come si fa per le vecchie conoscenze, con nomi che ricordano qualcosa, e li va ripetendo a bassa voce. Sí che voi vi sentite un po’ orgogliosi, vi freme il naso di compiacimento. «Forse ha conosciuto mio padre alla Contea», vi viene fatto spontaneo di pensare. «O al Consiglio, o alla Parrocchia di Pictáun...» Poi, dopo avere sentito tutti i nomi e aver detto qualcosa ad ogni nome, indica Ból col braccio, in fondo a destra, e lo chiama, poniamo, Vernon Gun: il ragazzo non s’alza: guarda e tace: (che altro dovrebbe fare, ottimo Dio?) e quello lo va allora chiamando Vib, Tukéis, e poi Wilfrid, poi Sandis, tutti i nomi, e magari Tukéis un’altra volta. Finché il bimbo, tremando, s’alza e dice, come a chiedere scusa d’uno scherzo:
— Il mio nome, signore, è Narvik Ból. Forse l’ho detto a bassa voce, prima, e non era facile capirlo. Ma il mio nome, signore, è Narvik Ból.
E quello sorridendo finalmente: — Ma già, sicuro: Narvik Ból. Che testa! L’avevo qui fra la lingua e i primi denti —. Ma, dopo appena mezz’ora, fa lo stesso: e, in piú, diventa rosso come un fiore. Nessuno ha capito ancora?
Ma il “Supplente”!
Ora, dopo avere chiesto il nome a tutti, e avere anche coscienziosamente approvato ad ogni nome, sí da dare ai ragazzi l’impressione che aver proprio quel nome e non un altro fosse una gran fortuna veramente, un caso proprio felice e forse un merito, quale fu il suo dolore e disappunto quando s’accorse che non un’intera mattina era passata, e meno che mai un giorno completo od un trimestre: ma appena una mezz’ora, e poi nemmeno. Che, in parole piú povere e concrete, doveva dire ancora “qualchecosa”.
Ma che cosa, che cosa, santo Dio? (Perché, in fondo, – e a che scopo poi nascondervelo? – il dramma del Supplente, il primo giorno di scuola, è proprio questo: che egli sa troppe cose e forse tutte, ma non sa quando dirle, e ne ha paura. Il fatto di conoscere ogni cosa, come le date con le cifre dispari, che è poi la cosa piú difficile del mondo, di fronte all’ignoranza dei bambini gli dà un senso di timidezza e di vergogna. E guai a guardargli le scarpe in quel momento!) Fortuna che, guardando innanzi a sé, su carte appese al muro, bimbi e banchi, gli accadde allora di fare la piú dolce scoperta immaginabile: che tutti, tutti i bimbi hanno una madre, e inoltre un padre: e ogni padre, il suo mestiere. Bastava, appunto, chieder loro questo e acconsentire, a ogni nome, una, due volte, perché la mattinata, ecco, passasse.
E indicò allora – non piú rosso, rosa – il ragazzo piú piccolo di tutti: il primo banco a sinistra, verso il muro.
— Tu, Tedder Gec, che cosa fa tuo padre?
— A me, signore? — chiese Gec alzandosi: e, avutone un benevolo cenno di consenso, cominciò a dire, come una poesia:
— Il Corazziere, signore, il Corazziere. Morto un giorno a cavallo per il Re.
— Come come? — chiese allora in un soffio il buon Supplente nel timore di non aver capito, e s’alzò un po’ – pare almeno – sulla seggiola. Un Corazziere? A quei tempi un Corazziere? Eppure gli avevano assicurato il giorno stesso, al Superiore Consiglio di Pictáun, che si trattava di ragazzi volenterosi e serii al massimo: e, la piú parte, ottimi addirittura.
— Ma quando, questo? — chiese tuttavia, benché la sua meraviglia fosse al colmo.
— Ah, non so. Non so. Con precisione non saprei, signore, — rispose Gec, con tutta serenità e con grande calma. — Ma credo, – cosí all’incirca, credo naturale – che debba trattarsi di tredici anni fa.
— Millesettecentoquattordici, vuoi dire, — incalzò allora il Supplente occhiferoce, alzandosi anche un po’ piú (pare almeno) dalla seggiola.
— Forse sí. Millesettecentoquattordici, mi pare. Anzi, è cosí senz’altro, ora che penso. E “lui” guidava i cavalli del Gran Re, proprio dietro il Primo Stendardo di Contea. 217 cavalli, mi ricordo. E i nemici, i Baroni di Turgau...
— Ah! Vergogna, Tedder Gec Vecchio buffone, — esplose allora il Supplente ricadendo di nuovo sulla seggiola, mentre Gec gli teneva fissi gli occhi sulle scarpe, con estremo stupore e gran paura. Che cosa aveva detto, dopotutto? Lui, sí, Gec, francamente non capiva.
— Lo ripeto due volte: sí, vergogna… Mio padre Corazziere… bene bene. Lo Stendardo e i Baroni e il Grande Re. E che cos’altro, avanti? Menti ancora. Io sono qui che t’ascolto. Avanti, su —. E poi, in tono addirittura gelido: — Intanto, nel 1714… quattordici… non c’era piú nessun re… Nes-sun re, dico. (E questo accadde, e ve lo spiego subito, perché, in seguito agli attacchi continui dei Baroni, in causa appunto dei Dazi Doganali, dei soprusi infamanti e dei...)
— Vent’anni fa, allora, signore, — disse Gec, con un bisbiglio che si sentí appena. Il suo cuore tremava e palpitava come a un uccello appena catturato, ma nessuno – e, se occorre, ho i testimoni –, nessuno riuscí a cogliere la minima incertezza nella voce. — Che combattesse a fianco del Re, signor Supplente e che avesse anche un cavallo tutto bianco... che il suo cavallo si chiamasse Iol e che lui... sí, Mio Padre Corazziere...
— E continua; continua, Tedder Gec, — interruppe di nuovo il Supplente con voce vagamente minacciosa. — Complimenti di cuore, signor Gec —. (Poi, evidentemente prostrato dallo sforzo del felice sarcasmo, tornò agli altri: — Tra le altre cose, e ve lo spiego subito, neanche “allora”, capite?, c’era il Re. Egli fu cacciato… destituito, vi dirò… meglio ancora, costretto ad abdicare...)
— Cent’anni, allora… — e Gec chinò la testa, mentre, per la prima volta in vita sua, egli vide, capí e sentí il silenzio.
L’altro si lasciò cadere le braccia lungo i fianchi. «Dio mio, che pazzo! E dove m’han mandato!», andava mormorando dentro sé.
Ma cosí calmo, cosí tranquillamente sereno, gli appariva ora innanzi Tedder Gec e – sia pure preso da un sottile brivido – cosí onestamente sicuro di sé e della sua storia, che il Supplente, fra lo stupito, l’incerto, l’indignato, prima di consegnarlo al Vecchio Gau e di farlo uscire dall’aula, a casa sua, ebbe, per la seconda volta nel mattino, un’idea luminosa veramente. Prese il registro; l’aprí; si mise a scorrerlo. Del resto, senza un registro sotto gli occhi, con nome, paternità, cognome e tutto, che cos’è mai un supplente appena giunto, se non meno ancora che un orfano o una vedova? E già è giunto alla C, già legge «Delton», già sa chi è il vecchio padre di Frantau… «Oh, Tedder, finalmente. Gec di...», quando, in quel momento preciso al Vecchio Gau, che, da un lato della classe, stava appendendo una carta alla parete colla sua eterna canna di bambú, la carta scivolò, s’afflosciò, cadde di colpo, come una vela fiaccata, sopra i banchi.
E il Supplente lasciò il registro e tutto, e corse ad aiutare il Vecchio Gau: il che, del resto, era anche suo dovere.
(Benché qualcuno, Gunter per esempio, abbia trovato o detto di trovare – padronissimo di credergli, chi vuole – che quando, proprio, il Supplente era giunto, leggendo, a Tedder Gec, il volto del Vecchio Gau si andò facendo cosí penoso e triste all’improvviso come le statue con due teste e barbe, poste sui muri delle case d’angolo (cioè, come di piú non si può essere): e che – sempre secondo lui, questo s’intende – la carta era già a posto, sul suo chiodo; e Gau già ritirava la sua canna: quando, all’improvviso, di colpo – lí è lo strano – egli l’alzò di nuovo, e neanche poco, e sollevò la corda della carta tanto che non poggiasse piú sul chiodo, poi riabbassò la canna d’un sol colpo e la carta... la carta venne giú. Ma forse non aveva visto bene.)
Ora, poi, messa a posto la carta sul suo chiodo; presi su nuovamente libri, e penne, scivolati qua e là, di sotto i banchi; ritornato il silenzio nella classe, il Supplente stava per aprire di nuovo il suo registro, quando alzò il capo di colpo, verso fuori, storse, con certa dignità e con grazia, il collo, tese, infine, le orecchie alle finestre. E come lui, dopo un po’, tutta la classe.
Dal di fuori, dal verde, dal cancello, dai giardini vicini propriamente, proveniva un rumore, invero, strano: e in nessuna maniera definibile. Poi il rumore aumentò sopra la ghiaia, s’avvicinò alle siepi, al cancelletto – si sentí aprire, Dio mio, il cancello stesso – e poi giú pel vialetto, sulle aiuole: lo si udí, già distinto, sui gradini: «viene qua, viene qua», non c’è dubbio: l’uscio sta per aprirsi, è aperto già… e, corrente, rotolante, scivolante, fra le due file di banchi della classe, si vide entrare la signora Gec.
«Dio del Cielo», pensò il Supplente allora e diventò color di viola mammola. «Povero me, che cosa ho fatto mai! Eppure, il Superiore Consiglio aveva detto... Mi era stato esplicitamente assicurato...» Ma già la signora Gec, chiedendo affannosamente scusa e scusa, lo aveva preso senz’altro per la mano, se lo trascinava in disparte, verso un angolo, lo fermava di fianco alla lavagna (dove i bimbi si mettono in castigo), e sempre chiedeva ancora scusa e scusa.
Si vide allora una ben strana cosa.
Che la Signora Gec, ora pigliando le mani del Supplente nelle sue e tenendovele come in prigionia, ora indugiando due dita dentro un’asola, non fa che dire e dire e dir parole: ma il Supplente la guarda e dice no, proprio al modo di chi non vuol capire: poi la signora dice altre parole, e il Supplente la guarda ancora un po’, ma senza dire niente, questa volta, come chi, in fondo, cerca di capire: e infine, infine la signora Gec gli si accosta di piú, gli si fa all’orecchio, gli dice altre parole a bassa voce, con un’aria piuttosto malinconica, e gli lascia infine anche libere le mani, e lui, senza guardarla, dice sí, fa di sí colla testa due o tre volte come chi ha capito ogni cosa o forse piú.
Poi lei, quasi correndo, esce di nuovo. (Questo, però, al Supplente riuscí oscuro.)
Ora, quando la porta a vetri si rinchiuse dietro il velo della signora Gec, e la scuola divenne ancora scuola, egli si volse di nuovo verso Gec continuando con tutta calma il vecchio dialogo, come se niente fosse piú avvenuto, o fosse, quella, un’interrogazione, ammettiamo di Storia o Geografia.
— Sicché tuo padre ha guidato i cavalli del Gran Re, dietro il Primo Stendardo di Contea? Nella prima battaglia, hai detto, no?
— Nella prima? In tutte e ...