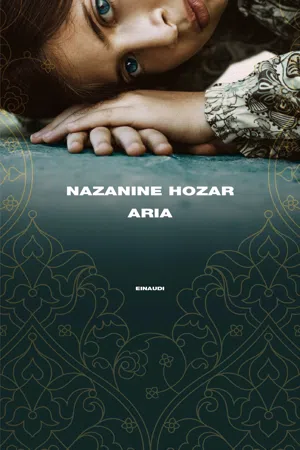Il trisnonno di Fereshteh era figlio di un mercante d’argento. Aveva viaggiato in lungo e in largo e, fra gli altri tesori, aveva portato in Persia, da Versailles, un corsetto di pizzo di seta appartenuto a Maria Antonietta con il ricamo dello stemma reale, prima che il popolo francese decapitasse sia lei che il re. Tale souvenir lo rese famoso. Quando Agha Mohammad Khan Qajar, lo scià castrato dell’Iran, decise di fare di Teheran la capitale del Paese e di costruirvi le proprie dimore, chiese al trisnonno di Fereshteh di entrare al suo servizio come argentiere di palazzo. Fu cosí che i Ferdowsi diventarono quello che erano. – Non ho mai permesso ad alcuno zoroastriano di varcare i miei cancelli, – gli disse lo scià. – Tu fai eccezione.
I Ferdowsi non erano stati sempre noti con questo nome. Un tempo erano semplicemente il figlio del figlio del figlio dell’argentiere e, come tutti, in Persia, non avevano un cognome. Fu il padre di Fereshteh a scegliere Ferdowsi, non in onore del poeta ma della piazza in cui vivevano. – Questo è il vostro nome di famiglia, gli inglesi lo chiamano «last name», ultimo nome, – gli aveva detto l’impiegato dell’anagrafe, prima di vergarlo su un librone di mille pagine. Sua moglie, Arnavaz, era incinta di Fereshteh. – Ultimo nome? – aveva esclamato lei. – È come dire che la famiglia non potrà averne altri. È un segno di sventura.
– Credo che lo chiamino anche «surname», sarebbe il nome piú importante, – aveva risposto il padre di Fereshteh. – È il modo in cui gli inglesi cercano di tenere in ordine le cose. Cosí quando il bambino nascerà tutti sapranno che mi appartiene –. E indicò il ventre di Arnavaz.
– E io, Hormoz? Il bambino non è forse mio?
– Eh, come è ingiusto il mondo con le donne, – aveva detto il neo nominato Hormoz Ferdowsi, toccando il ventre della moglie. – Se solo potessi renderlo un luogo migliore per te, mio povero agnellino.
Hormoz era ancora ragazzo quando aveva cominciato il suo lavoro di argentiere al servizio di Nasir al-Din Shah. Il suo bisnonno aveva fornito tutto l’argento che si trovava nel Palazzo del Golestan, e suo nonno e suo padre lo avevano conservato, lucidato e cesellato, impreziosendolo di rubini e giade. Attraversando le sale del palazzo, Hormoz aveva promesso allo scià che anche il suo lavoro sarebbe stato grandioso, almeno quanto quello dei parenti che lo avevano preceduto. – Persino gli zar di Russia ne saranno invidiosi, vostra Maestà, – aveva detto.
Poi, però, quando aveva visitato Teheran, lo zar non era rimasto affatto impressionato. – Nonostante i re governino da voi da un tempo piú lungo che nella maggior parte degli altri Paesi, ancora non sapete essere veramente regali, – aveva dichiarato in tono scherzoso lo zar allo scià. Udito questo, Hormoz era stato malato per trenta giorni. Aveva perso circa venti chili, e per un po’ aveva dimenticato persino il proprio nome. Si era rifiutato di giocare con Fereshteh, la figlia appena nata, e una volta, in preda a un mancamento per un attacco di vertigini, l’aveva fatta volare fuori dalla carrozzina senza volere. Nel momento peggiore della crisi, bevve alcol per ventiquattr’ore di fila, e il medico gli disse che il suo fegato stava cedendo. Comunque Hormoz si riprese. Ricominciò a lavorare l’argento. Ma in lui c’era qualcosa di diverso. – I tuoi occhi hanno cambiato colore, marito, – gli disse un giorno Arnavaz. – Vedo delle striature cerulee nel marrone.
– Ho deluso lo scià, – rispose Hormoz.
Negli anni successivi, i Ferdowsi ebbero altri tre figli, un maschio, una femmina e da ultimo ancora un maschio. I cortigiani del palazzo reale dissero ad Arnavaz che sarebbe stato meglio se i bambini fossero nati seguendo un altro ordine: maschio, femmina, maschio, femmina. Ma Hormoz Ferdowsi era veramente felice. – Sono un uomo moderno, – disse. – Sarei pronto a baciare la mano alla regina d’Inghilterra. Sarei pronto a farmi nominare cavaliere. Non c’è da vergognarsi ad avere come primogenito una figlia. Se allo zar capitano quattro femmine prima di un maschio, non può capitare anche a me?
Hormoz prese a farsi accompagnare da Fereshteh quando andava al palazzo di Golestan. Le mostrava il retaggio della famiglia. – Un giorno, quando sarai grande, angelo mio, cesellerai l’argento fra queste mura. Costruirai nuovi palazzi per nuovi re, e cesellerai l’argento lí dentro. Farai brillare Teheran, e i tuoi figli faranno lo stesso –. Sollevava la piccola Fereshteh per farle vedere il soffitto, che era coperto di lamine d’argento e tempestato di diamanti. – Lassú sembra pieno di stelle, papà, – diceva lei, tendendo le braccia verso lo scintillio.
– Sí, – diceva Hormoz. – L’uomo può fabbricare le stelle, se vuole. E un giorno lo zar vedrà le mie stelle. Un giorno ammirerà quello che tu stai ammirando ora.
Fereshteh aveva sette anni quando Hormoz partí alla volta della Russia per capire come mai allo zar non fossero piaciute le sue stelle. Quel giorno giocò con lei e con Jafar, il secondogenito, lanciando loro una palla, mentre i due figli piú piccoli osservavano la scena dalle carrozzine. Diede a ciascun bambino un bacio sulla guancia. Regalò delle bambole di legno alle bambine, e dei cavalli di legno ai bambini. Sarebbe dovuto stare via un mese, ma non tornò piú.
Il mese trascorse senza che arrivassero notizie di Hormoz e Arnavaz, quando comprese che il marito non sarebbe mai tornato, si chiuse in camera sua e lí rimase per tredici settimane di fila. La balia allattava i bebè, e Fereshteh guardava le cameriere correre avanti e indietro dalla camera di sua madre. Per settimane non la vide piú, poi un giorno, dallo spiraglio della porta, intravide una domestica che la imboccava con un cucchiaio. Arnavaz, un tempo una parsi di carnagione scura, con la mascella pronunciata e il viso allungato degli zoroastriani, adesso era pallida, sembrava paralizzata, e il cibo le colava dalla bocca. Alla fine la donna recuperò almeno in parte la salute, ma non proferí piú verbo.
I russi cercarono il padre di Fereshteh per tre mesi, poi abbandonarono le ricerche. Due anni dopo a casa Ferdowsi arrivò una lettera.
Gentile signora Ferdowsi,
in qualità di segretario del Partito bolscevico di Leningrado mi è stato affidato il compito d’informarla che la Repubblica Sovietica non può impegnarsi ulteriormente nella ricerca delle spoglie di un artigiano imperiale. Suo marito fu visto per l’ultima volta nel Palazzo d’Inverno.
Saluti.
Fu dopo l’arrivo di questa lettera che Hormoz Ferdowsi divenne una leggenda nel quartiere. Al termine del primo giorno di scuola, due anni dopo la scomparsa del padre, Fereshteh corse in cucina dove le domestiche stavano preparando la cena e dichiarò: – Mio padre diventerà il nuovo re di Russia.
– Ce l’hanno già un re… un re che stanno cercando di uccidere, – rispose la balia, staccandosi dal seno il bambino piú piccolo e porgendolo ad Arnavaz, che sorrise e annuí. Poi piegò le mani a formare due cilindri e se le mise davanti agli occhi, a mo’ di binocolo. – Tua madre dice che tuo padre è una spia, – spiegò una delle cameriere. Tutte e tre le domestiche avevano imparato a decifrare il nuovo linguaggio di Arnavaz, la quale era convinta che Hormoz fosse stato inviato dallo scià a spiare i comunisti russi, poiché temeva che progettassero di calare a sud sulla Persia. Arnavaz chiuse la mano a pugno e la batté sul tavolo. – Tuo padre tornerà, – disse la cameriera, interpretando quel gesto. Poi Arnavaz si picchiò la fronte e fece l’atto di tagliarsi la gola. – Tuo padre tornerà quando il bolscevico morirà, – disse la cameriera.
Ma il bolscevico, Lenin, non morí, o almeno non di lí a poco. E Arnavaz continuò a soffrire e a trascurare i propri figli. Poi, un giorno, quando Fereshteh aveva ormai dodici anni, Arnavaz riempí una valigia. Senza un saluto s’incamminò nel cuore della notte verso Darband, lungo la strada tortuosa che affondava nelle pieghe del gran Damavand. In qualche punto, al di là del monte, trovò un pastore di capre che la guidò fino alla frontiera russa e l’aiutò ad attraversarla, facendola entrare nei ricordi di Fereshteh.
Adesso che entrambi i genitori erano scomparsi, i fratelli Ferdowsi dovevano cavarsela da soli. Un cortigiano del Palazzo ebbe un’idea. La loro proprietà andava trasformata in una tenuta residenziale. I contadini che venivano per lavorare nei giardini o per costruire nuove camere avrebbero avuto in cambio un posto dove vivere. Nel giro di un anno si approntò il progetto e Fereshteh, essendo la piú grande, venne nominata direttrice.
Nell’agosto del 1921, si aprirono le porte della Tenuta Ferdowsi. Non venne nessuno.
– È gente umile, signorina Ferdowsi, – disse il maestro di palazzo. – Il popolo ha idee molto tradizionali. Crede che voi zoroastriani facciate delle magie e adoriate il fuoco perché lo adora il diavolo. Crede che lanciate incantesimi.
Fereshteh lí per lí non aveva neanche capito cosa intendesse quell’uomo. Lei voleva solo giocare a travestirsi con sua sorella Mahnaz. Pochi giorni dopo davanti alla loro porta vennero lasciati degli agnelli morti, a mo’ di sacrificio. Dall’altro lato della strada un vecchio contadino gridò: – Che il Profeta vi salvi, o che salvi noi tutti dalla vostra malvagità! – Fereshteh osservò il sangue che sgorgava dalla gola di un agnello e che scorreva giú per la strada, fino a piazza Ferdowsi. Due giorni dopo, il sacrificio venne ripetuto. La tenuta Ferdowsi si tinse di rosso.
Una volta i quattro bambini tornarono a casa da scuola e trovarono le parole «Casa di peccatori» scarabocchiate sull’ingresso principale. Mirza, il fratello piú piccolo, aveva imparato a leggere da poco. Ci prese gusto a sillabare la scritta piú e piú volte e per tutto il giorno continuò a ripetere: «Casa di peccatori, casa di peccatori».
Andò a finire che i fratelli Ferdowsi decisero di convertirsi. Nello scegliere i loro nuovi nomi musulmani, le ragazze si misero a bisticciare. – Io mi voglio chiamare Fatemeh, – esclamò Mahnaz. Ma Fereshteh, essendo la primogenita, ritenne piú giusto prendere per se stessa il nome della figlia del Profeta. – Tu sarai Khadija, – disse alla sorella. – La moglie del Profeta, quella che aveva nove anni.
I ragazzi non litigarono. Fereshteh diede al maggiore il nome di Jafar, e il piú piccolo diventò Mohammad. Nessuno di loro aveva in mente di farsi chiamare con il nuovo nome musulmano ma a Mirza piaceva cosí tanto il suo che chiese agli altri di chiamarlo cosí. Mohammad era molto meglio di Mirza, che gli ricordava il nome di una pietanza.
– Khadija è troppo difficile, – protestò Mahnaz. – I nomi arabi sono troppo strani.
– Allora ti chiameremo Moluk, che è sempre un nome arabo ma piú semplice, – le disse Fereshteh.
Presto Mohammad diventò Mammad, perché le veniva piú facile. E dopo un po’ anche Jafar adottò stabilmente quel suo nome arabo, perché col passare del tempo aveva dimenticato quello farsi e non rispondeva se qualcuno lo chiamava Jahangir. Finí che tutti e tre si abituarono ai loro nuovi nomi. Solo Fereshteh conservò il vecchio. Loro l’avevano sempre chiamata cosí.
Il primo contadino che arrivò alla porta della tenuta Ferdowsi fu una ragazzina dal viso dolce che rispondeva al nome di Massumeh. Suo padre la baciò sulle guance, poi si girò verso Fereshteh e le domandò se poteva venire a farle visita una volta al mese.
Fereshteh sorrise. – Certo. Può venire quando vuole.
– Si chiama Massumeh. È una brava cuoca, mia madre le ha insegnato a cucinare. ...