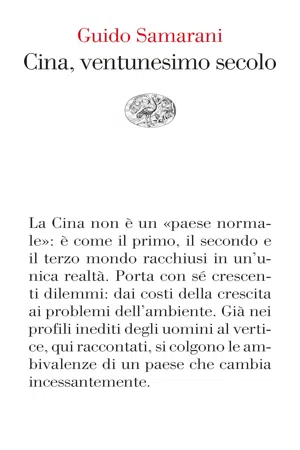Premessa.
Il primo decennio del nuovo (ventunesimo) secolo è stato segnato, in modo simile ma anche assai diverso dai tanti che lo hanno preceduto nella storia dell’umanità, da grandi e piccoli fatti ed eventi e ha portato all’affermarsi e all’emergere di nuovi grandi personalità cosí come all’eclissi o alla scomparsa, storica o naturale, di molti altri personaggi. È stato tra l’altro il decennio del drammatico e devastante attacco terroristico alle Torri Gemelle, dell’estensione del conflitto in Afghanistan e dell’avvio della Guerra in Iraq, del terribile tsunami del 2004 nell’Oceano Indiano, considerato uno dei piú catastrofici disastri naturali dell’epoca moderna; ed anche il periodo che ha visto il crollo della borsa americana e la profonda e grave finanziaria globale i cui effetti ancora si fanno sentire in questo 2010 e le tragiche e strazianti immagini che ci sono giunte da Haiti e che ci giungono periodicamente da varie parti del mondo, segno di grandi problemi irrisolti e di uno squilibrio oggettivo nel rapporto tra uomo e risorse, tra uomo e natura. Allo stesso tempo, è stato il decennio dell’inizio della circolazione dell’Euro nel 2002 e dell’elezione di Barack Obama, primo Presidente afroamericano degli Stati Uniti; e anche il periodo che ha visto conquiste e progressi straordinari e fondamentali nel campo della scienza e della tecnologia, tra cui la decifrazione completa del nostro patrimonio genetico, con evidenti riflessi sulle possibili applicazioni pratiche di tali novità (salute, ambiente, agricoltura, ecc.).
Anche per la Cina si è trattato di un decennio «speciale». Da una parte, Pechino ha dovuto far fronte alle violente proteste in Tibet e Xinjiang, al terremoto in Sichuan nel 2008, allo scandalo dell’avvelenamento del latte in polvere, al rinnovarsi dei casi di repressione spesso dura del «dissenso» e sul fronte dei «diritti umani» (l’ultimo caso tra fine 2009 e inizi 2010 è stato quello della condanna di Liu Xiaobo, uno dei fondatori di Charta 08), e ha dovuto fronteggiare altresí gli effetti derivanti dall’11 settembre. Dall’altra, il nuovo decennio si è aperto con lo storico accesso alla World trade organization/Organizzazione mondiale del commercio (Wto/Omc), l’economia ha dimostrato ulteriormente la propria grande vitalità nonostante le difficoltà e i problemi – anche seri – sorti con la crisi finanziaria globale, le Olimpiadi hanno evidenziato ancor piú il senso di profondo orgoglio nazionale e le grandi ambizioni dell’ascesa internazionale della Cina, anche al di là delle forti contestazioni e critiche che hanno accompagnato la marcia della fiamma olimpica; inoltre, Hu Jintao ha finalmente potuto incontrare Barack Obama (a Londra nel 2009), l’Expo di Shanghai – come ricorda periodicamente l’«Expo Magazine» – e la sua mascotte Haibao, simbolo della cultura cinese, attendono fiduciosi i 70 milioni di visitatori previsti, il programma spaziale cinese ha conosciuto straordinari progressi.
Successi e insuccessi, progressi e difficoltà caratterizzano dunque il percorso della Cina in questo decennio, secondo un andamento che a volte sembra seguire le previsioni e altre volte appare inaspettato.
Non sempre è facile muoversi tra previsioni ottimistiche e critiche pessimistiche: bilanciare le une e le altre cercando di offrire uno sguardo il piú possibile esauriente, pur nei vincoli imposti dalla necessità di sintesi, è il tentativo che muove le pagine che seguono.
L’attacco alle Torri Gemelle e l’ingresso della Cina nel Wto.
I primi passi del nuovo millennio sono stati per la Cina assai controversi.
Al di là dell’ovvia e pronta solidarietà a Washington, infatti, l’11 settembre del 2001 ha prodotto effetti rilevanti sulla visione cinese del terrorismo globale e, di riflesso, sull’approccio ai problemi legati alla sicurezza nazionale e piú specificamente alla gestione del conflitto in Xinjiang. Nei giorni immediatamente successivi all’attacco, Pechino si è innanzitutto impegnata a negare qualsiasi ipotesi, avanzata da fonti occidentali, di un qualche legame con i Talebani o addirittura, come suggerito dal «Guardian», che Bin Laden avesse trovato rifugio in Cina. Il 12 settembre il «Quotidiano del popolo», nel tratteggiare una ricostruzione storica della escalation terroristica degli ultimi anni, riconosceva la gravità degli attacchi di cui gli Stati Uniti erano stati oggetto sottolineando tuttavia, non senza una venatura critica, come le armi piú sofisticate (e tra queste il cosiddetto «scudo spaziale») apparissero inadeguate a far fronte a quello che veniva definito come il «nemico pubblico della comunità internazionale». Il 19 settembre, il vice Capo della missione diplomatica cinese a Washington, nel riaffermare la volontà del proprio paese di cooperare con gli Stati Uniti nella lotta contro il terrorismo, metteva tuttavia in guardia dall’adozione di una strategia anti-terrorismo che non fosse basata su prove solide ed inequivocabili.
Esattamente tre mesi dopo, l’11 dicembre, la Repubblica popolare cinese (Rpc) completava il suo lungo e tormentato cammino verso l’adesione al Wto.
Si è trattato di un percorso assai piú difficile e contorto di quanto Pechino probabilmente si era immaginata: un percorso iniziato negli anni Ottanta quando ancora esisteva il Gatt (General agreement on trade and tariffs), progenitore del Wto, e reso complicato nel corso degli anni dall’impatto internazionale della repressione della «primavera del 1989», dalla crisi e dissoluzione dell’Unione Sovietica e di gran parte del sistema socialista nel mondo, dall’emergere della Cina come un crescente competitore globale, soprattutto nel campo dell’export. Come i fatti avrebbero dimostrato, effetti benefici e ricadute negative si sarebbero intrecciati negli anni a venire per quanto riguarda lo sviluppo economico cinese e le sue relazioni commerciali con il mondo.
Già gli osservatori piú avveduti, tuttavia, alla vigilia dell’adesione avevano messo in rilievo (vedi ad esempio Naughton e Fewsmith) le enormi opportunità ma anche le scivolose asperità che il processo di inserimento e di adattamento avrebbero comportato per Pechino, con ricadute differenziate sui vari settori produttivi e finanziari ma con un consistente prevedibile impatto altresí sull’assetto giuridico e socioeconomico nazionale.
È in questo contesto che nella primavera del 2001 l’Assemblea nazionale popolare (Anp) ha dato il via al nuovo (il decimo, 2001-2005) Programma quinquennale di sviluppo economico e sociale, le cui linee strategiche erano state definite nell’ottobre del 2001 dal Quinto plenum del Comitato centrale (Cc) del Partito comunista cinese (Pcc). Il Piano – come messo in evidenza dalle relazioni politiche e tecniche che lo accompagnano – poteva contare sui solidi risultati acquisiti nel quinquennio precedente e apre un periodo («i prossimi cinque o dieci anni» come recitava il comunicato ufficiale) considerato cruciale e fondamentale per il futuro della Cina. Tra gli obiettivi essenziali, venivano messi in rilievo «il consolidamento e il rafforzamento dell’agricoltura in quanto base economica nazionale», l’accelerazione dello sviluppo della parte occidentale del paese, la crescita degli investimenti nel settore della ricerca scientifico-tecnologica e nel campo dell’educazione, la necessità inderogabile di intervenire sulle gravi carenze nel campo del welfare e di edificare una società socialista non solo materialmente ma anche «spiritualmente avanzata».
Un partito «avanzato»: il discorso di Jiang Zemin.
Il 1° luglio 2001, ottantesimo anniversario della fondazione del Pcc, l’allora Segretario generale, Jiang Zemin, pronunciava un importante discorso nel quale, dopo aver ricostruito le tappe storiche principali del partito e della rivoluzione cinese, enfatizzava l’esigenza che, oltre a operai, contadini e intellettuali, definiti «la spina dorsale del partito», venissero ora accettati anche elementi provenienti da altri settori sociali «che abbiano sottoscritto lo Statuto e il Programma del partito, abbiano operato in modo coscienzioso per la linea e il programma del partito, e abbiano provato attraverso una lunga serie di verifiche di soddisfare le esigenze del partito».
Si trattava del battesimo ufficiale della cosiddetta «teoria delle tre rappresentatività», anche se ad essa Jiang aveva fatto riferimento già prima. Con essa, il Pcc si ergeva a rappresentante delle «esigenze di sviluppo delle forze produttive piú avanzate, degli orientamenti della cultura piú avanzata e degli interessi fondamentali della larga maggioranza della popolazione».
I «padri» originari di tale teoria erano probabilmente Liu Ji, teorico di Shanghai che Jiang Zemin aveva portato con sé dalla metropoli a Pechino, e Wang Huning, politologo presso la prestigiosa Università Fudan di Shanghai, anch’egli cooptato da Jiang in seno al gruppo di «think tank» del partito.
Di fatto, era il primo passo per l’apertura del partito agli imprenditori e ai nuovi gruppi sociali emersi ed affermatisi nel corso del periodo delle riforme e delle «modernizzazioni» (a partire dalla fine degli anni Settanta), tanto che la stampa cinese segnalava già in luglio che i manager piú qualificati di imprese private avrebbero potuto competere per ricoprire alcune decine di posti in seno a vari dipartimenti governativi. In agosto, una serie di note ufficiali precisava che l’ammissione di nuove figure di rilievo avrebbe arricchito il partito stesso e che, peraltro, molte di queste nuove figure «provenivano da famiglie di operai, contadini, impiegati, ecc.».
Era evidente che il cuore politico della scelta compiuta riguardava il primo punto (rappresentanza delle forze produttive piú avanzate) e che, come avrebbero poi confermato varie fonti in special modo di Hong Kong, la scelta compiuta di ammettere coloro che pochi decenni prima venivano stigmatizzati come «borghesi» e «capitalisti» non era stata indolore, provocando proteste e resistenze in seno al Pcc.
In particolare, certi avevano messo in guardia dal pericolo di riconoscere di fatto la legittimità dello sfruttamento capitalistico, anteprima della rinuncia all’obiettivo finale del comunismo e simbolo evidente del ripudio concreto della natura di classe del partito stesso.
In realtà, come evidenziato tra gli altri da Bruce Dickson, il reclutamento di imprenditori nel Pcc era già stato avviato anni prima: si trattava dunque di un imprimatur ufficiale, che doveva dare il via – almeno in teoria – ad una nuova e piú intensa fase. Come sottolinea ancora Dickson, di fatto si può affermare che solo con il 2005 si sia verificata una svolta effettiva nel trend di reclutamento di questi nuovi gruppi sociali.
Il discorso di Jiang Zemin si intrecciava peraltro con le decisioni assunte nel settembre dello stesso anno dal Cc del Pcc nel corso del suo Sesto plenum.
In quella occasione era stato infatti approvato un importante documento («Decisione del Cc del Pcc sul rafforzamento e il miglioramento nella costruzione dello stile del partito»), che mirava a rendere piú efficace e incisivo lo stile di lavoro dei membri del Pcc in una fase in cui considerevoli apparivano le «tentazioni materiali» insite nello sviluppo dell’economia socialista di mercato. Il documento indicava tra i fenomeni negativi emersi e da combattere con risolutezza: mancanza di disciplina, crescita della burocratizzazione, preparazione di rapporti contenenti dati esagerati o addirittura falsi, diffondersi di fenomeni di arroganza da potere e di lassismo anche personale.
Peraltro, le stesse statistiche fornite nel periodo (primo semestre del 2001) dagli organi preposti alla lotta contro la corruzione e la malversazione tendevano a confortare le preoccupazioni politiche: piú di 25 mila crimini di carattere economico commessi da funzionari statali, con il coinvolgimento di molte migliaia di membri del Pcc. E le pagine dei giornali ufficiali ancora trasudavano rabbia e indignazione per il colossale imbroglio (evasione di dazi doganali) da poco scoperto nell’area di Xiamen, dove una vera e propria gang aveva potuto per 3 anni portare avanti i propri affari illeciti grazie ad una vasta azione di corruzione verso membri del partito e del governo nonché verso il personale giudiziario preposto ai controlli.
Il ricambio al vertice: l’ascesa della «quarta generazione».
I comunisti cinesi hanno in genere dato un’interpretazione sostanzialmente «continuista» alla loro storia e a quella della rivoluzione in generale a partire dagli anni Quaranta, in cui venne imponendosi la leadership di Mao Zedong e, con essa, una rilettura storico-politica del proprio passato sapientemente modellata attorno al leader. Non sono comunque mancati in questi decenni elementi di discontinuità, in particolare dopo la morte di Mao e l’ascesa di Deng Xiaoping nella seconda metà degli anni Settanta, come evidenzia il documento ufficiale del 1981 nel quale venivano inserite evidenti critiche all’operato di Mao alla fine degli anni Cinquanta e negli anni Sessanta. Tuttavia, il documento del 1981 forniva un’analisi conclusiva largamente orientata alla continuità piuttosto che alla rottura rispetto al passato (il periodo maoista), proponendo nell’insieme – sotto la regia politica di Deng Xiaoping, che pure aveva dato vita ad un programma strategico per varie parti antitetico a quello di Mao – un giudizio di ampia convergenza sull’operato politico del Grande Timoniere dai primi anni Venti (fondazione del Pcc) alla morte (1976).
Negli ultimi anni in particolare l’elemento della continuità è stato riproposto ed aggiornato attraverso il discorso sulle «generazioni». Cosí, Mao avrebbe guidato la «prima generazione» di comunisti e rivoluzionari, Deng Xiaoping la «seconda», Jiang Zemin la «terza» sino ai primissimi anni del nuovo secolo.
In effetti, tra il 2002 e il 2003 il Partito comunista cinese ha avviato un profondo ricambio dei vertici nazionali e regionali, dando il via alla ascesa della «quarta generazione», imperniata sul trio (in ordine gerarchico): Hu Jintao (segretario del partito) – Wu Bangguo (Presidente del Comitato permanente dell’Assemblea nazionale popolare) – Wen Jiabao (primo ministro), che guida ad oggi (primavera 2010) il paese.
Il ricambio ha avuto due momenti centrali: il primo, nel novembre del 2002, con lo svolgimento del sedicesimo Congresso nazionale del Pcc e il conseguente rinnovamento degli organismi dirigenti; il secondo, nel marzo del 2003, con la sessione di apertura della nuova (la decima) Assemblea nazionale popolare, chiamata a sancire i nuovi vertici istituzionali (Presidente della Repubblica, lo stesso Hu Jintao), di governo (il citato Wen Jiabao e i vari ministri e consiglieri di stato) e parlamentari (il Presidente del Comitato permanente della stessa Assemblea nazionale popolare, Wu Bangguo).
Nel corso del Congresso del Pcc è stato emendato lo Statuto, inserendo accanto ai principî base del «Marxismo-Leninismo, Pensiero di Mao Zedong, Teoria di Deng Xiaoping» il riferimento al «pensiero delle tre rappresentatività» reso ufficiale, come si è detto, da Jiang Zemin il 1° luglio del 2001.
La composizione dei nuovi organismi dirigenti del Pcc ha evidenziato un’ulteriore spinta, rispetto al passato, verso il ringiovanimento e l’elevamento dei livelli educativi della leadership. Il nuovo Comitato centrale, 356 membri effettivi e supplenti, è innanzitutto stato rinnovato per oltre la metà; l’età media dei membri è di 55,4 anni (ma il 20 per cento circa ha meno di 50 anni) e quasi tutti sono in possesso almeno del diploma di scuola secondaria superiore. In generale, si tratta di membri che hanno iniziato la propria attività politica successivamente al 1949 e con un background assai diversificato: componenti del precedente Comitato centrale, dirigenti di organismi e imprese statali e istituzioni finanziarie, membri dell’esercito, responsabili politici regionali.
Il disastro della Sars.
La fine del 2002 e i primi passi del 2003 saranno tuttavia ricordati in Cina (e nel mondo) anche per il diffondersi della Sars.
Le fonti ufficiali indicano che i primi sintomi della malattia erano stati segnalati nel novembre del 2002 nella provincia meridionale del Guangdong. Secondo il Ministero della Sanità, al 31 marzo 2003 i casi riportati erano 1190, con 46 persone decedute; il 20 aprile, tuttavia, la stessa fonte segnalava il rapido diffondersi dell’epidemia, con il numero delle persone colpite salito a oltre 1800, di cui 79 vittime. La distribuzione regionale metteva in luce come il nucleo centrale epidemico si concentrasse proprio nel Guangdong, c...