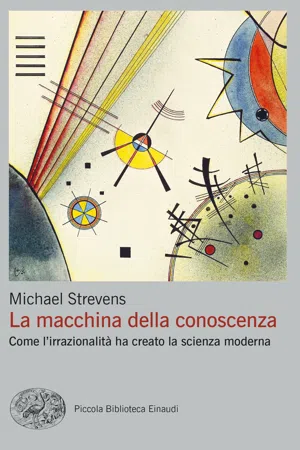Entra in scena la regola che definisce la scienza moderna e le dà un potere senza precedenti di creazione della conoscenza
Per mostrarvi come funziona la regola ferrea della spiegazione, vi presenterò due scienziati altrettanto rispettabili, ma diversi per carattere e cultura, per formazione e stile personale.
La professoressa Giulietta Capuleti, una donna spigolosa ed elegante, è cresciuta tra aule scolastiche, teatri d’opera e musei d’arte contemporanea. È un’appassionata della vita cittadina, con la sua potente organizzazione, le sue griglie e le sue strutture stratificate. Ex campionessa della «Gimcana matematica internazionale», preferisce un’ipotesi che spieghi in modo metodico ed esatto, anche se spiega soltanto alcuni capitoli isolati del volume delle prove. Per ottenere una teoria che soddisfi i suoi criteri e al contempo comprenda ogni cosa, è disposta ad aspettare.
Il professor Romeo Montecchi, un uomo energico e scarmigliato, è cresciuto in mezzo a distese erbose e boschetti, circondato da uccelli e coleotteri. Gli piace pensare con le mani: dopo aver smontato ogni genere di elettrodomestico, dall’aspirapolvere alla pompa di scarico della lavatrice, decise di dedicare la vita alla scienza per comprendere meglio la natura in tutta la sua varietà e sregolatezza. Si rende conto delle virtú della precisione matematica; tuttavia, sempre irrequieto e desideroso di andare avanti, accetterà con piacere uno schema esplicativo appena abbozzato se può rendere conto di una vasta gamma di fenomeni.
Per Montecchi è piú importante la quantità di prove spiegate; per Capuleti contano di piú le qualità superiori della spiegazione – la semplicità, la bellezza, l’esattezza. Forza contro ampiezza. Rigore contro portata.
Ora porterò questi personaggi indietro nel tempo per mettere in scena una rappresentazione teatrale filosofico-scientifica, illuminante e divertente, che si basa su una storia vera. L’azione si svolge in un momento imprecisato della prima metà dell’Ottocento, un periodo in cui la natura del calore era oggetto di un acceso dibattito. Da una parte del dibattito troviamo la teoria del calorico, creata e sviluppata dagli scienziati francesi tra gli anni Ottanta del Settecento e gli anni Venti dell’Ottocento, secondo la quale il calore è una sostanza di qualche tipo. Questo «fluido calorico» scorre costantemente dalle sostanze piú calde a quelle piú fredde, facendo sí che diventino piú calde e – appena riempite di fluido – si espandano. Nel 1830, la teoria del calorico ha ormai raggiunto una serie di successi spettacolari: il calcolo preciso della velocità del suono attraverso l’aria, una prima descrizione di una formula matematica che indica con precisione il tasso di trasferimento del calore attraverso un oggetto come una barra di metallo e una teoria chiarificatrice dell’efficienza dei motori a vapore e di altri motori alimentati dal calore.
Dall’altra parte del dibattito troviamo la teoria cinetica del calore (talvolta chiamata teoria meccanica del calore), secondo la quale il calore è una specie di moto: è il movimento frenetico e disordinato delle piccole particelle di cui sono fatte le cose. La teoria ha un pedigree illustre (è in circolazione dal Seicento, sostenuta, come vedremo, da Sir Francis Bacon), ma alla luce degli exploit della teoria del calorico francese appare piuttosto sorpassata. Vi sono però segni di una rinascita. Benjamin Thompson, scienziato britannico nato negli Stati Uniti che in seguito in Baviera venne nominato conte di Rumford, ha appena dimostrato che usando un trapano smussato per forare una canna di cannone immersa nell’acqua si possono generare per attrito quantità illimitate di calore. Alla fine l’acqua bolle – e continua a bollire finché il trapano è in funzione, anche quando ormai il fluido calorico del sistema dovrebbe essersi esaurito. Il chimico inglese Humphrey Davy ha condotto dimostrazioni simili e presentato argomenti simili.
I professori Capuleti e Montecchi si trovano al centro di questa situazione di stallo e cercano entrambi di spiegare al meglio il comportamento del calore. L’arma teorica scelta da Capuleti è l’apparato matematico della teoria del calorico: sistematico, quantitativo, preciso. Montecchi, invece, è un sostenitore entusiasta della teoria cinetica: anche se non può ancora uguagliare la precisione numerica delle equazioni della teoria del calorico, fornisce meccanismi esplicativi intuitivamente attraenti per una vasta gamma di fenomeni, non ultima la generazione di calore per attrito.
Chi ha ragione? Capuleti o Montecchi? Teoria del calorico o teoria cinetica? Nel 1830, entrambe le scelte sono legittime. Vent’anni dopo, la concezione cinetica avrà superato quella del calorico. In quel momento, però, non è ancora accaduto. La scelta tra le due teorie è dettata non tanto dalle prove quanto dal temperamento e dal gusto di chi le esamina. Montecchi e Capuleti si lanciano occhiate apprensive dai lati opposti del palcoscenico ideologico.
Tra pochi istanti, il sipario si alzerà. Rimane giusto il tempo per una breve avvertenza: ciò che segue non è un fatto storico, è finzione. Il retroscena è storicamente reale, cosí come l’importante problema con cui inizia l’opera. Nel seguito è in gran parte un abbellimento filosofico, inteso non a raccontare la storia della scienza del calore, ma a puntare i riflettori al di là degli attori, sul fondale, per rivelare un piano di accordo scientifico, prestabilito e di cruciale importanza, che sta dietro alla disputa scientifica essenzialmente soggettiva su quale sia la teoria in cui credere.
Molto bene; che il dramma abbia inizio. Capuleti e Montecchi sono impegnati in una discussione. La questione è la capacità del calore di irradiarsi attraverso lo spazio vuoto, cosí come il calore vitale del Sole attraversa il vuoto interplanetario e si riversa sulla Terra. Una cosa simile sembra impossibile se la teoria cinetica è corretta, poiché nel vuoto non vi è nulla che vibri, quindi nulla che possa trasferire dalla fonte alla destinazione i piccoli movimenti che costituiscono il calore. Forse la professoressa Capuleti ha ragione di respingere la teoria cinetica, allora – perché l’ultima considerazione l’ha confutata in modo definitivo, no?
Il fantasioso professor Montecchi, tuttavia, si domanda se il calore non possa viaggiare attraverso lo spazio vuoto in una forma diversa rispetto a quando viaggia attraverso l’aria, la terra e l’acqua. Non potrebbe esistere, ipotizza, un processo – chiamiamolo radiazione – grazie al quale l’energia vibratoria di un corpo caldo si trasforma in «raggi di calore» che, come i raggi di luce, volano attraverso lo spazio vuoto ad alta velocità e, scontrandosi con la materia solida, inducono il tipo di vibrazioni che equivalgono al calore vero e proprio1? La professoressa Capuleti ritiene che questo sia un tentativo chiaramente disperato di salvare la teoria cinetica da ciò che per qualsiasi osservatore neutrale è un’evidente falsificazione.
La manovra salvifica di Montecchi, tuttavia, non soltanto è logicamente ammissibile, ma in effetti è del tutto corretta. Il calore del Sole arriva sulla spiaggia grazie a radiazioni elettromagnetiche di certe frequenze, per lo piú nella banda di frequenza dell’infrarosso2. Questi raggi di calore non sono essi stessi una forma di calore3; il calore viene trasformato in energia elettromagnetica, che viaggia come un raggio e poi, quando colpisce la sabbia e i corpi dei bagnanti, viene ritrasformata in calore, esattamente come sostiene il contorto racconto esplicativo del professor Montecchi.
Ciò malgrado, lo scetticismo di Capuleti ha una motivazione logica. Per spiegare il movimento e il comportamento del calore le serve soltanto un tipo di cosa, il fluido calorico. Montecchi ha postulato due tipi di cose – il calore e la radiazione termica – e ciascuna spunta fuori al momento giusto per svolgere il compito in cui eccelle e poi si trasforma opportunamente nell’altra quando diventa necessario che lo faccia. Come minimo, Montecchi sembra violare la vecchia massima metodologica «non presupporre due entità quando ne basta una» – di solito chiamata «rasoio di Occam», in onore del filosofo medievale Guglielmo di Occam. Non è affatto irragionevole che Capuleti minacci Montecchi di rasarlo a zero.
Ecco quindi un altro esempio dell’essenziale soggettività del ragionamento scientifico. Che la disponibilità di Montecchi a postulare la radiazione – un modo completamente nuovo in cui il calore potrebbe viaggiare nell’universo – sia o no saggia dipende dalla prospettiva. Per Montecchi, è una scoperta ispirata; per Capuleti, è indulgere alla poesia. Lui percepisce il primo barlume dei raggi del Sole e il gioioso canto dell’allodola; lei soltanto l’oscurità e il canto struggente dell’usignolo.
Montecchi e Capuleti non sono d’accordo su quale teoria spieghi meglio le prove. Né su che cosa suggeriscano particolari prove – soprattutto la capacità del calore di viaggiare attraverso lo spazio vuoto – riguardo alla teoria dell’altro. Che sia una versione di Romeo e Giulietta in cui gli amanti sopravvivono, ma i loro battibecchi familiari portano lentamente ma inesorabilmente a differenze inconciliabili?
Ci aspettiamo che alla fine un dramma elisabettiano sfoci in modo commovente nel vero amore o nella violenza e un dramma moderno (forse) nell’infelicità o nell’autoconsapevolezza. Il dramma della scienza, tuttavia, non ha mai necessariamente fine. Montecchi e Capuleti possono continuare a dialogare all’infinito senza esaurire le battute. Il motivo è che vi è sempre un modo puramente scientifico per perpetuare una discussione scientifica: effettuare altre misurazioni o condurre nuovi esperimenti.
Il copione senza fine, il codice di condotta per il dibattito scientifico in base al quale Montecchi e Capuleti possono continuare a discutere in eterno è fornito dal precetto metodologico che chiamo «regola ferrea della spiegazione». La regola è abbastanza semplice: per risolvere le differenze di opinione, anziché gridare, litigare, filosofare, moraleggiare, sposarsi o fare appello a un potere superiore, gli scienziati devono condurre test empirici. Questo è tutto; la regola non cerca in alcun modo di interpretare le prove, di stabilire vincitori e vinti. In realtà, la sua funzione non è tanto risolvere la disputa quanto prolungarla. La perpetuazione fine a sé stessa del conflitto drammatico è l’essenza del metodo scientifico e, in quanto principale perpetuatrice, la regola ferrea si afferma come cuore, anima e forza vitale dell’indagine scientifica.
Il primo atto si è chiuso con un’impasse. Montecchi ha detto che il calore che viaggia attraverso lo spazio vuoto assume la forma di radiazione, Capuleti che è una spuma di fluido calorico che sfreccia nel vuoto. La regola ferrea mostra loro come continuare a discutere, come costruire un secondo atto scientifico intorno al loro disaccordo, improvvisando una serie di scene sperimentali, ossia conducendo una sequela di verifiche empiriche.
Per decidere la questione di come si muove il calore nel vuoto, Montecchi e Capuleti potrebbero, per esempio, concordare di misurare come cambia la velocità del calore attraverso un vuoto creato in laboratorio con l’inserimento di una lastra di vetro. Se Montecchi ha ragione e il calore si trasmette per radiazione, allora i raggi di calore dovrebbero attraversare il vetro come i raggi di luce, non rallentando affatto. Se Capuleti ha ragione e il calore è un fluido calorico, un liquido invisibile che scorre, allora il vetro dovrebbe fermare il calore, o almeno rallentarlo in misura significativa mentre passa per diffusione da una parte all’altra della lastra.
Supponiamo che eseguano l’esperimento. La lastra di vetro lascia inalterato il tempo impiegato dal calore per attraversare la camera a vuoto, quindi il test sembra confermare la teoria di Montecchi e smentire quella di Capuleti. Capuleti potrebbe arrendersi, ma può anche continuare a combattere. Dopo tutto, la sua ipotesi del calorico prevede un rallentamento significativo soltanto in combinazione con alcuni assunti ausiliari – in particolare, l’assunto che la lastra di vetro costituisca una barriera efficace contro il fluido calorico. Forse non è cosí. Forse sparare calore su una lastra di vetro è come dirigere una manichetta antincendio su una rete da pesca: la sostanza passa attraverso fori invisibili a noi, ma enormi in confronto alle particelle che compongono il fluido (sempre che sia composto di particelle). Per verificare la «congettura della rete da pesca» di Capuleti, ammette Montecchi, saranno necessari altri test. Forse impilando molte lastre di vetro? Se l’analogia con la rete da pesca regge, un numero sufficiente di strati dovrebbe rallentare il fluido calorico.
Supponiamo ora che l’esperimento della lastra di vetro produca il risultato oppost...