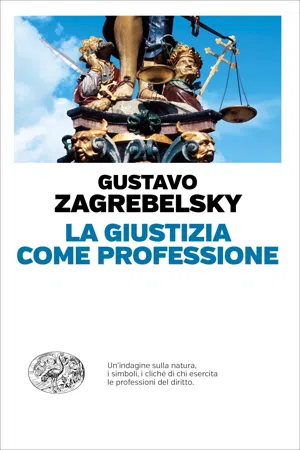1. Intermediazione.
L’avvocato è, innanzitutto, un intermediario, un mediatore (stiamo parlando dell’avvocato tipico: chi siano gli avvocati a-tipici si dirà piú avanti). Mediatore, in che senso? Gli affari e i contrasti d’ogni giorno quando sono portati in giudizio devono essere trasformati in questioni giuridiche. Devono trasformarsi – come dicono i giuristi – in fattispecie legali, cioè immagini (species) del fatto (facti) rilevanti secondo la legge. Non stiamo qui a disquisire sui rapporti tra fatti e norme, ciò su cui tanto si è pensato, discusso e scritto. Ma è intuitivo che una cosa è ciò che il profano può pensare di un torto subíto, di un diritto conculcato, di una dignità violata, eccetera, e un’altra è la configurazione necessaria affinché ciò che è stato patito – cioè il dato fattuale grezzo – diventi un “caso” giuridico. L’avvocato è colui che opera una prima trasfigurazione e fa entrare la multiforme esperienza della vita nella tipicità del diritto o, dal punto di vista opposto, è colui che fa entrare il diritto nella vita: una sublimazione giuridica o una contaminazione fattuale.
In questo senso, si può dire che l’avvocato al quale ci si rivolge per chiedere le sue prestazioni professionali è un mediatore, un intermediario, qualcuno che si distacca dal volgo, uno «che ha studiato», quasi un sacerdote che opera una transustanziazione, la quale introduce in una dimensione preclusa al comune mortale. Potrebbe trovarsi qui una chiave interpretativa – sia pure alquanto banale, da giuristi – del già citato fulminante e difficilmente decifrabile breve racconto di Franz Kafka dal titolo Davanti alla legge.
La regola generale è dunque che davanti al giudice si compare per mezzo dell’avvocato. Dalla porta della legge, l’uomo di campagna non è autorizzato a passare se non è accompagnato. Questa realtà è, di per sé, un gravissimo atto d’accusa nei confronti del «diritto», come è venuto configurandosi nelle nostre società: è un ritorno al tempo lontano in cui la conoscenza del diritto e la sua gestione erano «riservate» e l’uomo comune, nella sua ignoranza, era un semplice oggetto passivo. Le regole giuridiche sono pubblicate in appositi documenti, dotati di efficacia legale; ma chi vi accede da profano e, una volta che ha avuto accesso, ci capisce qualcosa? Perciò accade che quella che è una grave limitazione dei tuoi diritti di cittadinanza (che comprendono, ovviamente, la conoscibilità del diritto cui si è sottoposti) si rovesci in una “premura” a tuo vantaggio: non lasciarti solo davanti alla legge.
Firmando la «procura», si è nelle mani dell’avvocato, almeno fino a quando non viene a cessare il rapporto di fiducia e l’avvocato rinunci o la parte in causa revochi la delega scegliendone un altro o facendosene nominare un altro «d’ufficio». La possibilità di difendersi da soli, senza intermediari, esiste solo in casi marginali di poco valore e come eccezioni. L’avvocato è un pedaggio che si deve pagare per accedere all’amministrazione della giustizia. Senza avvocato, il singolo che vuol far valere un suo diritto o difendersi da una pretesa o da un’accusa è impotente. E, facendosi rappresentare dall’avvocato, è come se si riconoscesse bambino e accettasse d’essere parte d’una macchina – la macchina giudiziaria – che è messa in moto dallo Stato che celebra un suo rito.
2. Compito duplice.
Cosí si comprende che, di regola, nei processi connotati politicamente come quelli a carico di eversori e terroristi gli imputati rifiutano la giustizia amministrata da uno Stato che considerano nemico radicale e negano la legittimità del tribunale. La prima cosa che viene fatta è il rifiuto di nominare il difensore e di accettare quello nominato d’ufficio. L’avvocato, infatti, è un elemento della macchina giudiziaria, senza il quale il processo non potrebbe svolgersi. Il rifiuto diventa cosí un atto di lotta politica e un suo coerente proseguimento. Accettare la difesa di un avvocato significherebbe ammettere contraddittoriamente la legittimità della giurisdizione d’uno Stato che si vorrebbe abbattere. Nel 1976-77, in occasione del processo celebrato a Torino a carico di esponenti delle Brigate Rosse, il presidente dell’Ordine degli Avvocati Fulvio Croce, incaricato della difesa d’ufficio, fu ucciso per conto degli imputati, avendo accettato di difenderli.
L’avvocato è dunque un soggetto del processo che opera nell’interesse pubblico come «collaboratore della giustizia» o del giudice, o della Giustizia, espressioni alle quali gli avvocati sono affezionati perché conferiscono loro una particolare dignità. Per questo motivo, la loro presenza, a parte i casi di giustizia spicciola, è sempre necessaria. Ma l’avvocato è anche un «difensore», cioè un soggetto qualificato che opera nell’interesse del suo assistito. Ciò significa che è un soggetto di parte. Suo dovere professionale è sostenere le ragioni del suo assistito e rintuzzare le ragioni degli avversari.
C’è, dunque, una duplicità nella figura dell’avvocato, e la duplicità può diventare una contraddizione addirittura lacerante, una contraddizione che ha una lunga storia alle spalle1. Come «collaboratore della giustizia» o del giudice, l’avvocato deve utilizzare tutti e soltanto i mezzi funzionali a ciò che si chiama «giustizia giusta». Non potrà inventare prove false, ovviamente; né suggerire comportamenti illeciti al suo assistito. Ma potrà, quando siano a sfavore del suo cliente, ignorare altre prove di cui egli disponga e di cui la controparte sia all’oscuro? Può usare «stratagemmi» (artificia), come ammetteva perfino san Tommaso, ma non «inganni»? Fino a che punto può denigrare la figura umana dell’avversario e fino a che punto può santificare quella del suo difeso: questione che si pone acutamente, per esempio, nelle cause di separazione e divorzio e di affidamento dei figli in cui le “prove” sconfinano necessariamente dai meri fatti alla psicologia, alla personalità in generale delle parti? Qualsiasi argomento legale, qualsiasi artificio processuale può e deve essere utilizzato a favore del proprio assistito? O, pure qui, ci sono dei limiti? Per esempio, è davvero lecita la deliberata strategia, tanto diffusa, che mira alla prescrizione del reato – istituto che deriva da esigenze ordinamentali oggettive – e si traduce spesso in beffa per le aspettative delle «parti lese» e, in genere, vanifica le aspettative di giustizia? Gli espedienti dilatori di chi sa di non potersi aspettare una pronuncia favorevole nel merito, che mirano a fiaccare l’altra parte e a cavarsela con una transazione al ribasso, sono sempre accettabili? L’abilità dialettica può essere utilizzata per confondere l’avversario e il giudice? Nelle scuole di retorica si è insegnato come sostenere una tesi e quella opposta con uguale efficacia. Fino a che punto è lecito approfittare della debolezza della controparte, o della semplicità-ingenuità del giudice, o della sua sprovvedutezza, della sua influenzabilità e dei suoi pregiudizi? È lecito all’avvocato giocare la parte del gatto col topo?
In breve: l’avvocato-difensore deve «vincere la causa» nell’interesse del cliente; l’avvocato - collaboratore della giustizia dovrebbe far vincere il diritto. Nell’avvocato che invoca come suo titolo di merito la collaborazione nel compito di promuovere la giustizia convivono questi due doveri. Ma, tra la possibile vittoria della causa e l’altrettanto possibile trionfo della giustizia, può esserci contraddizione. Che cosa dice l’etica professionale? Possiamo trovare una risposta soddisfacente nella formula del giuramento che deve essere prestato dal giovane avvocato? Dice: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principî del nostro ordinamento» (corsivi nostri). Il giovane avvocato che pronuncia queste parole si rende conto della tensione tra i due lati della professione che si accinge a svolgere e si chiede qual è il comportamento deontologicamente corretto quando quella tensione deve sciogliersi nell’azione concreta?
Il codice deontologico tenta di porre argini all’abuso della funzione defensionale, per esempio vietando all’avvocato di suggerire comportamenti illeciti al suo assistito, di sottoporre al giudice prove e documenti che sappia essere falsi. Il che è talmente ovvio da apparire perfino superfluo. Cosí come è ovvio che sia vietato, sia anzi un reato, l’«intralcio alla giustizia» consistente nella corruzione dei testimoni e altri soggetti che offrono dichiarazioni nel corso dell’attività di giustizia. Ma c’è tutta una gamma di comportamenti che stanno nella zona grigia che l’avvocato abile sa usare per piegare la giustizia dalla parte del suo assistito e costruire cosí la sua fama e il suo successo professionale. Soprattutto, egli si chiederà se non venga meno al mandato che gli è conferito qualora non usi tutte le carte che può avere in mano per raggiungere lo scopo, cioè la difesa piú efficace in vista del provvedimento del giudice comunque piú favorevole al proprio assistito. Ma la difesa piú efficace, in tali casi, può ancora e sempre dirsi una «collaborazione» con il giudice? La «giurisprudenza disciplinare», che riguarda le violazioni delle norme di «deontologia» ed è esercitata dallo stesso ordine professionale cui l’avvocato appartiene, è significativamente sbilanciata sul lato dei doveri di correttezza e diligenza nei rapporti con l’assistito; quasi mai il tema della correttezza in quanto tale, considerata dal punto di vista del buon funzionamento della giustizia, viene in evidenza. La difesa prevale sulla giustizia.
3. Conflitti di lealtà.
È difficile la posizione dell’avvocato. Due fedeltà: verso colui che gli si rivolge per ottenerne il «patrocinio»; verso lo Stato che lo abilita a svolgere una funzione al servizio della giustizia (ciò che spiega il fatto che l’avvocato deve esserci, anche quando l’imputato non lo vuole, perché intende difendersi da sé o perché contesta in toto il processo cui è sottoposto). L’avvocato che non si prodiga per la difesa di chi si rivolge a lui incorre nel reato di «patrocinio infedele» con conseguenze disciplinari, responsabilità civile e penale. Tuttavia, il patrocinio infedele è un reato (come dicono i giuristi) «plurioffensivo», cioè un reato contrario sí all’interesse dell’assistito ma, al tempo stesso, contrario al buon funzionamento della giustizia, cioè a un interesse pubblico, dello Stato. Doppia faccia, dunque: strettamente orientata alla parte che sta nel processo, l’una; orientata allo Stato che veglia sul corretto svolgimento dei processi, l’altra: l’avvocato è al tempo stesso un libero professionista e, in certo senso, un funzionario pubblico. Ogni tanto si fa strada la proposta di dare rilievo costituzionale alla professione forense, con qualche norma da inserire nella Costituzione, ma finora non se ne è fatto nulla: questa duplicità è difficile da regolare per il rischio che una vocazione prevarichi sull’altra (come è nei regimi autoritari, dove l’avvocato è un funzionario alle dipendenze del governo).
Questa duplicità espone gli avvocati e la loro coscienza etico-professionale a molte questioni che, nella pratica, sono spesso tranquillamente ignorate. Tutto può sembrare lecito nell’interesse del cliente. Gli avvocati non sono tutti della stessa pasta e in ogni distretto giudiziario ve ne sono alcuni di cui si loda la correttezza e altri di cui si teme la spregiudicatezza. I giudici, per lo piú, sanno distinguere.
Non è questione dell’uso di veri e propri, evidenti, strumenti illeciti, come la subornazione di testimoni o la creazione di prove false. È questione, invece, dei molteplici strumenti di «abuso del diritto» di difendere. Già si è accennato all’abuso che si fa della prescrizione come strumento defensionale. La prescrizione è la conseguenza della rinuncia da parte dello Stato all’esercizio della sua «potestà punitiva» per ragioni puramente obiettive: la lontananza nel tempo del fatto, la possibilità che chi l’ha commesso non sia ormai piú la stessa persona, l’esigenza di liberare, dopo un certo periodo, dal rischio incombente di un processo per vicende remote, ecc. La prescrizione è una norma di civiltà. Ma si può ammettere che sia usata per vanificare il processo? Difendersi non vuol dire vanificare, come chiunque capisce immediatamente. Tanto piú, in quanto per raggiungere il desiato approdo la difesa ricorre facilmente a veri e propri abusi dei propri diritti: espedienti, pregiudiziali, rinvii, impedimenti e ricorsi pretestuosi, staffette nell’incarico defensionale con conseguenti ritardi per arrivare, alla fine, a rendere vana tutta l’attività precedentemente svolta. E, se il giudice decidesse d’accelerare, allora sarebbe accusato di voler male all’imputato e d’essere prevenuto nei suoi confronti.
Il difensore deve conoscere e usare tutti i mezzi che la legge mette a sua disposizione. Il «patrocinio infedele» è un reato e la negligenza espone l’avvocato al risarcimento del danno. Ma l’abuso della procedura può trasformare il diritto processuale nella Magna Charta degli arzigogoli. Dove è il limite? Il diritto processuale, soprattutto penale, è diventato, nella pratica, spesso piú importante del diritto sostanziale. Detto altrimenti: sono piú efficaci i difensori che sanno del processo e sono bravi nell’usare le sue insidie che non quelli che sanno di reati e pene.
4. Misteri.
Si dirà: alla fine è pur sempre presso il giudice che il diritto si afferma e si realizza. Ma l’opera dell’avvocato, a sua volta, non è forse quella di orientarlo, cioè di condizionarlo, in un senso o nell’altro? Dunque, dobbiamo ammettere che il diritto di cui parliamo, quando lo osserviamo non nelle inerti parole d’un testo legislativo...