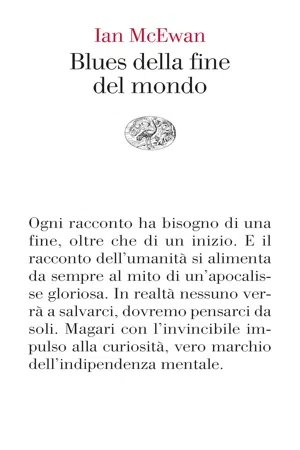Dal 1839 in poi, l’archivio fotografico mondiale è andato aumentando con crescente velocità, moltiplicandosi in una congerie pressoché infinita di immagini che ricordano la vertigine di una biblioteca borgesiana. Questa tecnologia ossessiva ci accompagna da ormai cosí tanto tempo che siamo in grado di guardare, che so, una scena di folla o una via trafficata di fine Ottocento sapendo per certo che ognuna di quelle figure è morta. Non solo la coppietta di innamorati in posa nel parco, ma anche il bambino che gioca col cerchio, la fantesca inamidata, il solenne bebè seduto rigido in carrozzina: la loro vita ha fatto il proprio corso e tutta quella gente non c’è piú. Eppure, cosí congelate sulla carta tinta seppia, queste persone ci appaiono curiosamente e intensamente dimentiche del fatto che devono morire; per dirla con Susan Sontag, «ogni fotografia proclama l’innocenza, la vulnerabilità di vite dirette verso la propria distruzione…» «La fotografia» dice ancora, «è l’archivio della nostra mortalità. Basta premere un tasto per conferire all’istante un’ironia postuma. Le fotografie ci mostrano individui presenti in modo inconfutabile e preciso all’interno delle loro rispettive esistenze; esse hanno il potere di radunare persone e cose che un attimo dopo si saranno già disperse, che saranno cambiate e avranno ripreso il corso del proprio destino individuale».
Lo stesso, un giorno o l’altro, potrebbe accadere con una foto di tutti noi, oggi raccolti in questa sala. Provate a immaginare un futuro osservatore che ci scruti in una vecchia foto, tra un paio di secoli, e che ci trovi bizzarramente antiquati, assorti nell’evidente rilevanza dei nostri affanni, ignari del quando e del come si compirà il nostro destino sicuro, e morti da un pezzo. Morti, in massa, da un pezzo.
Siamo allenati alle riflessioni sulla mortalità del singolo: questa è anzi l’energia che informa il racconto delle nostre esistenze. Si presenta già nell’infanzia sotto forma di fatto sconcertante, può riemergere nell’adolescenza come tragica realtà che ogni cosa intorno a noi sembrerebbe smentire, sfuma forse nella frenesia dell’età adulta per poi rifarsi viva all’improvviso, magari in un attacco premonitore di insonnia. Una delle piú alte riflessioni laiche sulla morte compare in Aubade di Philip Larkin:
… la certezza dell’annientamento
verso cui tutti noi viaggiamo
e dove saremo smarriti per sempre.
Non essere qui e da nessuna altra parte e
presto.
Nulla di piú terribile, nulla di piú vero.
Affrontiamo la nostra mortalità attraverso conversazioni private, nel familiare conforto della religione che Larkin definiva «quel vasto broccato musicale mangiato dalle tarme, creato per far finta di non morire mai». E la sperimentiamo in veste di tensione creativa, di paradosso fertile nelle nostre arti e in letteratura: giacché ciò che è descritto, amato o celebrato non può durare, l’opera deve sforzarsi di sopravvivere al suo creatore. Larkin, dopo tutto, adesso è morto. A meno di essere suicidi irremovibili e ben organizzati, non ci è dato di sapere la data del nostro decesso, però sappiamo che tale data si inscrive in un certo intervallo di possibilità biologiche e che, con il nostro invecchiare, tale intervallo è destinato ad approssimarsi sempre di piú al punto esatto.
Valutare le modalità e i tempi del nostro decesso collettivo, non nel senso di questa sala affollata, ma della fine di una civiltà, del progetto umano nel suo insieme, è ancora piú arduo: potrebbe verificarsi entro i prossimi cent’anni, non verificarsi in due millenni, o ancora accadere con una lentezza impercettibile, con un piagnisteo, non uno schianto. Ma a fronte di questa inconoscibilità, sono spesso fiorite teorie sicure riguardo all’avvicinarsi della fine. Nel corso della storia, l’umanità si è lasciata incantare da racconti che predicono la data e il modo della distruzione totale, sovente irrobustiti dal concetto di castigo divino e redenzione in extremis; l’estinzione della vita sul pianeta, gli ultimi giorni, il tempo della fine, l’apocalisse.
A molte di queste storie che raccontano il futuro nel minimo dettaglio, c’è chi crede con devozione. I movimenti apocalittici contemporanei, siano essi cristiani come musulmani, violenti oppure no, sembrano condividere la fantasia di una fine violenta, e influenzare profondamente la politica attuale. La mentalità apocalittica può essere demonizzante – in altre parole, può disprezzare i membri di altre comunità o fedi, i quali adorerebbero falsi dei e non avrebbero perciò speranza di essere salvati. Inoltre, la mentalità apocalittica ha tendenze totalitaristiche – si tratta cioè di idee monolitiche e onnicomprensive, fondate su credenze spasmodiche nel soprannaturale, immuni tanto alla propria dimostrabilità quanto al contrario, e indifferenti all’impatto di nuovi dati di informazione. Ne derivano momenti di pathos involontario, di comicità perfino, che forse ci rivelano qualcosa sulla nostra natura: giacché il futuro deve essere costantemente riscritto, occorre individuare nuovi Anticristi, nuove Bestie, Babilonie e Meretrici, mentre i precedenti appuntamenti con giudizio universale e redenzione vengono aggiornati a data successiva.
Nemmeno il piú superficiale degli studiosi dell’apocalisse cristiana potrebbe permettersi di ignorare l’opera di Norman Cohn. La pubblicazione del suo magistrale I fanatici dell’Apocalisse risale a mezzo secolo fa e ha conosciuto continue ristampe. Si tratta dello...