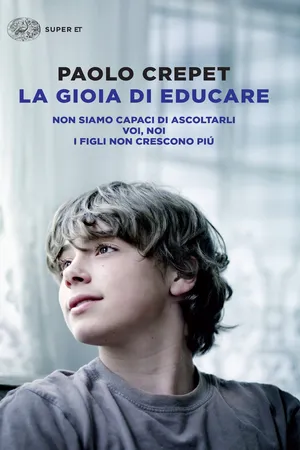
eBook - ePub
La gioia di educare
Non siamo capaci di ascoltarli. Voi, noi. I figli non crescono più
- 424 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Mai come oggi una generazione di giovani vive altrettanto benessere e disarmante vulnerabilità. Ragazze e ragazzi cresciuti senza conoscere il senso della frustrazione e del dolore, che tentano di sopravvivere aggrappati a un presente imbalsamato di privilegi, terrorizzati da un futuro insicuro. Identità fragili alle prese con famiglie fragili. Genitori eternamente indecisi tra il ruolo di amici o complici, fra severità e buonismo, controllo e fiducia. Mai come oggi i giovani devono affrontare una società incapace di prestar loro l'attenzione e il rispetto, i piccoli segni di affetto e i grandi ideali di cui hanno bisogno. Da anni Paolo Crepet viaggia lungo l'Italia incontrando genitori, studenti, insegnanti, educatori, per comprendere i motivi di questa crisi silenziosa che attraversa la scuola e la famiglia. Dal suo lavoro di ascolto sono nate le riflessioni contenute in Non siamo capaci di ascoltarli, Voi, noi e I figli non crescono piú, qui riuniti in un unico volume come capitoli di una stessa opera che parla di una sola, grande e dimenticata questione: l'emergenza educativa. Perché, come sostiene Crepet, il rischio piú grande è «che i nostri ragazzi siano costretti - come i trapezisti di un circo - ad attraversare la vita in equilibrio su una corda sospesa nel vuoto. Mentre gli adulti non sembrano piú in grado di alzare il loro sguardo al cielo».
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La gioia di educare di Paolo Crepet in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Personal Development e Self Improvement. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
I figli non crescono piú
A una ragazza, a un ragazzo
La fatica di crescere
Conosco bene questa città. Mi ci sta portando un tassista preso al volo all’uscita dell’aeroporto. Incautamente gli ho fatto fretta, lui mi rassicura in un italiano incerto che sa molto piú di Maghreb che di Padania: «Quindici minuti e ci siamo…» «Un po’ poco», penso, ma sta già volando tra due file di Tir che occupano l’autostrada. Suona il clacson come se conducesse un’ambulanza o dovesse farsi largo in un mercato di Tangeri, abbaglia chiunque di fronte a noi tenti un sorpasso e la foschia, bruscamente illuminata, sembra infittirsi. Guida tranquillo: cespuglio di capelli neri raccolti in un codino, musica franco-araba: ne tamburella sul cruscotto il ritmo con le dita inanellate della destra, la sinistra impugna il volante ricoperto di plastica maculata.
Dal mio scomodo sedile posteriore ciò che vedo e odo appare incomparabile con i ricordi della mia adolescenza in questa terra di Nord-est allora lenta e dolce, ora scattante e scostante. Segnali di un’evoluzione straordinaria e inquietante: il traffico impazzito, la distesa di capannoni che ha sommerso i campi di erba spagna, il confronto ravvicinato con gente che un tempo s’incontrava solo viaggiando lontano, quindi con differenze, modi di fare, colori, musiche. Anche un taxi può contenere una metafora, quando i cambiamenti avvengono a ritmo cosí sincopato.
Finalmente, dopo neppure un quarto d’ora, la mia freccia nordafricana annuncia che siamo arrivati a destinazione. Lui ride e io non chiedo il resto.
Ogni volta che torno in un posto dove sono già stato per una conferenza mi assale una sensazione ambigua: da un lato la consapevolezza e la responsabilità di rappresentare per qualcuno un punto di riferimento non effimero, dunque una conferma anche per me; dall’altro la paura che le persone possano essersi in qualche modo assuefatte alle parole. M’intralcia il timore di ripetermi.
I lampioni al neon del piazzale della Fiera opacizzano una nebbiolina fastidiosa, raddensano un’idea familiare d’umidità pervadente, capace d’infilarsi sotto il cappotto, dentro le scarpe. Nonostante la concomitanza con l’ennesima partita internazionale di calcio, il parcheggio è pieno di macchine: quasi tutte di lusso, compresi i gipponi aggressivi con le gomme giganti e i paraurti lucenti dei telefilm americani.
Superate le grandi porte di vetro, nel salone d’accesso si allungano file di uomini e donne silenziosi, ordinati secondo l’iniziale del cognome.
Per raggiungere il palcoscenico, mi fanno salire da una scala laterale. Devono provare i microfoni, indicarmi la poltrona, discutere la scaletta della serata, i tempi degli interventi introduttivi: tutto procede con precisione, come la preparazione puntigliosa della prima di uno spettacolo. Si percepiscono entusiasmo, ansia, eccitazione. Dalla fenditura del sipario riesco a vedere quasi interamente la sala: sembra enorme, impossibile da riempire, eppure grado a grado il panno rosso delle poltrone scompare, coperto da sagome di persone di ogni età. Qualcuno potrebbe essere già nonno, altri sembrano giovani coppie fresche d’innamoramento, c’è perfino qualche gruppo di adolescenti: raro, in una manifestazione dedicata agli adulti.
Nelle due aree attrezzate per i bambini che avevo notato all’entrata, un gruppo di animatori dipinge assieme ai piccoli figli dei partecipanti grandi fogli stesi sul pavimento: un segno dell’intelligenza e sensibilità degli organizzatori. Chi ha lavorato per la riuscita della serata non è un’università o una parrocchia, nemmeno un’amministrazione comunale o un’associazione di genitori o una scuola, ma la Confederazione degli artigiani di Vicenza.
In questi luoghi generalmente si parla di lavoro, produzione, sindacato, tasse e sgravi fiscali, delocalizzazione, arrembaggio dei cinesi; invece questa volta si discute di famiglia, di figli, di educare. Anzi, si avverte la necessità di organizzare una «scuola per genitori» funzionante per un intero anno, che prevede conferenze, seminari, focus-group.
Nulla avviene per caso, diceva il maestro.
L’incontro si prolunga fino a tardi. Sembra che la gente non abbia fretta di tornare a casa, eppure domani si lavora. Forse sentono di aver ricucito, almeno per un attimo, il senso di una comunità: hanno trovato l’occasione per spegnere una volta tanto la televisione e uscire di casa, incontrarsi, confermarsi l’un l’altro d’esser fatti della stessa pasta. Assaporano il significato di parlare di sé con concittadini che sentivano alieni, ormai; e invece sono proprio gli stessi problemi quotidiani che questa volta non affrontano da soli, ma seduti vicini.
Sono arrivati sin qui a sentire di essere ancora vivi: arrabbiati o convinti, stanchi o indignati, dubbiosi o entusiasti, ma vivi. Vivi e preoccupati: di cosa, non è facile capire. Però a guardare quella folla, ad ascoltare le domande si percepisce il profondo, drammatico cambiamento di questi ultimi quarant’anni.
Non si tratta soltanto di una transizione economica, dell’essere passati, nel giro di qualche breve lustro, dalla polenta alla Bmw.
I processi produttivi – in qualche modo, per lo piú positivo – questa gente è stata capace di gestirli. Soltanto che ora ha capito che un simile sforzo, per quanto grande, non basta piú, si è resa conto che proprio questa straordinaria promozione sociale ha prodotto effetti collaterali impensabili soltanto qualche anno fa. Effetti che hanno avuto un bersaglio speciale, fondamenta dell’intera comunità: il rapporto tra le generazioni, ovvero come progettare un futuro possibile per tutti.
Terminata la conferenza, stemperato il dibattito, gli organizzatori m’accompagnano a bere un bicchiere di vino e a mangiare qualcosa. Un artigiano si siede a fianco a me, la voce di chi ha voglia di confessare un problema grave. «Ci ho messo quarant’anni di fatica e sudore per tirare su un capannone, adesso dirigo un’azienda che funziona, vendiamo bene i nostri prodotti in tutto il mondo anche se in giro c’è crisi. Ho un figlio di ventotto anni, mi piacerebbe lasciare ciò che ho costruito a lui, ma se lo faccio quel capannone tra sei mesi non c’è piú. E sa perché? Quel ragazzo non sa far niente, ha preso un diploma senza impegnarsi, è iscritto all’università e fa sí e no un paio d’esami all’anno, vive in casa con noi, ha una fidanzata che come lui pensa solo a divertirsi, non hanno nessuna intenzione di sposarsi figuriamoci di mettere su famiglia. Mia moglie è disperata come me ma lo difende sempre, lo chiama “poverino”… Cosa dovrei fare, prenderlo a calci o abbandonarlo alla sua vita insulsa?»
Un altro imprenditore ascolta con particolare interesse, si unisce al lamento: «Anch’io sono nella stessa situazione. Mio figlio sta per compiere trent’anni e non fa nulla nemmeno lui. Con mia moglie abbiamo deciso di costringerlo ad andare a vivere per conto suo, sperando che cosí cominci a capire cos’è la vita. Gli abbiamo comprato un appartamentino nel nostro stesso quartiere, lui c’è andato con la ragazza, l’hanno arredato… poi l’ha affittato a un amico ed è tornato a casa da noi. Mia moglie, tutto sommato, non è dispiaciuta. Cosa dovrebbe fare un padre, con un ragazzo cosí?»
Cerco di allargare la discussione agli altri commensali: risultano piú o meno tutti nelle stesse condizioni.
Le ragioni del declino sociale ed economico del Paese non sono dunque nascoste soltanto nella globalizzazione o nell’improbabile concorrenza di Paesi dell’estremo Oriente, una ragione profonda, quasi indicibile ha invece a che fare con ciò che abbiamo voluto e saputo trasformare e con ciò che abbiamo voluto mantenere. Una radice che s’insinua e ramifica fin dentro le nostre case, nei salotti, nelle camere dei nostri figli.
Cerco d’immedesimarmi nel dramma di quell’artigiano imprenditore: il capannone è stato capace di tirarlo su – con enorme fatica, ingegno e coraggio – e forse anche di ingrandirlo, ma ha fallito nella cosa piú difficile: l’educazione dei propri figli. Lo guardo, mi chiedo se quell’uomo rappresenti un’eccezione o una regola deviata di una comunità mal cresciuta.
Temo il peggio. Mi torna alla mente la lettera di una signora toscana alla rubrica che tengo da tempo in un settimanale di grande diffusione. Vado a rileggerla. Fa impressione: il contenuto è straordinariamente coerente con il racconto dell’imprenditore vicentino. Vite analoghe, stesse preoccupazioni, stessa fragilità. Ne trascrivo un brano:
«… mio figlio di ventitre anni ha smesso di frequentare l’università (ha dato sette esami) già alla fine dello scorso anno accademico. Da allora non si occupa piú di niente, e all’invito: “Cercati un lavoro” scappa via coprendosi le orecchie per non sentire; se insisto comincia a essere violento e diventa capace di rompere una porta a pugni. Non si vuole prendere la responsabilità di una persona adulta qual è… Io e mio marito abbiamo provato in tutti i modi a fargli capire che il lavoro è alla base del suo avvenire, ma lui sfugge o rinvia, e alla fine tutto rimane come prima: dorme fino a tardi, ascolta musica, fuma, vede tv e dvd. E basta. È cosí ormai da otto mesi e non vedo vie d’uscita. Mi dia un consiglio lei su come affrontare questa situazione e a chi eventualmente rivolgermi per essere aiutata…»
Di solito, quando ascolto un’argomentazione cosí largamente condivisa, cerco di vedere dove si nasconde l’eccezione che la conferma: è un piccolo trucco che funziona per capire meglio le cose. Propongo quindi a quel gruppo di imprenditori di pensare se tra i colleghi ve ne sia uno con una storia familiare diversa, opposta. Confabulano un poco, poi uno mi dice: «Sí, ha ragione lei, uno ce n’è…» E mi raccontano la storia di Nello.
Nello è un artigiano come loro e come loro ha creato un piccolo patrimonio dal nulla: un lavoro da bestia per quarant’anni, creatività, un briciolo d’astuzia. Risultato: dal niente, da un piatto di baccalà a una florida azienda di macchinari di precisione venduti soprattutto negli Usa.
Nel frattempo a casa la famiglia cresce apparentemente tranquilla: la moglie che appena può dà una mano a tenere i conti dell’azienda; una figlia che presto si sposa; un figlio, Bruno, simpatico e un po’ indolente. Finito il liceo, quest’ultimo s’iscrive a Economia e commercio, ovviamente a pochi chilometri da casa. Eppure non frequenta, non dà esami, in casa non collabora: sopravvive senza gioie e senza lamenti. Finché il padre, dopo l’ennesima litigata, lo mette con le spalle al muro: «Ti devo dare due notizie», lo avverte risoluto, «una peggiore dell’altra: la prima è che domani mattina verrà il falegname a cambiare la serratura della porta di casa, né io né tua madre ti daremo una copia delle chiavi, quindi tu sarai fuori. La seconda è che se vuoi sono pronto a pagarti viaggio e iscrizione al master negli Stati Uniti di cui abbiamo tanto parlato e che tu non hai mai preso in considerazione. Prendere o lasciare. Hai tutta la notte per pensarci, domani mattina presto voglio una risposta».
L’indomani il ragazzo, molto a malincuore, comunica la decisione di partire per gli Usa. Tre anni piú tardi, Bruno è tornato in città e ha messo in piedi un’azienda che adesso funziona a gonfie vele. L’unico vero valore aggiunto di quella generazione.
Andare, o essere costretti a trasferirsi all’estero implica un’esperienza fondamentale che impone una maturazione impensabile tra le quattro mura domestiche, cullati e viziati da benessere e comodità. Significa essere costretti a confrontarsi con realtà culturalmente e socialmente diverse, ad acquisire un punto di vista meno provinciale, a imparare a fare conto sulle proprie forze e capacità. Durante questo percorso non può che crescere l’autostima e il senso dell’intraprendere a essa correlato. Ma se queste osservazioni rischiano di essere scontate tanto sono condivisibili, perché un genitore deve arrivare a minacciare di cambiare la serratura di casa per fare in modo che il figlio si possa salvare dalla mediocrità grigia del quotidiano imbottito di privilegi in cui si lascia vivere?
Naturalmente le responsabilità non vanno cercate solo nella generazione dei genitori: un fenomeno cosí articolato rimanda a una rete che comprende le omissioni dei figli, la disfunzionalità della scuola, la miopia delle istituzioni che governano e amministrano la nostra comunità.
Il problema è che gli unici ad avere una qualche coscienza di ciò sembrano proprio i genitori: quegli uomini e quelle donne che nell’immensa sala della fiera di Vicenza ancora a mezzanotte continuavano a parlare, chiedersi, ascoltare, cercare e trovare le parole per mettere a fuoco, dire e stemperare dubbi, inquietudini.
Nessun cambiamento sociale, tanto meno quello complesso di cui stiamo parlando, può sperare di essere condotto verso una piena maturità senza che vi sia, al fondo, un processo che porta a una presa di coscienza. Questo normalmente chiedo a un paziente la prima volta che lo incontro: non m’interessa tanto sapere del suo attuale disagio e delle radici prossime e remote del suo star male, quanto piuttosto della disponibilità a cambiare, magari anche solo un capello, la sua esistenza, qualsiasi sia la stratificazione di dolore da cui emerge.
Ed è, lo dice l’esperienza, di gran lunga la cosa piú difficile da ottenere da un individuo.
La famiglia si è fatta fragile, esattamente come il mondo che la circonda. Ogni tanto la politica si cimenta a parlare di aiuti, ma l’unico che riesce a pensare e a dire è il piú banale e inutile: una beneficenza economica direttamente proporzionale al numero di figli o al reddito.
Da decenni la politica non è riuscita a partorire nulla di diverso e meno umiliante della «cottimizzazione» della prole (di per sé agghiacciante).
Un pensiero progettuale dunque è necessario, ma prima di esprimere qualche idea a riguardo vorrei, senza ripetere ciò che autorevoli sociologi hanno descritto in questi ultimi quarant’anni, proporre qualche considerazione introduttiva.
Fino a che la famiglia ha dovuto funzionare come una agenzia che assicurava la sopravvivenza economica delle generazioni a venire, ha correttamente svolto il suo compito: era nella sua cultura, inscritto nel suo Dna. D’altra parte, l’idea di comunità è acquisizione recente, fino a pochi decenni fa era la rete familiare a surrogare ciò che la collettività sociale non era in grado di fornire.
La fragilità è emersa quando alla famiglia si è richiesto non piú soltanto di provvedere alla sopravvivenza dei figli, ma di educarli: non potevano piú bastare i soldi, la salute, gli studi, ma diventava fondamentale la costruzione delle fondamenta della comunicazione emotiva e dei legami affettivi. Esattamente ciò che per secoli era apparso del tutto opzionale.
Questa diversa e piú complessa aspettativa è maturata proprio quando la struttura organizzativa della famiglia è mutata: da una logica gerarchica (una piramide con al vertice il maschio anziano e alla base i bambini), a una orizzontale (con un potere comparabile di tutti i membri).
In questa complessa trasformazione, il benessere economico e la declinazione dei diritti individuali hanno indotto, piú di molti altri fattori, un’ancor piú profonda mutazione della struttura familiare. Non parlo di transizione in termini meramente organizzativi, ma soprattutto di alcune ricadute di quel soqquadro sul mondo relazionale.
Dibattito in Val d’Ossola, provincia con il piú alto numero di separazioni d’Italia. Fa freddo e piove da tre giorni. Da queste parti si lavora come due secoli fa, oggi però si fanno soldi, si costruiscono villette con tutti...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Prefazione all’edizione tascabile
- La gioia di educare
- Non siamo capaci di ascoltarli
- Voi, noi
- I figli non crescono piú
- Il libro
- L’autore
- Dello stesso autore
- Copyright