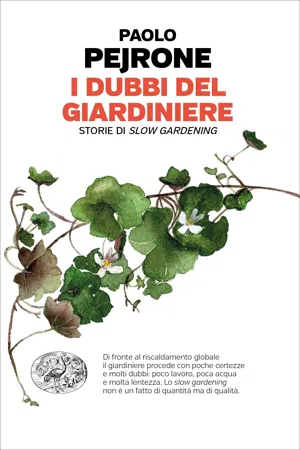![]()
![]()
Erbacce al posto dei prati, bordure miste che paiono torte multistrato, labirinti dove ci si sente piú sicuri quando si è persi piuttosto che ritrovati, orti senza ortolani né ortaggi, alberi da frutto condannati alla sterilità e cosí via. Come abbiamo già scritto e senza paura di ripeterci: nel giardino contemporaneo il gusto per l’inusuale rischia di prevaricare sulla stessa godibilità del posto, sulla sua semplice piacevolezza e bellezza, che mi paiono in fondo i veri motivi per i quali s’intraprende l’opera. Se architettura e botanica diventano una gara, spesso a rimetterci è la tanto auspicata sostenibilità, che nelle ricercatezze ben di rado riesce a trovare un valido sostegno.
Questo modo di intendere i giardini mi ricorda quel che capita nell’haute couture: ogni anno i limiti vanno superati, occorre sbalordire, anche a costo di cadere nel grottesco e soprattutto nell’inutile. Lascerei quest’idea ai vari Chelsea o Chaumont, con le loro alte missioni botaniche e architettoniche, con i loro peraltro interessanti giardini sperimentali. Nella vita di tutti i giorni piantare un giardino, almeno per me, ha ben poco dell’opera d’arte; è piuttosto un lavoro artigianale, non per forza stupefacente, non per forza nuovo, ma fatto in maniera corretta e capace, logico, con i piedi ben piantati per terra. Un lavoro capace di creare un’amicizia lunga una vita. Senza dimenticare che in giardino si è parte di un percorso di nascite, crescite, sviluppi, e morti: luoghi e combinazioni in cui l’effimero è già di per sé stesso sempre dietro l’angolo.
Evidentemente appartengo a un’altra epoca, nella quale ciò che contava era il «mestiere» e non tutto doveva per forza contenere una provocazione, un esempio o chissà quale messaggio. Le scelte semplici e razionali mantenevano un loro valore se le migliori per il posto; le «solite» piante andavano benissimo se garantivano un solido e gradevole futuro. Escluderle a priori, per ragioni di moda, di non sufficiente sofisticheria, di eccessiva popolarità mi pare in fondo un segno di gran debolezza, l’onnipresente timore di apparire scontati.
Il piccolo catalogo che segue, soltanto un esempio concreto e ragionato tra i tanti possibili, è un mix di vecchie e nuove proposte, di impellenti riscoperte e di inattesi acclimatamenti. Traghettare il giardino contemporaneo tra i flutti perigliosi di un clima in rapido e non favorevole mutamento è una responsabilità che ha bisogno di alleati fedeli, sui quali essere certi di potere contare. Piante pronte a tutto, tendenzialmente tolleranti di condizioni anche estreme, spesso rilevanti per il loro fogliame piú che per le fioriture: le paladine del giardino del XXI secolo sapranno, spero, (ri)educarci a un rapporto equilibrato e rispettoso verso l’ambiente che ci circonda.
![]()
Tra un dubbio e l’altro possiamo forse avere una certezza: il giardino «secco» sarà il nostro futuro. Un futuro assai prossimo, addirittura un presente. Altro che stravaganze per pionieri della botanica: ormai dovremmo tutti fare i conti con le evidenti bizzarrie del clima e abituarci a nuove piante, nuove estetiche, a modi nuovi di pensare e fare giardino.
Possibilmente evitiamo i fanatismi. Come tutte le grandi trasformazioni richiede tempo e una progressiva confidenza, meglio avanzare senza abiure improvvise o inutili prove di forza. Per non sbagliare, consiglio sempre piccoli passi e azioni inizialmente modeste. Anche là dove non abbonda l’umidità, ha ancora un senso coltivare una camelia o un’ortensia o un gruppetto di felci se possono farci felici. Tra il tutto e il niente stanno fortunatamente numerose vie di mezzo: l’importante è ridurre sprechi e insensatezze, allenandoci a pratiche virtuose e consapevoli e adattandoci alle caratteristiche del posto. Ben sapendo che innaffiature attente e distanziate saranno capaci di rendere le nostre piante piú forti e indipendenti, insieme ad altri semplici e caserecci stratagemmi: da un rigoroso drenaggio alla capiente «fossetta» costruita tutt’intorno per non disperdere l’acqua o alle spesse e soffici pacciamature.
Bisognerebbe preparare poco per volta il giardino ai tempi piú duri che verranno, sforzandoci di accrescerne l’autonomia e la capacità di sopportazione. Contemporaneamente perché non tentare qualche piccolo esperimento piú estremo, piantando là dove prevediamo di non dare neppure piú una goccia d’acqua nel giro di due o tre anni? A Revello è stato cosí dapprima per filliree e viburni tini, per corbezzoli e melograni, poi per i cisti e infine per phlomis e agapanti. Liberati finalmente dai vasi e piantati su una scarpata povera, rocciosa e ben drenata in pieno sud, hanno retto perfettamente il colpo. Tanto da indurmi a tentare ancora di piú e in posti ancora piú disagiati: negli ultimi anni decine e decine di cisti sono stati piantati nelle balze dell’uliveto e al piede del vecchio forte, in una zona detritica e riarsa dal sole. Insieme ai cisti ha conquistato nuovi spazi la Romneya coulteri, lontana cugina dei nostri papaveri proveniente dal «chaparral» della California. Nei giardini può diventare capricciosa: abituata com’è in natura a una vita di stenti, il troppo benessere (e soprattutto un drenaggio non perfetto) rischiano facilmente di ucciderla. O di renderla brutta di presenza e scombinata nel suo semplice portamento.
Qualche tempo fa mi è capitato di andare a visitare in Maremma, a Orbetello, il giardino di un appassionato che ha deciso di non irrigare piú le sue piante, un radicale e convinto applicatore dei principi del dry gardening. Osservare dal vivo permette di rendersi conto di come l’assenza di acqua (cosí come di qualsiasi aiuto o forzatura) incida sulla forma degli arbusti, nel bene e nel male. Per chi è abituato a vederle coltivate negli agi di un giardino o di un vivaio «tradizionali», molte piante mediterranee o comunque provenienti da ambienti secchi e poveri possono diventare quasi irriconoscibili. Una Romneya, proprio come un rosmarino o lo stesso cisto, mettono a nudo la loro vera natura, ben piú affascinante ed equilibrata, anche se meno vistosa e ridondante rispetto a quando crescono assuefatti alle ricchezze di terra, acqua e concimi dalle quali per istinto rifuggirebbero. Altre invece, Teucrium fruticans in testa, diventano facilmente scheletriche e quasi schematiche: non ci sono piú, paiono l’ombra di sé stesse, corrose dalla povertà e ridotte addirittura a un ricordo.
Siamo alle solite: per quanto selvatico e svezzato con grande sobrietà, ogni giardino ha bisogno del suo giardiniere, che sia padrone o professionista, appassionato o valido braccio per i lavori necessari di giorno in giorno, di mese in mese, di stagione in stagione. Un occhio attento, che sappia tirarsi indietro quando opportuno e viceversa intervenire quando necessario, sempre senza esagerare, dosando col contagocce sostegni e privazioni, può garantire crescite armoniche, equilibrate e uniformi. Il giardino non è natura e l’uomo non può e non deve abdicare alla sua essenziale ed esistenziale presenza...
![]()
Se si coltiva un giardino ben assolato, secco, pietroso e non troppo piccolo, i cisti possono diventare un Leitmotiv tra i piú piacevoli. Se poi non lo si coltiva affatto, lasciando andare le piante per conto loro vuoi per scelta o per necessità, sapranno regalare inaspettate soddisfazioni. Sono piante da abbandono, proprio come i rosmarini, le salvie, le phlomis, i teucri o le santoline, da metter giú e dimenticare (tutte piante che sarebbero molto gradevoli, sia nell’aspetto che nella felicità dell’insieme, se coltivate a gruppi e vicine).
Forse i primi due o tre anni bisognerà starci un po’ dietro, eliminando in primavera le erbacce finché la macchia non sarà abbastanza fitta da provvedere da sola o innaffiandoli d’estate, poco frequentemente e in abbondanza e mai con sistemi goccia a goccia. Dopodiché basta lasciar stare, meno si fa meglio è, anche se una leggerissima potatura all’inizio dell’autunno tiene le piante piú compatte, piene e pare ne favorisca la longevità. È questo infatti l’unico «difetto» dei cisti, crescono veloci e non sono eterni: i vent’anni possono considerarsi già un ragguardevole traguardo. D’altronde in natura sono abituati a occupare velocemente gli spazi azzerati dagli incendi, per poi abbandonare il campo quando lentischi, mirti e filliree riprendono il sopravvento. Con le punte tagliate, avendo l’accortezza di risalire fino a prendere un pezzetto del legno vecchio, si possono tentare tante nuove talee.
Anche i semi possono essere una buona strategia per prolungare la presenza dei cisti in giardino: germinano con facilità se li si sfrega energicamente in modo da intaccare il tegumento che li ricopre o, parola di Olivier Filippi che nel suo celebre vivaio vicino a Montpellier ne coltiva oltre duecento taxa, passandoli un attimo in forno. Sembrerà strano, ma è cosí che capita in natura: una leggera «tostatura» dovuta al calore del fuoco li predispone alla vita, una vita che almeno all’inizio s’avvantaggia della scarsità di competizione. È sufficiente andare sul litorale della Sardegna e vedere cosa capita nella tarda primavera, dopo gli incendi dell’estate precedente...
Questi sono divertimenti da giardiniere; chi invece desidera semplicemente arbusti forti, sempreverdi, con fioriture tra le piú belle verso aprile e maggio e a bassissima manutenzione può comprarne i piantini in vivaio. Sanno essere la gioia delle seconde case, dei giardini da weekend, quelli che non possono venire seguiti per settimane e addirittura stagioni intere. Non necessariamente giardini di mare: i cisti, se ben piantati, in terreni assolutamente drenati, ricchi di sassi e di sabbia, e in posizioni assolate, si rivelano assai piú resistenti ai freddi di quel che potremmo pensare. Ciò che il cisto detesta di piú sono i ristagni d’acqua.
Qui a Revello i cisti sono ormai una sperimentata e amatissima presenza. Un grande gruppo di Cistus x purpureus «Alan Fradd», a fiore bianco macchiato tra il bruno e il bordeaux, una delle cultivar piú belle a mio giudizio, cresce rigoglioso da anni al piede di una piccola falesia esposta a mezzogiorno. Visto il successo in questi ultimi tempi mi sono dato, come ricordato, a nuove piantagioni: a monte di un muretto a secco nell’uliveto e su una scarpata arida e sassosa che guarda il paese, tutte posizioni dove l’acqua non si ferma e sgronda via facilmente e velocemente. Posti che non sono stati complicati da individuare: di angoli poveri e degradati, erosi e roventi, dove difficilmente crescerebbe molto altro, il giardino abbonda.
Quanto al terriccio la grandissima parte dei cisti sopporta bene il calcare, chi piú chi meno: ad esempio il C. salvifolius, che ha fiori avorio a coppa ed è una delle specie piú resistenti alle ombre luminose, non ama gli eccessi; mentre il C. albidus, con foglie lanuginose e fiori rosa, è davvero di bocca buona. Altri, come il C. ladanifer, richiedono invece terreni leggermente acidi. Filippi consiglia di iniziare provando specie diverse, in modo da capire con precisione quelle che meglio si adattano al proprio posto, proprio come nel tempo ho fatto anche io tutto da solo: dopo poco piú di un anno dovrebbe essere già chiaro con quali non convenga insistere.
Curioso e imponente è il C. laurifolius, che può raggiungere anche i due metri e ha un tronco che con il tempo si sfoglia. Due soprattutto sono i suoi pregi: è uno dei piú resistenti al freddo, perché proviene dalle zone di montagna del Mediterraneo, e fiorisce in bianco tardivamente, verso maggio-giugno, dopo che per settimane le gemme rossastre e cerose hanno fatto bella mostra di sé. Sempre a detta di Filippi poi il C. x pulverulentus, rosa brillante e a portamento basso, ideale per tappezzare, è tra quelli che fiorisce piú a lungo, fino a luglio. Data la bellezza dei fiori dei cisti tentare di prolungare il piú possibile lo show è quasi un dovere per il giardiniere: tra le centinaia di possibilità la bulimia è un rischio concreto, ma non è il caso di preoccuparsi. Ci penseranno i cisti stessi a selezionarsi.
![]()
Nel cortile del Castello di Barbaresco, protetto dai muri della casa, assolatissimo e ben esposto a sud, cresce un piccolo ma esuberante maquis di gaure, nepete, lavande e perovskie. L’insieme, forte della sua consolidata tradizione mediterranea, pare trovarsi perfettamente a suo agio nelle terre asciutte e calcaree della Langa, adeguatamente alleggerite con consistenti apporti di sabbie drenanti. Le fioriture dirompenti e anarchiche scompaginano gli austeri rigori dell’architettura e l’effetto, grazie anche alla frenesia di api, farfalle & C., risulta attraente e pieno di vita. La gaura, che lí cresce in una varietà a portamento alto e con fiori bianchi che virano al rosa, molto simile alla specie botanica, quella delle praterie aride del Centro America, sovrasta leggera le masse grigie delle foglie e le spighe viola e blu.
Ormai iper-diffusa nei giardini, in quelli secchi ma anche là dove le umidità costanti la condannano a crescite insicure e stentate, la gaura è giustamente molto amata. Una vera manna anche per giardinieri alle prime armi, sia per le prolungate fioriture che per la risaputa semplicità di coltura. Che poi sia spesso adeguatamente proposta e piantata è tutt’altra questione e a mio giudizio non cosí facile: il troppo o il troppo poco sono sempre in agguato ed è breve il passo per risultati incerti e anche un po’ stucchevoli. Non di rado viene usata come mero riempitivo, senza far caso alla composizione, che è invece importante perché lo stacco eccessivo tra l’ariosità della gaura e la compattezza delle altre fioriture, cosí come tra altezze troppo diverse, può rendere il tutto poco attraente e armonico.
Ce lo insegnano bene i principî del prairie garden, un modo relativamente nuovo di fare giardino, che supera l’ormai abusata formula dei bordi misti infarciti di graminacee e propone combinazioni ben piú realistiche e spontanee. Le stesse che hanno reso i lavori di Nigel Dunnett conosciuti in tutto il mondo, da ultimo i celebri giardini del Barbican in quel di Londra. E che davvero rendono l’idea di una prateria fiorita cosí come si vede in natura, senza che le inevitabili contaminazioni e aggiunte del paesaggista tolgano alcunché alla leggerezza e sobrietà dell’insieme.
Quelle praterie che, per quanto riguarda la gaura, furono esplorate in lungo e in largo verso la metà dell’Ottocento dal botanico Ferdinand Lindheimer, di cui la specie porta il nome (Gaura lindheimeri o meglio, dopo gli ultimi e per nulla ben accolti arrovellamenti dei botanici, Oenothera lindheimeri). Tedesco di nascita, emigrato negli States dopo il fallimento della rivolta di Francoforte che si era opposta alle politiche del Metternich e all’assolutismo dei tempi, si stabilí in Texas. Da lí compí numerose spedizioni per conto dell’Università di Harvard ed è considerato, a ragione, il padre della botanica di quelle terre, scopritore di centinaia di nuove specie e creatore di un’importantissima collezione che personalmente coltivava nel suo giardino sulle rive del fiume Llano. Il suo nome riecheggia spesso nelle nomenclature scientifiche, non soltanto di piante, e la gaura è certamente una delle sue piú celebri scoperte.
È d’altronde una pianta utilissima, che rimane attraente per tutta l’estate proprio quando intorno il giardino vacilla sotto i colpi della canicola. Resiste in modo egregio al secco e al caldo, con i cespi di foglie allungate, talvolta sfumate di porpora e talvolta macchiate di scuro (non c’è da preoccuparsi, è fisiologico) e i panicoli di fiori che si aprono scalarmente fin all’autunno. Sono piante perenni, ma che non vivono a lungo: in compenso si riseminano con facilità, almeno le varietà non sterili, e anche le talee attecchiscono con successo. La G. l. «Whirling Butterflies», il cui nome dice già tutto, è forse la piú simile a quella che si trova in natura, alta fino al metro e con fiori bianchi che si tingono di rosa, ma è sterile e dunque particolarmente indicata là dove si tema l’invasione. Ci sono poi varietà a fiore rosa piú o meno intenso (che a me onestamente non riescono a piacere) e altre bianco puro, come la G. l. «Papillon» a portamento piú compatto.
Addirittura ricordo di aver visto una volta, ma di sfuggita per la fretta, una varietà abbastanza bassa e dal fiore candido con una gola leggermente verde, piantata in non ricordo quale aiuola di Torino. Nei cataloghi non ce n’è traccia, sarà stato sogno o realtà? Eventuali testimoni sono i benvenuti...
![]()
C’ero già passato accanto d’estate e mi aveva colpito prima di tutto il profumo: di rosmarino arrostito dal sole e dal caldo scottante del muro, un brutto e altrimenti fastidioso muretto in cemento lungo la strada che porta a Barbaresco (evidentemente una zona, quest’ultima, di rivelazioni botaniche e giardiniere, per me e non soltanto...). I rosmarini l’avevano coperto ormai generosamente, per decine e decine di metri, avvolgendolo con la loro trama fitta. Un esteso siparietto che assolveva egregiamente alla funzione, con tanto zelo e diligenza da non potere che rimanerne impressionati, un vero festival di inchini, strisciamenti e prostrature... La vigna tutt’intorno, qualche fico e dei gruppi di iris (che non ricordo piú se immaginati o reali) reggevano il gioco, evocando alla perfezione una mediterraneità che nel nostro profondo Piemonte è una conquista recente. D’altronde quelle terre povere e dure si prestano bene, complici gli inverni sempre piú miti e a patto di un attento drenaggio che sappia ovviare alle pesanti asfitticità delle argille.
Fino a una ottantina di anni fa da noi il rosmarino veniva piantato e cresciuto solo negli anfratti piú temperati: il bravo giardiniere ne coltivava sempre due o tre vasi, riparati durante i mesi freddi. Il rosmarino era sí una pianta diffusissima, ma mai in quantità: ciascuno ne aveva quel poco che bastava. Un continuo alleggerimento a uso della cucina riusciva poi a impedirne l’eccessiva lignificazione. Ai nostri giorni, dall’inizio del millennio e in pieno Effetto serra, non c’è piú bisogno di grandi cautele: la siccità e quel famoso grado in piú hanno le loro immediate conseguenze. Come i rosmarini, sono tantissime le specie che approfittano e cavalcano questo mondo tiepido e purtroppo spesso fatto di eccessi, vittima di picchi violenti, ormai libere dal complesso di dover essere utili. Le piante della macchia mediterranea, un elegante e profumato consesso fatto di filliree e corbezzoli, di lauri, ligustri, lecci, sughere, cipressi, alterni e tanti altri, sono a mio giudizio i migliori compagni del nuovo giardino.
Ben vengano dunque i muri trapuntati di rosmarino: il binomio sa di combinazione riuscita, il successo è palese e corroborato ormai da anni di tentativi e perfezionamenti. Nei cataloghi le varietà a portamento prostrato sono sempre piú numerose: dall’intramontabile Rosmarinus officinalis «Boule», che rimane uno dei miei preferiti, scapigliato e ordinato allo stesso tempo, gradevolissimo compagno di tanti giardini di bocca buona e di poca acqua, al R. o. «Mac Connel’s Blue» a foglia piú larga. Dal californiano R. o. «Lockwood de Forest», vigorosissimo e con grandi fiori, al R. o. «Punta di Cannelle», un po’ meno resistente al freddo ma con rami che ricadono a cascata. I loro fiori color del mare, tra il blu della genziana e quello del Lithospermum, anche se poco vistosi sono tra i primi a rompere il fronte delle tonalità incolori dell’inverno. Del giardiniere poi potrebbe...