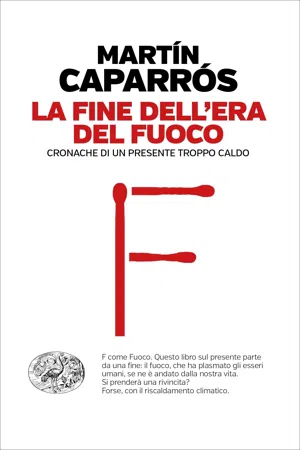![]()
Quegli uomini che avevano disperatamente bisogno del fuoco, che non erano niente senza il fuoco, s’inventarono paradisi ignifughi, rifugi dove le fiamme non arrivavano, pura nuvola e spirito molto lontano dalle fiamme dell’inferno. Ora che viviamo in un mondo senza fuochi, ciascuno è il paradiso di se stesso; l’inferno, com’è noto, sono gli altri.
![]()
Li immagino nei loro piccoli antri, con la barba incolta, gli occhi cisposi, mentre bevono succhi rigorosamente bio o mentre sbocconcellano pizze rafferme, la musica piú cool di Spotify, il pavimento un po’ sporco, lí a cercare di immaginare la Prossima Grande Cosa. Ma so che è puro pregiudizio: alcuni la cercano nelle strade piú eleganti o piú squallide delle loro ricche città, altri nei boschi e nelle montagne e nelle spiagge tropicali, altri sulla sedia di un ufficio pubblico dove sognano di non doversi sedere mai piú. In ogni caso, al di là delle piccole differenze, l’idea che fa perdere il sonno sembra essere la stessa: di cosa li potrei convincere? Cosa gli posso dare che ancora non hanno?
Tra le cento start up europee analizzate dalla rivista «Wired», le piú «hot» del 2017, ci sono una banca virtuale che permette ai bambini di otto anni di avere carte di credito associate al loro cellulare, una dozzina e mezza che promettono di farti arrivare a casa in meno di due ore verdure biologiche o vini altrettanto bio o sushi o fiorellini o qualsiasi altra cosa – senza che tu debba fare lo sforzo di uscire –, una dozzina che ti permette di vendere o affittare o condividere una qualche forma di veicolo con o senza autista o proprietario, una mezza dozzina che ti offre la possibilità di comprare piú a buon mercato o in maniera piú attenta o piú vicino a te, un’altra mezza che ti propone modi sempre piú sofisticati di affittare o condividere abitazioni, ancora un’altra mezza che concentra offerte e domande di lavoro – e una che usa big data perché sia il sistema a scegliere a chi darlo –, due o tre che ti diagnosticano malattie in tre clic, altrettante che ti fanno fare ginnastica per evitarle, altre che aiutano le piccole attività a migliorare la propria contabilità o il loro posizionamento su Google, giochi vari, un editor di foto, un aspirante WhatsApp con un aspetto piú intrigante, un consulente finanziario, un programma per migliorare l’efficacia delle pubblicità in rete, un programma per bloccare le pubblicità in rete, un altro per predire cosa compreranno tizio o caio, uno per trasformare il tuo cellulare nella tua chiave di casa, un altro per migliorare la resa delle coltivazioni biologiche, un altro per migliorare il rendimento degli investimenti in borsa, un altro per migliorare l’efficacia delle comunicazioni tra superiori e subordinati, due o tre per trovare l’amore – o quantomeno per farlo, e qualcuno, di sicuro, per migliorarne la qualità.
E la domanda iniziale sarebbe stata la stessa in ogni caso: di cosa potrei convincerli? I giovani startupper sognano di essere i prossimi Jobs, Zuckerberg, Bezos. Sono, di già, l’avanguardia di questo sistema che consiste nel creare nuovi appetiti. Dico, credo: il tizio che ha inventato l’ascensore aveva passato diversi anni a salire le scale; quello che ha inventato Twitter deve aver pensato che forse poteva persuadere milioni di persone a dire quello che non dicevano mai, sempre a patto di usare 140 caratteri. Dico, credo: che le invenzioni cercavano un modo per soddisfare le nostre domande; ora invece pensano a quali ci possono imporre. Non si inventa piú un oggetto o un metodo; si inventa un bisogno. Tutto consiste, in sintesi, nel farsi venire l’idea che nessun altro ha mai avuto per rendere indispensabile qualcosa di cui la settimana prima non sentivi il bisogno – e offrirti il modo di ottenerla in mezz’ora.
In un mondo cosí pieno, la chiave della ricchezza consiste nel trovare un nuovo buco. Un po’ piú in là, nel mondo che è pieno di buchi, la povertà continua a cercare di riempire quelli che già esistono. Sono due mondi, sempre piú vicini, piú lontani: si guardano, si minacciano, non si trovano su Facebook; qualcuno si sorprende quando si scontrano.
![]()
Ci ho pensato ieri, quasi senza pensarci, quando ho attaccato alla parete del bagno di casa un sottile gancetto autoadesivo di pura latta: non avevo la piú pallida idea – né la piú pallida possibilità di farmi un’idea – della sua provenienza. Non avevo modo di sapere chi l’avesse fatto, dove fosse stato fatto, come fosse il lavoro, quale il suo percorso da un qualche remoto angolo della Cina fino al cinese all’angolo di casa mia. Come quasi tutto quello che usiamo, anche il gancetto arrivava dal nulla – e nemmeno ci sorprende.
Per millenni, tutto ciò che possedevamo aveva una storia – piú o meno – rintracciabile. Il proprietario di un martello sapeva che l’aveva costruito Lope, quello del laboratorio nell’altro isolato, il figlio di Trini, la cugina dello zio Pedro. Adesso no – e poi possediamo cosí tante cose, che se ne conoscessimo la storia non avremmo tempo per nient’altro.
Viviamo nella civiltà delle migliaia di cose. Negli Stati Uniti – dove fanno questi calcoli – uno studio recente dice che in una casa media ci sono trecentomila cose, «dalle clip agli assi da stiro». In Inghilterra, in media, un bambino di dieci anni possiede 238 giocattoli, pur giocando soltanto con dieci o dodici. E la ricerca di una compagnia assicurativa inglese dice che trascorriamo una media di dieci minuti al giorno a cercare quello che abbiamo perso: in una vita possono essere duecento giorni persi a cercare. Quasi niente, se paragonati ai duemila che passiamo a comprare.
Abbiamo migliaia di cose e ci sono miliardi di persone che non ne possiedono quasi: noi, il 12 per cento della popolazione che vive in Europa e negli Stati Uniti, consumiamo il 60 per cento dei beni del mondo – mangiamo il mondo –, mentre il 33 per cento piú povero – africani, asiatici, sudamericani – consuma il 3 per cento. Qualche anno fa sono andato in un angolo dell’Amazzonia per scrivere del brasiliano Movimento dei Senza Terra. Una donna, Gorette, mi prestò la sua capanna e io pensai che la migliore descrizione della povertà fosse raccontare la mancanza: «Nella capanna di Gorette ci sono un machete, 4 piatti di latta, 3 bicchieri, 5 cucchiai, 2 casseruole di ottone, 2 amache a rete, un secchio con l’acqua, 3 lattine di latte in polvere zuccherato, sale e latte in polvere, una latta d’olio con l’olio, 2 latte d’olio vuote, 3 asciugamanini, una scatola di cartone con ben poca roba, 2 calendari di qualche negozio con dei paesaggi, un pezzo di specchio, 2 spazzolini da denti, un cucchiaio di legno, mezzo sacchetto di riso, una radio che non capta quasi nulla, 2 giornali del Movimento, il quaderno di scuola, un secchio di plastica per portare l’acqua dal pozzo, una bacinella di plastica per lavare i piatti e una bambola di pezza con un vestito rosso e una strana cuffia. Questo è quello che possiede, oltre a 3 tronchi su cui sedersi, un paio di hawaiane, una lampada a cherosene ed esattamente nient’altro».
È cosí che abbiamo vissuto, per millenni: con poche cose strettamente necessarie, procurateci faticosamente, che conoscevamo e apprezzavamo. Adesso niente significa niente: è tutto usa e getta, sostituibile, non vale la pena trattare nulla con cura o ripararla perché è piú facile e piú economico comprarne un’altra. Inoltre, niente ci fa piú piacere che comprarne un’altra.
Contro questa contaminazione, ultimamente sono spuntati i «minimalisti»: persone che dichiarano che non abbiamo bisogno di tutta questa spazzatura per vivere bene e che la saggezza consiste nel non possederla. La cosa paradossale è che il sistema economico mondiale ha bisogno del nostro bisogno di sempre piú cose – perché vive della loro fabbricazione. Sono le delizie del capitalismo globale, che è come un aereo: se non romba a 800 chilometri all’ora, cade. Se dicessimo basta, se organizzassimo un uso razionale delle risorse, milioni di persone – operai, imprenditori, impiegati, imprenditori, venditori, imprenditori – avrebbero grossi problemi. O forse inventeremmo qualcosa: a volte capita.
![]()
L’intelligenza è partita all’attacco. Viviamo in un mondo in cui quasi tutto sembra essere intelligente: i telefoni, le case, le macchine, i forni, persino dio – o quantomeno alcuni. Sempre che si stia parlando, ovvio, di intelligenza artificiale. La piú naturale, la piú intrasferibile delle qualità umane – l’intelligenza – ultimamente è stata trasformata in un artificio che cerchiamo di associare a qualsiasi cosa. Letteralmente: a qualsiasi cosa. Adesso, per esempio, ai pigiami.
Un’azienda americana, la Under Armour, ha appena lanciato sul mercato i suoi «pigiami intelligenti»: dicono che siano una creazione di Tom Brady, la grande star del football americano e marito di Gisele Bündchen, che ha scoperto che i raggi infrarossi inviati dalla bioceramica che usava per disinfiammare e rilassare i muscoli lo aiutavano anche a dormire meglio. L’azienda è allora riuscita a miscelare un gel di quella bioceramica nel tessuto dei suoi pigiami, rendendoli confortevoli e, pare, intelligenti.
O non tanto, ma quel che conta è l’intenzione: vogliamo controllare anche quello che facciamo quando non facciamo niente che possiamo controllare. Il sonno è, in tal senso, una delle ultime frontiere. E in questi tempi ossessionati dai corpi – i propri, gli altrui, quelli che non si sa – la scienza e la tecnica del sonno occupano sempre piú spazi e persone, producono sempre nuovi appetiti.
Poco tempo fa il «New York Times» ha pubblicato un articolo dal titolo Il sonno è il nuovo status symbol – e menzionava le ricerche dei migliori laboratori americani, le invenzioni delle aziende piú coraggiose. Anche nel sonno – in quello perso, nella sua ricerca – ci sono tonnellate di denaro. E il pigiama intelligente non è, ovviamente, l’unico a volerne approfittare. L’industria del sonno, fino a poco tempo fa dominata da materassai ottocenteschi con una patina di modernità e pastiglie che assomigliavano troppo alle temibili droghe, si è diversificata in rami e rametti.
Ormai esistono cuscini intelligenti quasi quanto il pigiama, lampade che ti attivano la melatonina, cuffie che ti resettano le onde cerebrali, musiche che ti cullano come una mamma ma che sono molto piú pazienti, app che vegliano sul tuo sonno e lo interrompono quando gli pare o lo proteggono quando gli pare e alla fine ti dicono com’è andata e cosa puoi fare per migliorare: per diventare un trionfatore del sonno.
Perché, nonostante tutto, continuiamo a ignorare. Il sonno è, sia chiaro, una strana frontiera. Non sappiamo molto di cosa succede lí: accettavamo – finora accettavamo – che fosse un territorio misterioso, un posto in cui stiamo e non stiamo e siamo e non siamo. Conosciamo, questo sí, i suoi risultati, i suoi effetti: sappiamo che non è facile dormire bene e che, quando lo facciamo, siamo diversi. Lo sanno anche i datori di lavoro: un dipendente che ha dormito male è un dipendente che lavora male, ecco perché ai capi del personale interessa trovare modi per migliorare il sonno dei loro lavoratori.
E per questo pagano, per esempio, una Fiera del Sonno come quella che ha organizzato per LinkedIn a New York una signora, Nancy Rothstein, che si presenta come «ambasciatrice del sonno». «Se il sonno è stato in grado di diventare il nuovo sesso, come dieci anni fa aveva proclamato Marian Salzman, talent scout di tendenze e dirigente di Havas North America, oggi è una misura del successo – un’abilità da coltivare e curare – che moltiplica il potenziale umano e prolunga le nostre vite», ha scritto sul «Times» Penelope Green.
È vero che in inglese, perlomeno, le parole «sonno», sleep, e «sogno», dream, sono chiaramente diverse. Ma in spagnolo no, sueño sta sia per «sonno» sia per «sogno», e che oggi il sueño di molti sia non perdere il sueño la dice lunga sui tristi sueños dei nostri tempi.
![]()
Hai dormito. Ti svegli, grugnisci, vai fino in bagno, ti guardi allo specchio, vedi quello che non vorresti e lui ti rimprovera. Ci sono specchi e specchi; questo, se l’avessi nel bagno di casa tua, ti direbbe che avresti dovuto evitare quei due ultimi gin tonic e che il salame è stato un di piú: che lo indicano i livelli di alcol e di colesterolo e di lipidi nel tuo corpo. Questo specchio è un nemico travestito da amico – o viceversa.
Viviamo nella cultura del guardarci. Ora ci riflettiamo, ci contempliamo di continuo, ci fotografiamo, ma per millenni gli uomini non si sono visti: gli specchi sono un’invenzione quasi recente. Agli inizi erano di rame o di pietra – e mostravano molto poco. Gli specchi di vetro spuntarono negli anni di Cristo: in questo nessuno ci dovrebbe vedere piú che una coincidenza. E da allora, per molti secoli, sono stati un lusso dei ricchi. Gli altri non ne sapevano molto: al massimo si erano visti la faccia riflessa in qualche ruscello, in una pentola, su un gioiello di qualcun altro.
In questo mondo del guardarsi è strano immaginare una vita senza vedersi, senza sapersi: senza la consapevolezza del proprio aspetto. È stato cosí fino a un secolo fa, quando hanno iniziato a esserci specchi dappertutto. Da allora, sono diventati un modo per distruggere le illusioni, per non credere in se stessi, per chiedere alla realtà una conferma o una smentita: specchio, specchio delle mie brame.
Ma, al di là di queste incredulità, è sempre stato chiaro che lo specchio era una superficie pensata per vedere superfici: paradigma del superficiale. Finora. Ben presto la parola «specchio» designerà un’altra cosa. Ecco perché, com’è inevitabile di questi tempi, bisognerà aggiungergli la parola «intelligente». Sebbene alcuni diranno che «specchio intelligente» è un ossimoro: che uno specchio è stupido, che mostra soltanto quello che gli mostriamo. Non piú: ora guarderà a fondo.
Lo specchio intelligente è il prodotto di un gruppo di ricercatori pagati dall’Europa e chiamato Semeoticons, che da anni sta lavorando a Pisa. È una superficie riflettente in cui è nascosta una grande quantità di videocamere e sensori progettati per analizzare il flusso sanguigno, l’ossigenazione, il grasso sottocutaneo, le condizioni della pelle – tra le altre cose. Attraverso tutti questi dati, ti informa sul tuo stato generale, ti avvisa se c’è qualche problema cardiovascolare, ti consiglia di andare a fare ginnastica o di startene un po’ tranquillo, se è necessario. Non ti fornisce soltanto informazioni sullo stato – sempre – preoccupante del tuo corpo: ti dice anche cosa ne devi fare, del corpo.
Lo specchio intelligente di Semeoticons è in fase di sperimentazione; è un segno dei tempi. Sarà uno di quei poliziotti della vita a cui ultimamente siamo tanto grati: controllo sociale, folle in attesa di essere tenute d’occhio nel modo piú efficace possibile.
Lo specchio è sempre stato uno strumento per «monitorarsi» – da ben prima che esistesse la parola «monitorare» – dall’esterno: adesso la prepotenza della tecnologia fa sí che lo stesso strumento cerchi di monitorarci dall’interno. Le macchine, che se ne stavano fuori, all’esterno, iniziano a farsi strada verso l’interno, il nostro interno, e pensiamo sempre di piú che il loro posto sarà anche lí, e vengono sempre piú pensate per stare lí.
È un’altra tappa del trionfo della macchina: l’idea che tutti siamo macchine e che, quindi, i nostri errori si possano correggere con la giusta macchina – meglio ancora, ovvio, se si possono prevenire. Saremo l’elemento base per queste macchine che ci diranno cosa fare e, soprattutto, cosa non fare; macchine che ci porteranno a modulare i nostri comportamenti a seconda delle loro letture e delle loro analisi e dei loro algoritmi su dove sta il bene e dove sta il male. In cambio, ovviamente, ci promettono un po’ di vita in piú e – il dottor Faust già lo sapeva – in cambio di quel po’ siamo capaci di concedergli tutto.
![]()
Non albeggiamo, è evidente: siamo una cultura che ha abbandonato l’alba. Questa frase, insistente, mi martella la testa da giorni e giorni: siamo una cultura che ha abbandonato l’alba.
Non so se l’idea si possa sviluppare piú di tanto. È palese che si tratta di una sciocchezza: con tutti i problemi seri che hanno bisogno e meritano la nostra attenzione, a chi può interessare. E, come se non bastasse, incombe, spietato, il pericolo di cadere nella metafora da due soldi o in un inutile giochino di parole: che non guardiamo piú l’inizio dei giorni, che non ci importano piú gli inizi, che non ci svegliamo, che ci sentiamo piú vicini al tramonto – e altre idiozie del genere. E non si tratta di quello; è qualcosa di molto piú concreto e piú reale: la nostra cultura non considera l’aurora parte dei suoi giorni.
In senso strettamente letterale: le nostre giornate iniziano quando è già giorno. Ci alziamo quando c’è luce nel mondo. È, piú che altro, un effetto secondario dell’elettricità. Per millenni gli uomini hanno vissuto al ritmo del sole: di notte era tutto piú difficile e illuminarsi era un invidiato privilegio di pochi. Ai tempi le persone si svegliavano alle prime luci dell’alba – o un po’ prima, per approfittarne – e andavano a letto poco dopo le ultime.
La diffusione della luce elettrica ha cambiato queste abitudini: ora possiamo illuminare quando vogliamo e possiamo inventarci orari e possiamo consacrare la notte come spazio piú ambito, il trofeo del nostro trionfo sulla natura. La luce del giorno serve a lavorare – a consegnare la forza lavoro in cambio dei mezzi per riprodurla – e la notte a divertirsi; il giorno non ci appartiene, mentre la notte diventa nostra, è una ricompensa. E in questa conquista della notte ci siamo persi l’alba.
È strano, quasi alieno; la vediamo soltanto se non riusciamo a dormire o se siamo insonni o in viaggio o per una malattia o, piú di frequente, per un gradevole eccesso: alla fine di una serata di bagordi o grazie ad amori cosí felicemente lunghi che arrivi a vedere spuntare il giorno. È un momento straordinario nel senso piú stretto del termine: spezza la forma ormai accettata del tempo, quella data per buona.
Anche se è vero che viviamo nelle città, montagne di cemento dove diventa difficile vedere l’alba o il tramonto: dove tutto è strutturato perché i fenomeni naturali si intromettano il meno possibile – e si vedano il meno possibile. Ed è vero che l’alba ha perso gran parte del suo spazio da oltre duemila anni, quando i romani hanno stabilito questo orario per cui i giorni non iniziano quando iniziano bensí in mezzo alla notte – e questo ha tolto all’alba la forza di essere una vera e propria ora zero, l’ora dell’inizio.
E pur tuttavia, il fenomeno è piú ampio: non riteniamo che vedere albeggiare rientri nelle nostre abituali attività. Mi dispiace...