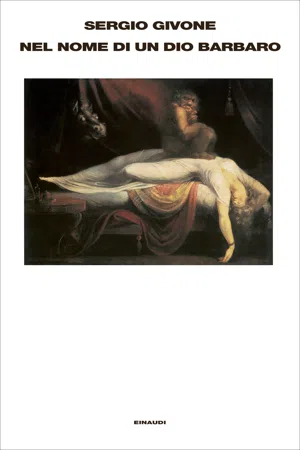![]()
Rigomago, 12-13 febbraio 1921
E anch’io mi inchino a voi, criatüri, creature. Io, che voi chiamate Fradèl, vi ho voluto con me stasera. E chi se no?
La cena è finita. Ci siamo alzati da tavola qualche minuto fa.
– Che ore sono?
– Quasi mezzanotte.
Lo stupore di Dolze Maman è commovente. Stella dice qualcosa del tipo: «È volato il tempo!», Surèla annuisce, e:
– Cosí è la vita... il quasi-niente della vita, – aggiunge. – Perciò siamo stati bene.
Vado verso la finestra. Scosto la tenda.
– Che notte sarebbe questa per le anatre! Anzi, sapete cosa vi dico? Ci vado. Se qualcuno vuole venire con me...
So che nessuno lo vorrà. Infatti.
– Voi però promettetemi che resterete qui a dormire. È tutto pronto. Vero? Resterete...
È un ordine. O forse un’implorazione. Neppure io so cos’è. State certi: non turberò i vostri sogni. Ma voi sognateli ancora una volta e sognateli nella mia casa. Cosí, forse, verranno anche da me e mi faranno compagnia questa notte. Il viatico che cerco. Dio mio... Che sia già impazzimento, questo? No. Io so per certo che chi è pronto a morire, e lo è davvero, viene visitato dai sogni degli altri – lui, che sta per diventare nessuno e ognuno.
Ma io, lo sono, io? – pronto a morire, intendo.
La vestizione del cacciatore è semplice. Di lana, la migliore, purissima, il sotto. Di fustagno, il sopra. Cappello, giberna, fucile. Mi affaccio sulla sala da pranzo.
– Oh...
– Ma dove...
Gliel’avevo detto che sarei andato a cacciare le anatre. Perché adesso fanno quella faccia?
– Buonanotte.
Mi guardano increduli. Io sono sulla porta. Surèla mi raggiunge.
– Cerca di tornare prima che faccia chiaro.
– E tu va’ subito a dormire. Sei stanca.
– Abbracciami.
– Non fare la bambina.
Però le dò un bacio. Sento la sua mano scorrere sulla mia giacca e arrestarsi non appena incontra il dorso duro dei quadernetti che ho deciso di portare con me. Lei sa che cosa ci scrivo, nei miei (o dovrei dire vostri?) quaderni. Perciò mi guarda stupita. Le balena negli occhi una domanda. Ma si dà la risposta da sé, una qualsiasi. E sbagliata... Addio, sorellina. Non mi accorgo della porta che si chiude alle mie spalle. In caso contrario, sarei tornato. Per scrivere qualcosa sul vetro della finestra col dito. Sarebbe stato leggibile, poi, il mio messaggio? Ma lei dev’essere rimasta lí, a spiarmi. A spiarmi? Neanche fossi un estraneo.
O lo sono, invece... Mi chiedo se questa che calpesto sarà l’ultima neve. Mi dico: l’ultima neve, l’ultima neve. Il suono di queste parole è dolce, ma il significato... Sfido chiunque a trovarlo. «O gent», urlo all’indirizzo di una donna che da una finestra ha rovesciato il pitale sulla strada e per un pelo, ma proprio per un pelo, non su di me. «Saría custa l’ura», mi sento rinfacciare, e penso che anche lei ha le sue buone ragioni. Anch’io ho le mie, però. Comunque, meglio scostarsi dai muri. Qui. In mezzo alla strada. Si vede anche meglio e non c’è rischio d’inciampare. Purché non sia venuto in mente a qualcun altro d’andare alle lame nel bosco della Partecipanza... Quello stagno è mio! Stasera, almeno. Sia come sia. È da lí che passa la mia strada: attraverso la paura e il buio. Il mondo per me si è oscurato. Ma c’è la luna. Chiara sulla campagna, lucente sulla brina, bella ovunque – anche fra vetro e persiana di quella finestra sgangherata, forse perfino al di là, a illuminare un pagliericcio di miseria e di delizia. Oscurato, il mondo, per una distrazione, per uno scherzo del destino. Ma oscurato, c’è poco da fare – e la luna, la luna è al servizio dell’ombra che ti segue. Avanti, allora.
E questo? Sembra che sia la banderuola del campanile di Sampedarmàr. La banderuola e la croce. Ma che idea... No, forse è la murícc, è il gufo. La banderuola, la croce e la civetta. Qualcosa vorrà pur dire. Ma che cosa? «Eilà, giuvantú». Giocano tra loro, si direbbe. E di me gliene importa? Un serpente mi sale dallo stomaco alla gola, vorrei fargli sapere, ai tre. La banderuola, la croce e la civetta.
Passo una mano sugli occhi. Attraversati da luce tremula. Come ne sgorgassero lacrime. Eppure non mi sono accorto di aver pianto. Surèla, e voi tutti: Stella, Dolze Maman, Nazareno, Viotto... Iutèmi. Aiutatemi. Ma come, se i vostri volti sono imprigionati in un cristallo di ghiaccio? Lacrime roventi ci vorrebbero, per scioglierlo. Eppure, se ciò accadesse, che ne sarebbe di voi? Dissolti, i vostri volti. Per sempre.
Perciò la mia pena mi è cara. Vorrei farla tacere. Ma nel momento in cui tacerà, chi mi parlerà di voi? E voi, come potrete parlarmi?
C’è un tiglio sulla strada. Giusto fra le ultime case e la campagna. Dove si comincia a salire. Ma appena appena, tanto che uno neanche se n’accorge. E c’è anche una fontana. Al tiglio e alla fontana sono legati i miei primi ricordi. Anche gli ultimi? Che idea... E se la fontana è gelata, se il tiglio è scheletrito, da dove questo risuonare di acque, questo frusciare di foglie, dove l’usignolo e l’allodola, dove la gioia, dove la pace? Sempre lí, se Dio vuole.
Il cappello... Forse me l’ha strappato una frustatina di quest’aria fredda e nervosa. O forse è rimasto impigliato nella rama di un gelso. Ma non torno a riprendermelo. No, indietro non torno.
Il piede cerca la neve. Ma, dure come pietre, zolle scoperte lo urtano. Tuttavia non sarò arrivato se non quando, voltandomi, non vedrò piú né case né campanili né torri.
Ora. Lo stagno, il capanno. Non c’è nessuno. Il cielo sia lodato.
Non so come uscirne. Ma qui dovevo venire. E qui sono. Le nostre gioie, le nostre pene, tutto è come un gioco d’un fuoco fatuo. Apro il primo quaderno e lo sfoglio, anche se la luce è poca, troppo poca, per leggere.
Contiene la storia di Dolze Maman, che solo alla fine sarà Dolze Maman. Prima e durante: Vivi, diminutivo di Virginia. Che per me e per tutti noi lei non sia Vivi, che importa?
L’isola della vita
«Come un estraneo son venuto, come un estraneo riparto».
C’è un punto di svolta, nella storia di Vivi che diventerà Dolze Maman, o di Dolze Maman che era Vivi. Da lí bisogna partire. E cioè dal giorno in cui, 28 settembre 1901, sul «Sunday Times» apparve il seguente annuncio:
THE LIFE’S ISLAND. We are a normal family
we are going to buy an island
and are looking for a complete community.
Please send a note to Llwynteg Farm,
Pentregat, Llandysul...
Il giorno dopo una copia del quotidiano era già sulla scrivania di Ettore Mella. Il quale, letto l’annuncio, lo sottolinea con penna rossa, ci fa un bel cerchio intorno, stacca la pagina su cui è stampato e diligentemente la inserisce in un faldone, rubricandola alla voce «Chimere, miraggi, sogni», già piuttosto corposa. Riprende a sfogliare quello e poi altri giornali e di tanto in tanto procede alla stessa operazione: sottolinea, stacca la pagina, la inserisce, e cosí via, senza particolare impegno ma neanche con fastidio. Diligentemente, per l’appunto. Ma qualcosa gli dev’esser passato per la testa. Si alza, recupera il faldone, cerca la pagina del «Sunday Times». La estrae, poi, dopo essersi messo a sedere, la copia con la sua bella grafia ariosa su un pezzetto di carta che infila nel portafoglio. Resta con gli occhi a lungo sull’annuncio e finalmente lo rimette al suo posto.
Qualche parola di spiegazione a questo punto ci vuole. Per dire che Ettore Mella è un Mella autentico, l’ultimo della dinastia dei lanieri e dunque l’erede. Infatti lo troviamo nel suo ufficio, al primo piano della palazzina appena costruita in stile floreale e annessa alla vecchia fabbrica, tanto severa quanto maestosa, che si trova in una conca delle prealpi fra Cossato e Biella. Ufficio per la verità modesto, a differenza di quello del padre, Adone Mella, che è dirimpetto al suo, come modesto è stato finora il curriculum del giovane Ettore. Poco portato agli studi, ciò viene imputato dalla madre a una sensibilità fuori dell’ordinario. Infatti è autore di versi molto apprezzati dalla piccola corte raccolta intorno alla signora – «Saranno gli altri a studiare lui», esclamerà un giorno la signora Mella dopo una pubblica lettura dei medesimi. Piú prosaico, e anche piú realista, il padre attende, pazientemente attende, poiché nel corso delle cose, e in nient’altro, spera. Ettore compie alcuni viaggi in Italia e in Francia («affinché cominci a far esperienza del mondo») accompagnato da don Eusebio Randazzo, in cui la madre ripone massima fiducia (e anche il padre, che dopo averlo preso da parte lo ha invitato a chiudere un occhio di tanto in tanto: «Deve diventare uomo, Lei capisce, don Randazzo», e don Randazzo, con cristiana rassegnazione: «Non sempre la salute del corpo e la salute dell’anima coincidono»).
Viene anche mandato, l’erede, in Inghilterra, a Cardiff, ma torna dopo pochi mesi affermando che «non hanno piú niente da insegnarci, gli inglesi, in fatto di tessitura», e questo se non altro gratifica il padre, che vede qualche segnale di crescita nel rampollo. In compenso la produzione poetica di Ettore Mella, come don Randazzo non mancherà di far notare alla madre, e la madre alle amiche, e le amiche a don Randazzo (il solo a non esserne avvertito è il diretto interessato), acquista cadenze pre-raffaellite e neogotiche e post-romantiche di grande afflato religioso. Ettore si sente in dovere di portare il suo cuore e il suo spirito a quelle sublimità, dopo averle poetate.
– Soffre molto. Moltissimo, – dice la madre al padre.
– Bene. A quell’età soffrire fa solo bene, – dice il padre alla madre.
– Tu la prendi alla leggera, ma nostro figlio è una natura superiore.
– Purtroppo.
– Una grande inquietudine lo tormenta.
– Inquietudine, dici...
Ripete quella parola, sul cui significato è incerto, ma che volentieri toglierebbe dal dizionario: – Per ragioni umanitarie, – esclama, ruggendo.
Gli avessero detto che suo figlio ha il mal francese, non dispererebbe di lui come invece dispera. Figuriamoci quando la moglie, persuasa di poter aprire un varco nella corazza di quell’insensibile mercante, passa a illustrare nei dettagli le sofferenze del giovane Ettore e:
– Trascorre ore e ore nel mezzo della notte con gli occhi fissi nel buio, – racconta, – poi, le mani madide di sudore, la fronte diaccia, quando l’angoscia non è piú sostenibile, – continua, e il marito lí che la guarda sempre piú perplesso, – si mette a sedere sul letto e: «Chi sono io?», gli esce dalla gola come un grido, un urlo, e non c’è chi gli risponda, non c’è perché non ci può essere, né in cielo né in terra –. Ora è lei, la signora, quasi a gridare e poi a uscirsene in un pianto inconsolabile.
Aspetta che si riprenda un po’, Adone, e le chiede: – Ma tu queste cose come le sai? – e lei, con orgoglio materno: – Lui me le ha rivelate –. Al che: – Pure! – bofonchia Adone Mella prima d’accasciarsi, affranto, su una poltrona.
Che sia arrivato il momento d’intervenire, è fuori discussione. Mella convoca il figlio nell’opificio, la mattina seguente. Si informa con tatto e circospezione sulla grande inquietudine che lo tormenta. Chiede se davvero quella è la domanda: «Chi sono io?»
– Sí.
– Nel mezzo della notte?
– Sí.
– Di giorno no?
– No.
Lo guarda per un paio di istanti eterni e anche qualcosina in piú:
– Me invece lo sai cos’è che mi tormenta, me?
Ettore scuote la testa.
– Non che tu ti fai quella domanda, no... – Pausa. – Che tu non abbia ancora trovato la risposta.
Si alza in piedi e facendoglisi addosso, di traverso la scrivania, con il dito puntato:
– Un coglione! Ecco la risposta.
Si siede. Batte un pugno sul piano della scrivania. Stancamente, però. Vede il figlio piú desolato di lui. Allora gli mette le mani sulle spalle. – Ragazzo mio, – gli dice con un misto d’indulgenza e di pietà, – è ora che tu incominci a lavorare –. Un lavoro appropriato. Che tenga conto del suo amore per l’arte: l’arte della parola, non è vero? Gli risulta che addirittura legga il francese e l’inglese come se niente fosse. Bravo, bravissimo. E allora stia a sentire. La mattina, ogni mattina, troverà nel suo ufficio, lí di fronte (la mano col dito indice puntato torna a farsi minacciosa), giornali da tutta Europa o quasi. Non ha che da sfogliarli. Lasci pure da parte la politica, la cronaca e gli annunci mortuari. Roba per chi ha tempo da perdere. Piuttosto si soffermi sulle notizie di costume. Sulle offerte pubblicitarie. Sulle minuzie. Il suo compito, eccolo: raccogliere informazioni curiose, ordinarle, catalogarle. Serviranno.
A che scopo, vuol sapere il figlio. Eh, lo scopo... Lo scopo non è del tutto chiaro neppure a lui. Ma c’è qualcuno che gli sa dire...
– Tu, per esempio, perché ti sei tirato i calzerotti sopra i pantaloni fino al ginocchio, roba che se ti chiedevano di farlo l’anno scorso piuttosto ti facevi ammazzare?
Ettore non lo sa e pensa: gli ha dato di volta il cervello a questo.
Ma il padre:
– Il perché, caro mio, era già scritto da qualche parte: bisogna scoprirlo per tempo, farsi trovare preparati, anticipare la moda, capito?
– No.
Tranquillizzato dalla scoperta che il padre è sulla via di un innocuo rimbambimento senile, e quindi non gli può nuocere piú di tanto, mentre lui era già pronto al peggio, Ettore Mella si adatta senza recalcitrare alla nuova condizione di lavoratore – e teorizza, ripromettendosi di darne comunicazione a tempo debito, che il senso del lavoro è di non averne affatto. Col che ritiene anche di aver cancellato quel «coglione» che non smette di far male. Davvero? Ne è convinto? Per la verità deve ancora pesargli, l’insulto, e infatti la sua vena creativa si è completamente inaridita. Ma avverte oscuramente che il suo giorno non è ancora arrivato, eppure non tarderà.
Ciò accade, fuor d’ogni dubbio, la prima domenica del maggio 1899. A Varsej è annunciata un’esibizione del celebre Garnier, il «virtuoso degli spazi celesti», come lo definisce «La Sesia», arditissimo timoniere di palloni aerostatici e spregiatore delle macchine volanti che «anziché fare affidamento sulla libera potenza dell’aere ricorrono a orrorosi dispositivi meccanici». Se ne sono visti ormai molti, di tali palloni, alzarsi in volo e con alterna fortuna proseguirlo; ancora mai uno «con sopra una ninfa artefatta che a una data altezza ritornerà a terra senza pallone, col paracadute». Un esperimento strabiliante e, si mormora, inteso a precorrerne altri in cui a vincere gli abissi sarà non piú un manichino ma chissà, un essere vivente…
Ettore Mella, non avendo ancora ottenuto dal padre il sospirato automobile (ma ci sono trattative in corso) raggiunge Varsej su un bel tiro a due in compagnia di Leonilde Botta, famiglia di banchieri, dote atta a esaltarne le doti. Si sistemano sugli spalti in legno costruiti per pochi eletti intorno all’antico Lazzaretto, ancora a ridosso di Sant’Andrea, mentre una folla impressionante si accalca tutt’intorno. Garnier ha preteso infatti di partire dal cortile interno, in modo che le manovre d’ascesa del pallone non siano disturbate e se ne possa ammirare (bel colpo, Garnier) il librarsi oltr...