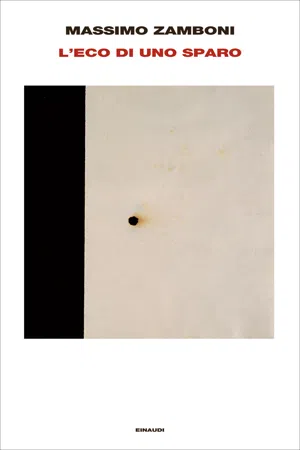![]()
![]()
Innanzi me Dott. Pietro Troja-Mannino notaio residente in Reggio Emilia, senza assistenza di testimoni a cui le parti d’accordo fra loro ed anche con me notaio espressamente rinunciano, sono presenti…
Una pausa breve per ristabilire il fiato. Troja-Mannino è un pezzo d’uomo nella mia immaginazione, pure la lettura del rogito sarà faticosa per uno come lui, discretamente pingue.
… sono presenti li fratelli B* Mario = Telesforo = Silvio = Francesco = Prospero ed Umberto, possidenti, tutti del fu Giovanni fu Francesco, e le sorelle B* Odila e Luisa con la loro madre Canuti Caterina di Enrico, donne di casa, rispettivamente figlie legittime e coniuge superstite del fu Massimo o Massimiliano, fratello dei precedenti…
Comincia cosí l’Atto di Divisione della famiglia B*, il ramo materno del sangue di mia madre. Il giorno è il 19 del mese di agosto 1931.
Anno IX dell’Era Fascista.
Nono anno e dodecaultimo assieme.
La piú breve delle ere.
Solo un doloroso battito di ciglia.
… In Villa S. Pellegrino nella primissima periferia di Reggio Emilia, presso l’abitazione nel podere di famiglia, di fronte a Pietro Troja-Mannino notaio, stante il Regno di Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, per grazia di Dio e volontà della Nazione…
Tutto è deciso già, e solo deve essere letto e confermato. La lettura dell’atto si intrufola nelle menti come una cantilena. La voce del notaio sfuma in lontananza, si dissolve nelle tante stanze snocciolando tutti quei nomi che compongono la genealogia orizzontale della famiglia. Credo che pochi tra quegli uomini maschi seduti attorno a lui, tutti con il vestito buono, i capelli imbrillantinati, l’aria sicura, potessero ascoltare attentamente. Uomini piú avvezzi al lavoro che ai fogli scritti, stavano immobili, solo inavvertiti assensi del capo; con il cucire – da noi si dice cosí – le gambe accavallate, un piede penzoloni che rimbalza su e giú. Generazione di bisnonni dall’aspetto concreto, estraneo agli uffici cittadini, e insieme bastantemente elegante, proprio di chi frequenta agiatezza da un certo tempo pur avendola dovuta conquistare. Baffi scuri. Teste quadrate, mascelle solide, da masticatori: la loro somatica li distingue abitanti della pianura, accesi e riscaldati, lontani da asciuttaggini e freddezze montanare. I documenti pubblici che li riguardano definiscono quegli uomini «macellatori». E aggiungono: «padroni». E «benestanti». Scarpe lucide ai piedi, calze eleganti, cravatte e gemelli al polso per la solennità del giorno.
Finestre serrate, contro l’origliare dei servi e dei curiosi, nonostante l’agosto di pianura. Qualcosa di buono, di fresco, sulla tavola imbandita nella stanza accanto.
Forse soltanto Telesforo, in quanto primogenito e capo carismatico, forse le due sorelle nipoti di quei sei zii, in quanto uniche donne del gruppo e insegnanti, si impegnano a seguire il rogito. Gli altri sonnecchiano con la ragione in caldo, aspettando il momento di firmare. Eppure, per quella sigla indelebile la vita di ognuno e dei suoi cambierà, avviando lo sgretolamento di una concezione monumentale e storica del vivere assieme. Un atto di divisione, appunto. Nessuno lo avverte, ma cosí arriva il Novecento, spazzando ciò che fu: e i nuclei di sangue si andranno progressivamente a separare, diventando monocellulari.
È soltanto una lettura impegnativa per il notaio, cui la soddisfazione di una scrittura stesa secondo i canoni della professione regala una piccola estasi da burocrazia. Non posso trascrivere integralmente l’atto, ventisette pagine dattiloscritte fittamente, caratteri e numeri, valori e nomi catastali, misure di terreni. Ma è un piacere leggerlo, perché in quelle righe scorrono nascostamente le consuetudini agrarie della nostra terra: i nomi dei poderi – La Grande, La Piccola, Corte Rondina, Abissinia –, il loro confinare a ponente e a meriggio; le aree cortilive con annesso porcile, i pozzi in comune e le servitú dei canali; per tutte le scorte, vive e morte, e gli attrezzi relativi.
Percorriamolo comunque per sommi capi, perché è nella difesa strenua di quanto quel giorno viene pattuito che traggono senso tutte le vicende successive:
Mancando ai vivi il 2 ottobre 1893 senza aver fatto testamento, il fu Giovanni fu Francesco lascia di possedere agli undici figli e figlie un unico cespite denominato Castello B* in Villa Pieve Modolena.
Patrimonio giudicato troppo esiguo per essere condiviso tra undici eredi, e quindi prontamente consolidato liquidando le quote alle sorelle Giuseppina, Giulia ed Enrichetta, disinteressate alla proprietà essendo andate a marito, e al fratello Gisberto, andato a sposa. Sette fratelli maschi restano assieme. Sette fratelli che per i successivi quarant’anni condivideranno la vita lavorando cumulativamente, in perfetta armonia fra di loro: una combinazione rara, un concentrato di forze e volontà tale da imprimere il carattere di saga familiare alle loro vicende.
I sette B*, ci informa il notaio, hanno avuto fortunata occasione di produrre un discreto patrimonio immobiliare, amministrato e coltivato sempre unitamente, fino alla data della divisione in corso, causata dalla improvvisa morte di uno di loro, Massimo o Massimiliano. Momento in cui li comparenti Consorti B* non stimando piú conveniente continuare quella comunanza di interesse, hanno divisato il proponimento di dividere il loro comune patrimonio. Il discreto patrimonio immobiliare è in realtà molto consistente, e se i fratelli si voltassero indietro ora avrebbero davvero di che essere fieri per l’economia che sono stati capaci di generare dietro di sé, sudando, ragionando, lavorando assieme. Undici poderi agricoli sparsi per la pianura, sette palazzi nella città, nel cuore antico; tanto che – dicono in famiglia, esagerandosi – la centrale piazza San Prospero è tutta dei B*, tranne la chiesa. Il perito incaricato di concordare le quote di ripartizione stima in lire tre milioni centoquindicimila ed una lira il cumulo patrimoniale, frumento e formaggio Parmigiano Reggiano compresi. Una cifra difficile da valutare con il metro di oggi, certo considerevole raffrontata a un salario medio operaio di quegli anni di lire 530 mensili. Una ricchezza che il secolo a venire ha provveduto a frantumare in mille rivoli. Fortunati; meno fortunati. Separati, comunque. Una sola proprietà in comune resiste ancora oggi, tuttora indivisa e indivisibile, quell’una lira indicata nel patrimonio generale. Forse il piú importante e il meno valutato dei beni; certo il piú duraturo.
Ne parleremo piú oltre.
Sette sette sette. Dicono che un seme di erbaccia, una semente cattiva, lasciato cadere in terra buona germoglierà producendo male erbe per sette anni. Dicono che per ogni capello bianco strappato sette altri ne nasceranno. Sette, sempre sette. Sette fratelli che vanno d’accordo. Sette uomini fratelli, uniti e intelligenti. «Con una forza come quella, – scriverà Italo Calvino, parlando d’altri sette fratelli che incontreremo poi, nel corso della narrazione, di tutt’altro segno, e fede opposta, – ci si sente come una repubblica per conto proprio». Sette fratelli della pianura padana. Ogni fatica può essere ribaltata.
Il notaio procede nella lettura della suddivisione. Sette quote per sette fratelli, assegnate e rispettivamente accettate, da oggi in poi e per sempre. Qualcuno avrà inspirato di ristoro, nella stanza, tossicchiando via un qualche timore nascosto di disaccordi. Da questo giorno si intende cessato lo stato di comunione fin ora esistente.
A Canuti Caterina – mia bisnonna, moglie di Massimo o Massimiliano, il fratello defunto – spetterà l’usufrutto della quota numero tre. Alle sue figlie, Odila e Luisa, madre – la prima – di una bimba di cinque mesi, mia madre, ne spetterà la proprietà. Comprendente: Podere Pozzetto, di ettari diciotto piú il casello del Parmigiano Reggiano e la casa del casaro; Podere Carina, in Villa Rivalta, esteso sopra una decina di ettari di terreno fertile, livellato e abbondantemente irrigato; un intero palazzo nel centro storico cittadino, di piani quattro e vani censiti quarantanove. Proprietà impegnative, che appartengono, cui si appartiene pienamente a lungo; per orgoglio, convenienza, impossibilità di immaginarsi altri.
In quel palazzo di quarantanove vani ho abitato anche io per anni. Senza chiedermi la provenienza, le ragioni del possesso; cosí, come fosse un dato naturale. Vi ho guardato la mia famiglia crescere, poi diminuire e risiedere ancora. In quel palazzo ho conosciuto una nonna, intravisto una bisnonna. Ho visto altre famiglie rigorosamente reggiane compiersi in una lunga vita; poi sempre meno reggiane, e per periodi sempre piú brevi, e ogni cambio nella composizione degli inquilini segnalava che anche la città stava cambiando verso forme nuove, inaspettate.
La lettura va a terminare.
Conformemente alla volontà dei comparenti, l’atto, scritto di mio pugno, e letto a chiara voce, viene fatto trascorrere dal notaio Troja-Mannino per la raccolta delle firme.
Nel sollievo di tutti è ora di distendersi. Ora di stappare vino di ghiacciaia. Un brindisi a ciò che è stato. Due, a quello che sarà. Qualcosa di spumante e leggero, un lambrusco chiaretto e chiacchierino della Bassa – qualcuno tuffa un mezzo limone nel bicchiere – o un piú scuro Montericco delle colline «che sa di uva», per i bevitori piú indifferenti al clima, versato da bottiglioni dal vetro spesso, nero, impenetrabile. Apprezzano i botti dei turaccioli che saltano, Vocca che ciocco!, circondano il tavolo con lo sguardo e poi il corpo – qualcuno decanterà il bianco abboccato che non inciucca –, le donne avranno messo in mostra i salumi sul tagliere, le torte e gli erbazzoni, su piatti decorati, tovaglie ricamate, schermendosi come da consuetudine familiare con quella espressione rituale che utilizzano ancora oggi: «Dopo non c’è niente altro, eh!»
La sera, immagino, una cena in ultima comunione attorno al formidabile tavolo dei B*. Raccontano ancora oggi che «nel ’28 erano in 28» seduti attorno a quel gran pezzo di albero, fabbricato con un’unica asse smisurata. Ventotto tra fratelli, cognate, discendenza. Voci alte, esuberanti, abituate a scavalcarsi con il tono; braccia che si esprimono gesticolando. Quel mercoledí 19 agosto si celebra il commiato, la separazione attuata per crescere ancora. Brodo di cappone, brodo «con l’occhio» – il grasso che galleggia sull’oro liquido di manzo e gallina – dove cuoceranno cappelletti o pasta reale. Oppure verranno serviti tortelli d’erba? Lasagne? Carne certamente, ossessione della famiglia, carne lessata con salsa verde di prezzemolo e uova, carne arrosto accompagnata da cipolline in dolce e brusco, cacciagione con salsa di carote, flan di spinacci. Un tocco di Parmigiano per avvicinarsi alla conclusione. Il Dolce Amore, la Zuppa inglese, il Salame dolce di cioccolatto. Nocino per chiudere, e caffè di Mokka.
Trasmessa come patrimonio femminile, indifferente al clima – abituata a spremere tutte le verità dall’uovo, le sue consolazioni dal burro –, quella sera la cucina etnica di casa nostra suggella la separazione avvenuta.
![]()
Si è assaliti da una ebbrezza biblica nel cercare documenti in un modesto archivio parrocchiale di campagna, che pure per forza di vicende storiche non può trattenere in sé piú che due-tre secoli di discendenze. Scorrere quelle pagine inchiostrate con l’indice calcato per non naufragare è forse il viaggio piú avventuroso che si possa ancora affrontare, scortati da catene cantilenanti che lasciano interdetti: figlio di, che fu figlio del fu, che fu figlio del fu, che fu figlio del fu… Si compie una vertigine retrospettiva che soltanto l’organizzazione cartacea – fogli di famiglia, stato di popolazione, indice dei battezzati, fogli di morte, registri di matrimonio – riesce a frenare indirizzandola in forma di linea, l’unica adatta al nostro intelletto. L’ossessione del vuoto è l’ossessione di riempirlo, di catalogarlo, l’ossessione di enumerare le discendenze cosí come procede la Bibbia, cosí come usano oralmente i popoli nomadi che non hanno registri che ricordino per loro. Ancorarsi ai luoghi, al possesso dei luoghi, è una zavorra che ci tiene eterni contro un vento incessante che tutto altrimenti spazzerebbe via. Tanto accanirsi non è spiegabile con le sole necessità materiali – casa, cibo, fuoco – per i figli e per sé: questa è la nostra cultura; in questo risiede il formarsi della Legge.
Il resto è Limbo, insostenibile Natura.
Prima di stabilirsi a Reggio agli inizi del Novecento, i B* abitano ininterrottamente nel Castello di Pieve Modolena per almeno centocinquanta anni. Da dove derivino quei patriarchi anteriori, come e perché siano giunti là, attraverso quali mezzi o uffici abbiano potuto acquisirne la proprietà, è consegnato ad archivi inaccessibili. L’etimo li ricondurrebbe al Nord, alla vicina Lombardia, alla città di Bergamo. Le carte li dicono proprietari di una «casa con terra», uno status decisamente poco comune per quei tempi. Poca terra, in effetti: 44 tavole reggiane, circa 1800 metri quadrati, posti a confine con le proprietà della contessa Sormani e la «strada maestra», l’antica via Aemilia. Vengono nominati in maggior parte «negozianti», dediti al commercio; intraprendenti, dunque, da tutti indipendenti se non dal loro ingegno, e residenti in ottima posizione strategica lungo l’asse principale appena fuori il centro cittadino. Quasi tre secoli sfiorati nel medesimo luogo immobile – che ancora oggi viene ricordato come Castello B* benché nessun familiare lo abiti da piú di cent’anni. Da lí videro passare guerre e duchi, successioni europee, repubbliche reggiane, rivoluzioni francesi, duchi nuovi e nuove insurrezioni, unità d’Italia, governanti buoni o cattivi – piú spesso pessimi – prima di traslocare tutti assieme avvicinandosi alla città.
Quasi ogni anno, due al massimo, per tutti i centocinquanta certificati nell’archivio parrocchiale, le loro donne consegnano un figlio al mondo. Se dovessi procedere a elencare tutti quei figli, che non sono mai meno di otto a coppia, e i figli dei figli e i nipoti e i cugini che tutti indossano nomi familiari che si ripetono e migrano tra le generazioni come in un romanzo fluviale sudamericano e ai quali tutti vengono imposti due o tre nomi scelti tra i nomi dei nonni o dei fratelli appena deceduti – di infiniti «infanti» sono costellati gli elenchi parrocchiali dei morti –, ci sarebbe davvero da restarne tramortiti. Nato, nato, nato, nato morto, non nominato: la forza di quelle donne doveva essere straordinaria.
E se incorporiamo infine tutti i cognomi delle madri al sangue dei mariti vedremo esplodere all’infinito le generazioni, tutti si mischiano con tutti. Potremmo avere maggior umiltà e forza, poiché in ognuno di noi risiede una vertiginosa moltitudine imparentata.
Quando si affaccia in vita mio bisnonno Massimiliano, sua madre trisnonna mia Cucchi Luigia di professione massaia aveva partorito tre volte già nei tre anni precedenti, e nove volte partorirà nei diciotto successivi. Era l’anno della Comune di Parigi, 1871, di Roma capitale d’Italia. Massimiliano Carlo Francesco proviene dunque da Giovanni Maria che percorre tutto l’Ottocento a Pieve Modolena e nasce da Francesco Vincenzo Carlo e Bassoli Luigia, il quale Francesco principia la sua vita sul finire del secolo precedente spirando poi «nelle braccia del Signore» a metà dell’Ottocento e viene come primogenito da Giuseppe Antonio sposo di Ferretti Ippolita e nato da un Francesco a sua volta nato agli inizi del Settecento e che di cognome faceva allora Bargomi, registrato dai documenti manoscritti come «proprietario di casa propria», concessa in uso a altre quattro famiglie che in «detta casa» abitavano. Massimiliano B* fu Giovanni fu Francesco fu Giuseppe fu Francesco: cinque nomi di maschio in successione, cinque punti saldi cui afferrarmi mentre affondo nelle calligrafie ostili dei registri parrocchiali. Siamo già a inizio Settecento.
«Detta casa» era il Castello. Quasi non lo si vede ora, sommerso dai concessionari d’auto, dai palazzi commerciali della prima periferia; ma c’è, tale quale era, e per le architetture pressoché inalterate basta uno sforzo piccolo di fantasia per estrarlo dal contesto attuale.
L’esercente della tabaccheria posta a fianco me lo conferma.
«Entri sotto l’arco tamponato».
Da fuori, non è certo un palazzo patrizio; né doveva esserlo allora. Ho dovuto cercare parecchio per identificarlo, indovinando, interrogando, scartando via via ville e casali augusti, solenni dimore di campagna in stato di abbandono, ridimensionando progressivamente – con sollievo – le mie aspettative.
Nessuna dimora arrogante.
Passando sotto l’arco tamponato, entro infine nel cortile in comune. Solo casette. Tante casette. Cosí questo sarebbe il Castello. Alla vista, il nome suona supponente, oppure ironico. Straordinari comunque questi incastri abitativi. Luoghi dove si fondano comunità strette come un pugno, fraterne per dovere, forse anche feroci. Repubbliche per conto proprio, dicevamo già. Casette costruite le une addosso alle altre, sovrapposte, con i muri in comunanza, le scale che collegano e espandono abitazioni stalle botteghe officine senza soluzioni, disposte a cerchio o quadrato senza altra apertura che non fosse risolta su un’unica piazzetta o vicolo che dirigeva all’esterno. Ovattati contro l’esterno, risuonanti di rumori estinti, di quei sistemi architettonici a incastro ne esistono ancora in provincia: può capitare di imbattercisi a Campegine, Arceto, altrove. «Ghetti», li chiama la gente di campagna. Una concezione difensiva e comunitaria del vivere, un uso antico, tanto che il cancello di ferro che ogni sera sbarrava l’accesso ai forestieri lo chiamavano «rosta», termine di diretta derivazione longobarda.
Difensivo e comunitario: cosí doveva apparire questo castello popolare dei B*, sperso nella campagna sulla strada romana verso Parma.
![]()
Osserva Rilke, nelle Elegie duinesi: «Non crediate che il destino sia poi tanto di piú di quel condensato che è l’infanzia». L’infanzia è il riassunto di tutto ciò che sarà. L’infanzia della famiglia B* – il suo destino – si situa tutta nel contrattare bestie, comprare bestie, vendere bestie, macellarle. Buoi, vacche, tori, torelli, vitelloni, m...