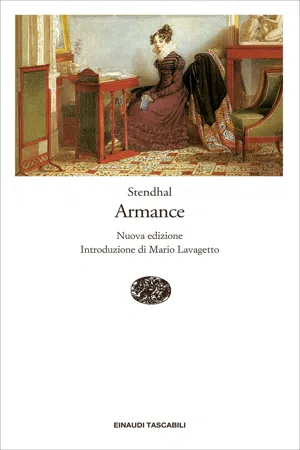![]()
Se è vero, come qualcuno ha detto, che la traduzione comporta sempre un esercizio critico, tradurre Armance significa, prima di tutto, tentare di sciogliere l’enigma del suo stile. Sappiamo dell’idiosincrasia di Stendhal per lo stile pretenzioso e raffinato, «da bottegai»: nella sua premessa al romanzo rivendica il diritto a uno stile «agreste e borghese», che conservi la forza dell’immediatezza anche a costo di qualche imperfezione. Possiamo dunque immaginare la sua sorpresa nel leggere le prime recensioni ad Armance, che sottolineavano proprio i difetti opposti a quelli da cui aveva cercato di difendersi nella breve nota introduttiva e che criticavano lo stile del romanzo, giudicato troppo sostenuto, pretenzioso, complicato, gourmé, addirittura pedante e antiquato. Fu un giudizio condiviso anche dagli amici di Stendhal, fatta eccezione, a quanto ne sappiamo, per Mérimée, che parlò, lui solo, di «stile secco». Lettori piú recenti hanno accusato Armance di sciatteria stilistica. Sappiamo anche che Stendhal non ha mai rinnegato il suo primo romanzo, che trovava ben fatto e delicato come la Princesse de Clèves.
L’equivoco sullo stile di Armance nasce probabilmente dalla natura ibrida del genere romanzo, che non aveva ancora canoni definiti ed era estremamente ricettivo. Fin da ragazzino, Henri Beyle ha coltivato un sogno: vivere a Parigi e scrivere commedie come Molière. È noto che abbozzò e in qualche caso portò a termine, alcuni lavori teatrali. Il suo primo romanzo, scritto di getto e rivisto in breve tempo, senza che vi fossero apportati grossi cambiamenti, risente di quella vocazione giovanile e per certi aspetti le dà corpo (ancora nel 1826, l’anno in cui Armance fu scritto, Stendhal tentava la via della commedia). Dal teatro Armance eredita il contatto immediato con la realtà del suo tempo e la vocazione alla polifonia. Lo stile finisce per essere un non-stile, uno strumento sensibilissimo per registrare i discorsi altrui: piú che di un concerto, il romanzo si compone di una folla di voci spesso dissonanti e in qualche caso armonizzate in duetti o terzetti. Sullo sfondo c’è una vita di società in cui niente è serio, forse nemmeno le passioni ardenti, esaltate fino al parossismo, dei due innamorati. I cupi umori germanici sono contrappuntati dalla gaiezza dell’opera buffa: l’enfasi tedesca, le esclamazioni di dolore, le lacrime e i sospiri dei due innamorati, eroi romantici e passionali, convivono, nello stile di Stendhal, con il brio scoppiettante di certe arie rossiniane, riconoscibile nei capricci estrosi di Mme d’Aumale. Non a caso l’Otello di Rossini funge da «preludio» all’episodio del duello, che ha come oggetto l’amore-vanità.
La passione di Stendhal per l’opera buffa, per l’aneddoto curioso, per la beffa e per il riso si impone anche a un soggetto cosí apparentemente lontano dalla commedia. Il cupo Octave incarna tutte le follie del misantropo, ma la sua malattia è messa in scena e allo stesso tempo vista dall’esterno, commentata, diagnosticata, criticata, irrisa. Lo stile di Armance sta allora tutto in questo teatro delle passioni: ogni personaggio recita una parte e spesso è consapevole delle sue finzioni. Persino l’onesta Mme de Malivert e la dolcissima Armance ricorrono all’inganno, perché il loro ruolo sociale lo esige. Ma il gioco delle maschere non si ferma qui: il discorso diretto, parlato o pensato, spesso prosegue anche al di fuori dei segni diacritici che lo delimitano, si mescola alla voce del narratore e diventa parodia: l’autore sta dietro le quinte e ride di tutto.
In questo coacervo di voci, di cui si è cercato di rispettare la tonalità, esiste comunque un vocabolario stendhaliano, fatto di preferenze e di esclusioni, che il traduttore deve necessariamente restituire. I termini ricorrenti sono stati ripetuti, contravvenendo alla legge retorica della variatio. È stata sempre mantenuta, ad esempio, la traduzione di sombre con cupo, in riferimento all’umore, alle fantasie, agli stati d’animo, agli arredi, agli accordi di Mozart, al tessuto di cui è fatta la borsa regalata da Armance a Octave, anche dove si potevano trovare iuncturae piú eleganti. La cupezza di Octave è infatti una qualità essenziale, che finisce per contagiare anche Armance; senza la ripetizione dell’aggettivo sarebbe stato piú difficile cogliere il carattere di «malattia infettiva» dell’umore di Octave. Per lo stesso motivo ho sempre cercato di tradurre noir con nero, e non con scuro o triste, perché fosse rispettato il colore clinico e chimico della malinconia.
Nei limiti del possibile sono state mantenute le relative, anche dove risultano un poco faticose, e il si davanti agli aggettivi (cosí bello, cosí triste...), che ricorre con frequenza altissima (lo ha notato Spitzer in un saggio dedicato ad Armance).
Ho preferito non trasporre in forma impersonale gli interventi della voce narrante, come è stato fatto talvolta in altre traduzioni, quando nel testo francese compare la prima persona. La presenza del commento autoriale è infatti un tratto di stile significativo, che acquista grande rilievo con gli appelli al lettore della Certosa di Parma e con i massicci interventi esplicativi che costellano la Vita di Henry Brulard.
Per quanto riguarda il registro, ho cercato di attenermi alle prescrizioni e alle proscrizioni linguistiche di Stendhal, imponendomi l’astensione dai «raffinati preziosismi» che fanno chiudere il libro dopo il primo capitolo e dalle concessioni al linguaggio gergale contemporaneo. Nel capitolo diciassettesimo, ho preferito tradurre proda di un fosso, scegliendo il termine desueto e letterario in luogo del piú comune riva, per alimentare il sospetto, credo fondato, che in quel punto del testo affiori un ricordo dantesco (Inf., IV, 1-9).
Ho ritenuto opportuno introdurre sempre i trattini didascalici per contrassegnare il discorso diretto e le virgolette «francesi» per il pensato, attenendomi alle consuetudini tipografiche della collana. L’uso dei didascalici mi è parso indispensabile soprattutto per rendere piú agile la lettura dei passaggi, piuttosto frequenti, caratterizzati da un fitto scambio di battute di dialogo in successione continua, senza gli «a capo».
N.P.
![]()
1 Prendendo le distanze da un genere letterario che mostra di disprezzare, Stendhal stimola comunque la curiosità del lettore, suggerendo che dietro le vicende romanzesche si possono nascondere personaggi illustri del suo tempo o fatti di cronaca scandalistica. Vivian Grey è il primo romanzo di Disraëli, pubblicato anonimo nel 1826; Matilda, di un certo Lord Normamby, era stato tradotto quello stesso anno dalla contessa Molé; non si conosce l’esistenza di un romanzo intitolato Almak’s High Life. Stendhal lo ha probabilmente inventato pensando all’Almak’s Club, uno dei ritrovi piú aristocratici di Londra.
2 La bella molinara, opera di Paisiello, composta nel 1788 su libretto di G. Palomba, atto II, scena VI. Vi si racconta la storia di un notaio innamorato di una mugnaia.
3 bate: sic.
4 Bisogna essere mugnai, bisogna essere notai? [N.d.A.]
5 Commedia di Picard e Mazères, rappresentata alla Comédie-Française il 31 maggio 1827.
6 Saint-Gingolf, sul lago di Ginevra.
Capitolo ...