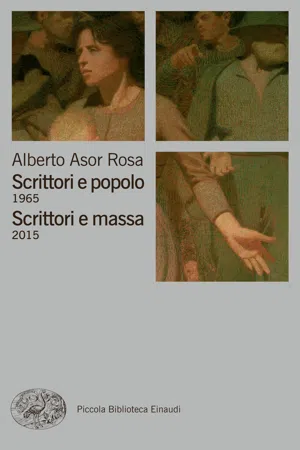![]()
Vi siete mai chiesti perché l’Italia non ha avuta, in tutta la sua storia – da Roma ad oggi – una sola vera rivoluzione? La risposta – chiave che apre molte porte – è forse la storia d’Italia in poche righe.
Gli italiani non sono parricidi; sono fratricidi […] Gli italiani sono l’unico popolo (credo) che abbiano, alla base della loro storia (o della loro leggenda), un fratricidio.
Ed è solo col parricidio (uccisione del vecchio) che inizia una rivoluzione…
UMBERTO SABA
![]()
1.
L’uso del termine populismo è legittimo solo quando sia presente nel discorso letterario una valutazione positiva del popolo, sotto il profilo ideologico oppure storico-sociale oppure etico. Perché ci sia populismo, è necessario insomma che il popolo sia rappresentato come un modello. Questo è il motivo per cui un poeta come G. G. Belli non può essere definito – a mio giudizio – populista: in lui, infatti, non avviene mai, neanche di sfuggita, neanche di scorcio, che il popolo venga, non dico idealizzato, ma anche soltanto reso oggetto di una ipotesi ideologica progressista. Tra il poeta e la materia del suo canto c’è sempre un fermo distacco, o, meglio, un marmoreo rapporto di conoscenza e di rappresentazione; l’affettuosità, nei rarissimi momenti in cui si manifesta, non è mai adesione, ma semplice simpatia: un sentimento, dunque, non programmatico, che non rientra in un disegno ideale e si esaurisce sul piano puramente umano. Ricordate la teoria belliana del «monumento»? «Non casta, non pia talvolta, sebbene devota e superstiziosa, apparirà la materia e la forma: ma il popolo è questo; e questo io ricopio, non per proporre un modello, ma sí per dare una immagine fedele di cosa già esistente e, piú, abbandonata senza miglioramento…» Il fatto è che Belli è un realista romantico, in cui le preoccupazioni del vero predominano ampiamente su quelle del possibile: laddove vedremo che, nello scrittore populista, una larga parte dell’ispirazione è sempre occupata dal sogno di ciò che non è, e che forse sarà, contrapposto al motivo, spesso secondario, o piú secondariamente rappresentato, di ciò che è e che mutare non si può. Sotto questo profilo, considerazioni analoghe si potrebbero fare anche sui veristi italiani della seconda metà dell’Ottocento, almeno su quelli della prima maniera. Anche in Verga, come in Belli, c’è piú verità che simpatia; anche in lui è piú essenziale il culto del reale che l’ammirazione per il popolo stesso.
In altri scrittori il populismo può invece ridursi all’esaltazione di un mito decadente e diventare cosí espressione di un atteggiamento esclusivamente letterario, le cui proporzioni culturali ed ideologiche si rivelano, ad un’analisi piú attenta, assai povere e limitate. È il caso, ad esempio, di Gabriele d’Annunzio, che, nelle Novelle della Pescara, pur uscendo dalla severa matrice veristica, individua un valore positivo nella barbarie e nella ferinità dei suoi contadini e pescatori abruzzesi. È il caso di tutti coloro, tra l’Otto e il Novecento, che sono arrivati al popolo attraverso la ricerca estetizzante della verginità sensuale e dell’esaltazione sensibilistica. In costoro il populismo resta circoscritto in un ambito ben definito, componente, come dicevamo, di una predisposizione fondamentalmente letteraria alla vita e ai contatti umani. Quando invece le ambizioni sono piú estese e il «quadro» culturale, entro cui l’elemento populistico si colloca, risulta tutto influenzato, tutto indirizzato, proprio da questa scelta fondamentale verso una concezione positiva di popolo, allora il discorso non potrà essere soltanto letterario, ma, necessariamente, storico-culturale, storico-politico, o, tout court, politico.
Constateremo ben presto che il populismo, in quanto tendenza, si manifesta generalmente presso quegli scrittori o quelle correnti, che hanno presente un orizzonte di letteratura nazionale e si pongono – da un punto di vista o dall’altro – un problema di egemonia politica e ideologica. I due termini di popolo e di nazione rivelano la loro reciproca e indissolubile dipendenza, anche quando il richiamo alla presenza e alle ragioni del popolo assume il carattere di una decisa protesta sociale. Senza voler abbozzare, neanche a grandi linee, il problema del populismo in Europa, non mi pare dubbio affermare che la nascita di una letteratura populistica coincide con la nascita o la rinascita della nazione, oppure, anche piú spesso, con i tentativi di farla nascere o rinascere o di darle un nuovo contenuto sociale, piú avanzato e progressivo. Intorno alle necessità oggettive d’organizzare una cultura nazionale, dentro le strutture politiche e sociali della nuova o rinnovata nazionalità, certi strati borghesi – che non sempre coincidono con i gruppi dirigenti effettivamente la vita politica ed economica del paese – coagulano i loro interessi ideologici, letterari e politici verso le grandi masse popolari. La diversità dei risultati, che un fenomeno del genere comporta, sarà strettamente legata alla diversità dei fattori, dai quali questo rapporto si origina e si determina: presenza maggiore o minore di grandi masse popolari e contadine, maturità dell’orizzonte ideologico del ceto borghese dominante, natura dei contrasti in esso esistenti fra gruppi di formazione sociale e culturale non omogenea, capacità di sviluppare soluzioni letterarie diverse da quella populistica, ecc. Alcuni caratteri restano però comuni; anche perché, soprattutto nell’Ottocento, le varie esperienze populistiche nazionali si comunicano e si scambiano tra di loro in misura impressionante.
Sulla base delle argomentazioni precedenti, nessuno può sorprendersi che la grande patria del populismo, nel senso piú puro del termine, sia stata la Russia. Da una parte, cento milioni di contadini, prementi come muta presenza da secoli alle soglie della Storia, ostinata a non considerarli e a non riceverli; dall’altra, un ceto intellettuale vivacissimo, che non riesce a diventare classe politica dirigente e scarica perciò tutti i suoi fermenti progressivi nell’organizzazione o, assai piú spesso, nella mitizzazione dell’ordine contadino russo, forma storica e nello stesso tempo ideale di una grande Nazionalità, che porta in sé, come un seme fecondo sotto una coltre di neve, il principio di una giustizia universale, di un socialismo non materialistico, valido per gli spiriti come per le condizioni sociali.
La vastissima produzione letteraria, spesso d’alto livello, che a questa profonda aspirazione umanitaria si ricollega e al contempo dà vita ad espressione, costituirà un tramite formidabile della tematica contadina in tutta Europa. Ma non minore importanza avrà la predicazione dei teorici e degli agitatori, da Herzen a Bakunin. Si ricordi, per quanto ci riguarda piú da vicino, l’influenza avuta da quest’ultimo sull’ambiente letterario italiano della fine dell’Ottocento. Carducci stesso ne rimarrà toccato.
La Francia a sua volta dà al populismo europeo la sua anima democratica, egualitaria, anarchista e, a seconda dei casi, socialistica. Negli anni dal 1815 al ’60 essa è una vera miniera di teorie sul popolo. L’eredità della Rivoluzione, con il suo spirito giacobino e montagnardo, è raccolta da un’infinità di autori, che cercano di dare, ancor al di qua di una visione classista della società, una risposta ai mali dello sviluppo capitalistico, dell’oppressione politica, della disoccupazione, della fame, dell’abbrutimento. Alcuni nomi di autori e di opere spiccano su tutti gli altri, rappresentando modi diversi e spesso contrastanti di affrontare e di risolvere lo stesso problema: Claude-Henri de Saint-Simon, con Le nouveau Christianisme (1825); Jules Michelet, con Le peuple (1846); Pierre-Joseph Proudhon, con Qu’est-ce que la propriété? (1840) e con La philosophie de la misère (1846). Ma se questi sono i veri grandi padri del populismo francese, anche Blanc, Fourier, Lamennais forniscono spunti e agganci numerosissimi ad una indagine di carattere populistico. Il quadro è evidentemente molto variato. L’aspirazione saintsimoniana ad una fraterna organizzazione dell’umanità – motivo che colpí perfino il Leopardi della Ginestra – non è certo il programma democratico di Michelet, che avrebbe dovuto riconciliare le classi popolari e quelle dirigenti nelle sublimi idealità di patria, di nazione, di progresso; e questo, a sua volta, non coincide con il risentimento piccolo-borghese, quale Proudhon l’esprime contro le strutture di uno Stato accentrato e contro le leggi inesorabili del grande sviluppo economico capitalistico; né l’utopismo fourieristico è la stessa cosa della forte tensione morale e religiosa contenuta nell’appello cristiano-democratico di un Lamennais. Ma il fascio d’influenze promanante da questo gruppo di pensatori e dalla loro attività politica diretta finisce per precipitare sui prosecutori nazionali e stranieri come un insieme, se non omogeneo, per lo meno indistricabile. Nel Mazzini dei Doveri c’è Saint-Simon, c’è Lamennais, c’è Proudhon. In questi pensatori, che davvero, in tutti i sensi, vengono prima di Marx, un elemento comune, dunque, può essere ritrovato: l’avversione spesso profonda, sincera e moralmente molto intensa contro alcuni mali gravissimi della società contemporanea, che, non riuscendo per difetto d’analisi a scoprire le radici strutturali dell’ingiustizia e dello sfruttamento, non arriva fino ad individuare nella classe operaia la forza eversiva di quel mondo corrotto e trova perciò nel popolo uno strumento di correzione, di miglioramento o di educazione, interno ad un sistema dato di rapporti socio-economici. Il loro programma di massima potrebbe essere riassunto nella formula: contro il grande capitale (quindi, spesso, anche contro la grande borghesia), in nome del popolo, contro ogni organizzazione autonoma della classe operaia.
Vedremo che questo atteggiamento avrà in Italia vastissima diffusione, come, in genere, tutti gli aspetti della cultura democratica e socialmente impegnata di origine francese.
Parlando della Francia, non si può non far cenno della persona e dell’opera di Victor Hugo. I lavoratori del mare (1866) e, soprattutto, I miserabili (1862) traducono in forme romanzesche facilmente accessibili nonostante la loro frondosità il sentimento borghese d’indignazione e di deprecazione per l’egoismo delle classi agiate e le sofferenze dei ceti popolari. Senza curar troppo la profondità psicologica dei suoi personaggi, ma badando soprattutto a realizzare effetti di commozione umanitaria, Hugo riusciva a produrre in questo campo modelli insuperati dal punto di vista di una retorica populistica grandiosa ed impressionante. Intere generazioni d’intellettuali e di popolani riconosceranno in Jean Valjean, assai piú che in Platone Karataev, il tipo ideale della loro vaga se pur fervida protesta contro il male sociale, l’esempio piú insigne di una virtú che cresce dal basso e che fonda persino il benessere materiale sull’osservanza di alcune irrinunciabili leggi morali. Con queste opere Hugo dimostrava che ad un populismo di questo tipo non riusciva repugnante neanche un atteggiamento etico e spirituale fondato sull’uso spropositato dell’espediente retorico, dell’intrigo sentimentale, del colpo di scena ad effetto. Ai fini di una diffusione di questa tematica anche presso lettori di mediocre o scarsa cultura, tutto ciò risultava anzi estremamente positivo, per quello spontaneo incontro fra gusto piccolo-borghese e gusto popolare, su cui spesso ci accadrà di ritornare. Con gli Châtiments (1853), inoltre, Hugo imponeva in tutta Europa un tipo di poesia retorico-civile, che si serve dell’appello al popolo come di uno strumento essenziale al compimento di un programma di restaurazione democratica contro la tirannia dei burocrati, degli alti funzionari, degli affamatori, degli speculatori, dei «piccoli uomini» di ogni razza e ceto. Attraverso la sua voce, l’altisonante spirito del Progresso, «calme et fort, et toujours innocent», si espandeva dappertutto, incontrando l’universale consenso di coloro che nel mondo continuavano a vedere, ancora nell’Ottocento, la lotta eterna fra i principî del Bene e del Male, della Libertà e dell’Oppressione. Da lui in poi, e per moltissimo tempo, «l’Art et le Peuple» dovevano rimanere legati alla stessa catena di un progressismo letterario gonfio di parole e piccolo-borghese nell’animo.
2.
Anche in Italia il fenomeno populistico è vivo, pur senza raggiungere la ricchezza artistica e letteraria dell’esperienza russa, né l’organicità politica e ideale di quella francese. Anche in Italia, infatti, si pone, e a piú riprese, il problema della rivoluzione nazionale, che altri paesi europei avevano risolto in periodi precedenti, passando per strade piú avanzate e moderne. Non è un caso che, agli ideali del Risorgimento e poi della Resistenza, cioè, per usare le espressioni care ai nostri critici di sinistra, del primo e del secondo Risorgimento, siano legate fasi di eccitazione letteraria populistica. Né è da sottovalutare l’altro elemento, costituito dalla presenza di un problema contadino assai pressante, non solo nel meridione d’Italia, ma un po’ in tutte le regioni del paese: sí che le intelligenze piú avvertite osservarono fin dalla metà dell’Ottocento che il consolidamento dell’unità politica poteva essere conseguito solo attraverso una radicale riforma dei rapporti sociali nelle campagne, che alleasse al moto nazionale la fiducia e la partecipazione di ingenti masse popolari (contadine), ad esso sostanzialmente indifferenti o addirittura avverse. Non discuteremo questa tesi, che dagli scrittori democratici dell’Ottocento doveva poi essere travasata nel pensiero di A. Gramsci, e che viene smentita oggi da quanti vedono nel sacrificio del problema contadino l’inevitabile scotto pagato alle necessità di industrializzazione del paese1. È un fatto, però, che durante tutto il secolo XIX possiamo avvertire dietro l’opera di scrittori e di uomini politici la pressione di una massa sociale subalterna, indifferenziata e generica il piú delle volte, la quale si esprime in forme ideologiche molto diverse tra di loro ma contraddistinte da questo dato comune, ch’esse ruotano tutte intorno all’esigenza di dare una risposta borghese (nazionale) al problema della presenza storica, del ruolo, delle funzioni politiche, sociali, culturali del popolo. Che questo lavorio, pur essendo molto intenso e continuo, non abbia dato vita ad una corrente dichiaratamente populista, si spiega forse con i caratteri del ceto intellettuale italiano nei due secoli ultimi della sua storia. L’arretratezza dello sviluppo storico-sociale non permette infatti qui da noi quel lento processo di formazione di una classe grande-borghese, su cui in Europa si fonderanno piú tardi la fortuna e le sorti di una cultura moderna, possentemente rinnovatrice e in alcuni casi eversiva. In queste condizion...