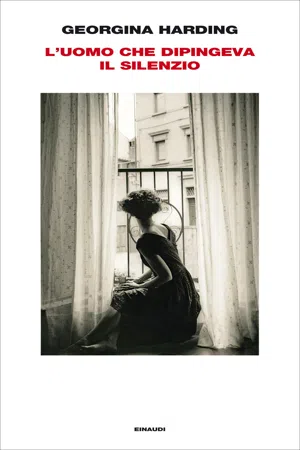![]()
![]()
A una prima occhiata la casa di Poiana appariva imponente. C’erano il suo candore, la lunga facciata neoclassica, il portico sormontato dal frontone e le file di finestre dalle imposte verdi. L’edificio sembrava piú grande di quanto non fosse, perché in effetti la sua profondità non superava quella di una sola stanza. Chi fosse arrivato dal viale d’accesso e avesse guardato all’interno, avrebbe potuto scorgere il giardino retrostante al di là del luccichio dei vetri.
Era un luogo attraversato dalla luce, luce riversata dalla successione delle finestre sui bei parquet di camere che si susseguivano l’una dopo l’altra, camere le cui porte rimanevano sempre aperte – tranne quando si facevano grandi sforzi spazientiti per chiuderle nei periodi piú freddi dell’inverno – dato che in quella casa le persone si muovevano liberamente come la luce: membri della famiglia, domestici, visitatori, abitanti del villaggio venuti per qualche incombenza, per presentare una richiesta o chiedere consiglio, figli dei proprietari e della servitú lasciati a gironzolare insieme ai cani.
In certi giorni c’erano momenti in cui i bambini correvano sfrenati di stanza in stanza slittando sul legno lucido. Oppure si nascondevano negli armadi e al riparo di lunghe tende, dove solo un fremito nel damasco o la punta di un piede che sporgeva ne rivelavano la presenza. Saltavano fuori da dietro i divani e quando nessuno li vedeva si arrampicavano sui mobili, non tanto sui Biedermeier del salotto quanto sulle massicce cassapanche e sui pesanti tavoli dell’ingresso, che per loro diventavano galeoni da arrembare e conquistare uno a uno nel mare del pavimento, tra pelli d’orso e tappeti trasformati in un esotico arcipelago. Il gioco era ancora piú emozionante perché si svolgeva sotto gli occhi dipinti di antenati in cappelli di pelliccia, con i pugnali ingioiellati che spuntavano dagli abiti e le lunghe facce scure di pirati in gramaglie. Questo passatempo aveva avuto fine la volta in cui i fratelli di Safta, avendo litigato, avevano strappato dalla parete le due spade incrociate appese sopra il camino per affrontarsi in duello. Gli altri bambini li guardavano inorriditi. Augustin se ne stava rannicchiato sotto il tavolo di quercia e Safta gridava per chiedere aiuto, ma quando erano arrivati Stanislaw e Fräulein Lore, Gheorghe aveva un taglio di dieci centimetri sulla gamba e lo scontro si era concluso spontaneamente. Tutti guardavano la ferita, cosí netta e profonda che il tempo era parso fermarsi per un attimo di orrore prima che cominciasse a uscire il sangue.
Augustin e Safta erano nati entrambi a Poiana nello stesso anno, a distanza di sei mesi. Safta – un nome come un rapido respiro, perché quello completo, Elisabeta, non veniva usato quasi mai – era stata messa al mondo in una tranquilla giornata invernale, sul grande letto della stanza al piano di sopra che aveva visto nascere almeno le tre precedenti generazioni della famiglia. Era una camera situata proprio all’estremità della casa, con il soffitto alto e pareti rivestite di legno in cui si aprivano finestre su tre lati, affacciate sugli alberi spogli e sulla vasta lontananza bianca che pareva porcellana sotto la neve. Il letto aveva agli angoli quattro svettanti colonnine ed era coperto da un drappo di seta turchese ricamata che veniva dalla Cina. La madre di Safta era stata condotta là al suo arrivo in casa come giovane sposa, e aveva trovato la stanza bellissima finché la governante non aveva aperto il profondo armadio pannellato che conteneva gli strumenti per il parto. Marina Văleanu era una ragazza snella e impressionabile di appena diciassette anni, scura come i boiari dei ritratti sulle scale e con due occhi che potevano essere tanto appassionati quanto malinconici. Era appena tornata dalla luna di miele a Venezia, cosí innamorata da non poter pensare al marito senza desiderio. Mama Anica era vecchia e rinsecchita, e aveva superato da un pezzo l’età dei timori ginecologici. Tirò fuori dai recessi dell’armadio bacinelle, forcipi, asciugamani bolliti fino a diventare duri come corteccia, forbici, filo, un coltello dall’uso inimmaginabile. E il sinistro spettacolo sgomentò la sposa. Quella notte, facendo l’amore nel letto coniugale, avvertí una subdola paura, un presentimento che le tolse la passione. Cosa c’è, le disse il marito continuando ad amarla. Non sei contenta di essere qui a casa con me? Lei non riuscí a parlargli degli orrori nascosti nell’armadio. Capí che da quel momento in poi non sarebbe piú stata la sua amante, bensí la madre dei suoi figli. Il primo lo portava già dentro di sé e sarebbe nato di lí a otto mesi, solo per morire in culla nel giro di un anno. Poi vennero Safta, Gheorghe e Mihai in una successione anche troppo rapida, ma lo spirito di Marina rimase distante. Fare l’amore e dare alla luce quattro bambini in quel grande letto furono la causa di un’alienazione destinata a durare per tutto il resto della sua vita matrimoniale.
Il piccolo nacque in agosto, in uno degli alloggi per la servitú dietro il cortile delle stalle. Quella notte infuriava un tremendo temporale, con tuoni fragorosi e un fulmine che colpí una delle acacie nei pressi della casa. La madre, Paraschiva, avvertí il violento scoppio proprio nell’attimo in cui spingeva fuori il figlio, lo avvertí con una consapevolezza cosí acuta da impedirle di capire se lo scoppio fosse avvenuto fuori o dentro di lei. L’avrà sentito, pensò. Questo sarà il primo rumore che avrà udito al mondo. Ma piú tardi si sarebbe domandata se quella singola esplosione sonora, il tuono accompagnato dallo schianto quasi simultaneo dell’albero caduto, non fosse stata eccessiva per le orecchie di un neonato.
O forse si trattava di una punizione. Perché lei era sola. Perché il padre del bambino non era rimasto abbastanza a lungo per farlo venire alla luce integro e sano. Perché il piccolo era quello che chiamavano un figlio dei fiori, anche se nel suo caso non erano stati fiori ma un giaciglio crepitante di foglie d’autunno. Perché non aveva nulla da ereditare, e lei era riuscita a pensare di dargli un nome solo al momento del suo arrivo.
Non avrebbe saputo dire quando di preciso aveva capito che era sordo. Era un bambino taciturno. Vagiva di rado, e se lo faceva il suo pianto aveva qualcosa di diverso, sembrava meno sonoro, meno insistente di quello dei coetanei, e meno prolungato. Safta poteva strillare fino a condurre al delirio chiunque si trovasse in casa, le sue urla rimbombavano tra le pareti e continuavano senza tregua finché l’unica soluzione pareva quella di portarla fuori, dove c’era spazio e silenzio e nessuna eco, solo per un attimo, fino a quando il freddo o il buio della notte le toglieva il fiato e tornavano la quiete e il sollievo. Il pianto di Augustin, invece, era breve e uniforme, privo di drammaticità. Piú che piangere, il bambino gemeva, si contorceva e si dibatteva. Vederlo cosí turbava Paraschiva con la stessa urgenza e profondità che qualsiasi madre nutre per il primogenito, ma in molte occasioni non lo vedeva semplicemente perché non lo sentiva. Doveva capitare spesso che si dibattesse a lungo in quel modo a sua insaputa. Già da allora, Augustin aveva imparato a non pretendere l’attenzione altrui.
Non sorrideva con facilità, Paraschiva l’aveva notato. Aveva osservato quel riserbo in lui fin dalle prime settimane e dai primi mesi dopo la nascita. Sembrava concentrare lo sguardo sul viso della madre, e gli s’illuminavano gli occhi, ma non reagiva come gli altri bambini. Non girava la testa se lei gli parlava. All’epoca non aveva dato molta importanza alla cosa. Il mondo intorno a lui era pieno di animazione. Paraschiva si trovava spesso in cucina, dove le chiacchiere non mancavano mai, oppure portava con sé il figlio nella nursery quando aiutava ad accudire Safta. La piccola farfugliava e canticchiava tra sé per buona parte del tempo, ma aveva sei mesi di piú. Con i suoi vivaci occhi scuri, era cosí sveglia da far capire che ascoltava qualsiasi cosa le si dicesse. Paraschiva prese naturalmente l’abitudine di parlare piú a lei che al figlio, di dare per scontato il silenzio di Augustin.
Il bambino stava quasi per compiere quattro anni prima che lei ammettesse ciò che in un certo senso sapeva da sempre. Augustin era nella nursery della casa padronale. Stava giocando con un trenino, un regalo per il piccolo Gheorghe che però non era abbastanza grande per usarlo, e cosí Augustin se n’era appropriato. Adorava quel trenino. Era fatto di legno, con la locomotiva rossa e verde e i vagoni che si agganciavano l’uno dietro l’altro. Lui poteva intrattenervisi per ore, spingendolo su e giú con tanta concentrazione che nemmeno i coetanei riuscivano a distrarlo. A volte Safta ne era irritata. La bambina gli assestava un calcio o un pugno perché la piantasse con quel gioco e guardasse lei mentre si esibiva o raccontava una storia. E Augustin sollevava il faccino sotto la zazzera scura dei capelli, sorrideva con aria placida e si piegava al suo desiderio. Le avrebbe perdonato qualunque cosa già a quell’età, e guardava le sue mosse di danza come se facessero parte di un film proiettato davanti ai suoi occhi, baluginante e capace di avvincerlo all’infinito. Un giorno Paraschiva entrò e lo capí con chiarezza. La scena era un film per lui, non diverso da quelli del cinema itinerante. Un film muto. La bambina era una bruna attrice silenziosa in miniatura: viso ovale, labbra in movimento, occhi pieni di passione. Quel giorno, come al solito, Safta aveva assegnato ad Augustin il ruolo del pubblico, e gli si pavoneggiava davanti raccontandogli una storia, mentre lui sembrava ascoltarla come sempre: lei però non parlava, ma si limitava a muovere la bocca. Stava facendo un suo gioco privato con lui. Fingeva di parlargli, anche se in realtà non emetteva alcun suono, e Augustin non coglieva la differenza. La bambina sapeva quello che Paraschiva non aveva ammesso nemmeno con se stessa: suo figlio non era in grado di sentire nulla.
Quella sera, in cucina, Paraschiva confidò a Mama Anica i propri timori. Le fu difficile trovare le parole. Credeva di conoscerle da tanto tempo, eppure non sarebbe riuscita a pronunciarle prima di allora. Guardò Mama Anica e si chiese se lei lo sapesse già, se avesse intuito il problema. Se entrambe ne fossero consapevoli in silenzio. Quella scoperta era difficile da esprimere a parole perché aveva a che fare con la loro assenza. Una volta che l’ebbe enunciata, le parve di contemplare un pozzo scuro e profondo.
– Se è cosí, – disse Mama Anica, – dobbiamo fare una prova. Sarà semplice. Avremmo dovuto pensarci prima.
Il bambino giocava sul pavimento. Non alzò gli occhi quando la madre andò a mettersi davanti a lui, abbastanza vicina da vederlo bene in faccia. Non sollevò lo sguardo quando Mama Anica gli si piazzò alle spalle. Mama Anica aveva portato con sé la campanella appesa nel corridoio accanto alla porta sul retro, i cui rintocchi nitidi e acuti richiamavano gli uomini dal giardino se c’era bisogno di loro. La suonò in diverse posizioni dietro la testa di Augustin, in prossimità di un orecchio e poi dell’altro. Dopo di che prese un tegame e un cucchiaio di legno, e percosse la pentola a mo’ di tamburo. Ogni volta la madre scrutava in volto il piccolo. Non vide alcuna reazione, neppure un battito di ciglia, nemmeno mentre Mama Anica gli avvicinava la casseruola fin quasi a toccarlo.
– Dunque è proprio cosí. È la verità. Non ci sente davvero.
A Paraschiva parve di essere travolta dal mondo simultaneo delle sue sensazioni uditive, da tutto ciò che sentiva in quel momento: i colpi del cucchiaio sulla pentola, Mama Anica che parlava, il chiacchierio dei bambini nel cortile, i rumori di un cavallo e delle ruote di un carro in arrivo, gli schiamazzi di polli e oche, il gracchiare delle cornacchie sugli alberi, i richiami di qualcuno dalla porta della casa. Tutto ciò che lei udiva e lui no. Eppure Augustin sembrava un bambino cosí sveglio e normale mentre prendeva il tegame e lo colpiva a sua volta con il cucchiaio. All’inizio picchiò sul lato come aveva fatto Mama Anica. Poi ribaltò la casseruola e cominciò a rimestarci dentro imitando i gesti di chi cucina. Raccolse una noce caduta a terra e si mise a rigirarla nella pentola. Paraschiva gli diede un’altra noce presa da una ciotola, poi una patata. Lasciò che cospargesse il tutto con del sale. Assecondava il suo gioco, ma si sentiva lontanissima da lui. Avrebbe voluto chiamarlo a sé. Lui continuò a mescolare e fissò di nuovo la madre per avere altri ingredienti. Paraschiva si guardò intorno e trovò un po’ di erbe aromatiche da offrirgli. Erano tante le cose che gli sfuggivano, e malgrado ciò sembrava soddisfatto di quello che stava facendo. Insieme alla pietà, la madre provò una rabbia improvvisa. Il fatto che non la sentisse e non le parlasse le parve una sorta di rifiuto.
– Parlagli, – disse il dottore. – È sordo come una campana, non c’è dubbio. Non mi è possibile darti speranze su questo, ma tuo figlio può imparare a leggere le labbra. Parlagli ogni volta che ne hai l’occasione. Accertati di metterti di fronte a lui. Pronuncia le frasi lentamente e con chiarezza. Usa parole semplici e ripetile spesso. Hai detto che è sempre stato cosí, che è nato con questo problema. I casi come il suo sono i piú difficili, perché il bambino che non ha mai sentito il linguaggio non sa a cosa serve. Ho visto ragazzini di qualche anno piú grandi perdere l’udito per una scarlattina o qualche altra malattia, oppure per una lesione, ma possedevano già l’uso della parola, e hanno imparato a leggere le labbra cosí bene che quasi non ci si accorge della loro sordità.
Paraschiva andò dal prete e si fermò sulla porta di casa sua tenendo il figlioletto per mano. Il sacerdote era grande e grosso e si chinò verso Augustin. Per quanto Paraschiva fosse sicura delle sue buone intenzioni, il piccolo fece un passo indietro, impaurito dalla statura dell’uomo, dalla veste nera e dalla barba folta. Il prete gli impartí lo stesso la sua benedizione. Raccontò a Paraschiva il miracolo in cui Gesú restituisce la parola a un muto.
– Ma il miracolato era sordo? Gesú gli ridiede l’udito? Secondo il dottore il mio Augustin non è muto, ma solo sordo. Non parla perché non ci sente.
Se Gesú poteva far parlare un muto, replicò il sacerdote, era sicuramente in grado di far sentire un sordo. Ma esistevano particolari santi dai quali ottenere intercessione con la preghiera, aggiunse. Menzionò certe icone e reliquie conservate nelle chiese della regione. E domandò quale fosse il santo del giorno in cui era nato il bambino.
– Era la festa di San Giovanni Battista, – rispose lei. – Il 29 agosto.
– Ma questa data non è solo la festa del Battista, è anche la ricorrenza della sua decapitazione. Devi certamente pregare lui piú di tutti. Sí, devi pregare i santi che ti ho citato, ma specialmente il profeta Giovanni.
Paraschiva fece tutto ciò che le aveva suggerito il prete. Comprò della farina bianca fine e infornò dolci e trecce di pane da usare come offerte, e si recò a visitare le varie icone. In ciascuna chiesa incaricò qualcuno di scrivere la sua supplica e la lasciò là, accese una candela e si prostrò in preghiera. Per celebrare il quinto compleanno di Augustin, portò il piccolo con sé in un famoso santuario del Battista, un intero giorno di viaggio a bordo di un carro per andare e un altro per tornare, e dormí davanti alla chiesa insieme al figlio. Al mattino lo condusse all’interno e lo sollevò perché baciasse l’icona e contemplasse la testa del profeta arruffata e sanguinante sul vassoio. Pregò per il miracolo. Un santo che aveva perduto la testa avrebbe sicuramente capito.
Fece tutto ciò che le venne consigliato da chiunque, ma finí per convincersi che il medico aveva ragione sin dall’inizio. Era già troppo tardi. Augustin continuò a vivere senza parole. Il suo destino nel mondo era ormai segnato. A volte Paraschiva sospettava che non provasse il bisogno di sentire o di parlare. Aveva per lo piú necessità semplici, che lei generalmente era capace di comprendere e soddisfare. Se le capitava di non capire, Augustin poteva abbandonarsi a capricci taciturni, ma terribili. Sferrava pugni, calci e botte in ogni direzione, si rotolava sul pavimento tempestandolo di colpi. In alcuni casi, l’unica in grado di indovinare cosa lo turbasse era Safta. Gli fa male lí, diceva, indicando un punto insospettabile. O, piú semplicemente, è arrabbiato perché Gheorghe gli ha preso la matita, spiegava. A volte Paraschiva si chiedeva se Safta sapesse queste cose per una sorta di telepatia. Riusciva sul serio a leggergli nel pensiero o Augustin mandava segnali che solo lei sapeva cogliere? In realtà, essendogli cresciuta accanto ancora prima di aver imparato a parlare, era giunta a conoscerlo grazie a un intuito immediato, come se Augustin fosse la parte silenziosa di se stessa.
![]()
Quando Safta e Augustin avevano otto anni, arrivò un’istitutrice incaricata di istruire i bambini della casa. Fräulein Lore veniva dalla Germania. Era alta come un uomo, con una chioma rossa di cui andava fiera e un volto liscio e immobile difficile da interpretare e ancora piú difficile da giudicare in termini di età. Giunse raccomandata per la sua fermezza con i maschi, una dote ritenuta necessaria con Gheorghe e Mihai, nati a cosí breve distanza l’uno dall’altro e tanto inclini a litigare. A lezione era inflessibile e stizzosa. Nella nursery, sotto il tetto, faceva freddo d’inverno e un caldo afoso d’estate. La Fräulein costringeva gli allievi a sedere eretti e a togliere i gomiti dai banchi, insegnava a tutti e tre a scrivere lettere ordinate lungo righe ripetute a non finire, e li martellava con le tabelline al punto che Mihai le ripeteva a pappagallo prima ancora di saper eseguire la piú semplice delle addizioni.
I due fratelli si lamentavano e si agitavano sulle sedie e, se pure combinavano qualcosa, era molto probabile che dovessero rifare tutto da capo. Spesso Safta si trovava piú avanti di loro, o si dedicava per conto suo alla lettura di un libro. A volte, mentre l’istitutrice sp...