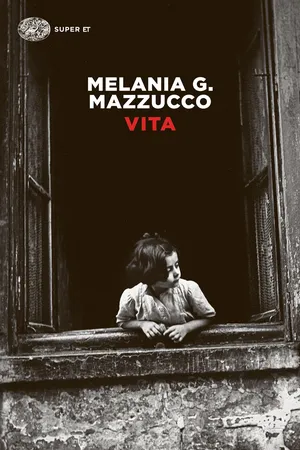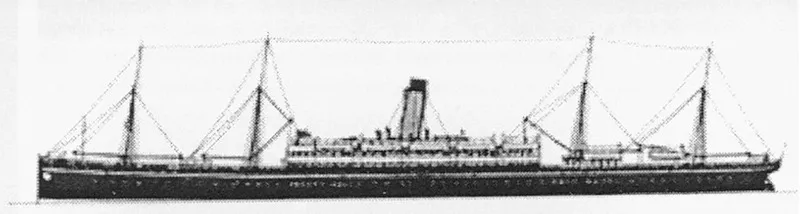La prima cosa che gli tocca fare in America è calarsi le brache. Tanto per chiarire. Gli tocca mostrare i gioiellini penzolanti e l’inguine ancora liscio come una rosa a decine di giudici appostati dietro una scrivania. Lui nudo, in piedi, desolato e offeso, quelli vestiti, seduti e tracotanti. Lui con le lacrime aggrappate al battito di un ciglio, quelli che soffocano risolini imbarazzati, tossicchiano, e aspettano. La vergogna è inizialmente centuplicata dal fatto che indossa un paio di brache di suo padre, gigantesche, antiquate e logore, talmente brutte che non se le metterebbe neanche un prete. Il problema è che i dieci dollari necessari a sbarcare sua madre glieli ha cuciti proprio nelle mutande, perché non glieli rubassero di notte nel dormitorio del piroscafo. In quei dormitori – è cosa risaputa – nelle interminabili dodici notti di viaggio sparisce di tutto – dai risparmi al formaggio, dalle teste d’aglio alla verginità – e niente si ritrova. Infatti i dollari non sono stati rubati, però Diamante si è vergognato di confessare ai funzionari dell’isola che porta i dollari nelle mutande, e gli è venuta l’idea geniale di dire che non ce li ha. Il risultato del suo estremo pudore è che gli hanno fatto una croce sulla schiena e lo hanno respinto in fondo alla fila, per rimpatriarlo appena riparte la nave. Cosí ha fatto un viaggio inutile, suo padre Antonio e il misterioso zio Agnello hanno sprecato un mucchio di soldi e Vita – che è già passata – si ritroverà sola a New York e Dio sa cosa le succederà.
Da dietro la finestra, la città tremola sull’acqua – le torri sfiorano le nuvole, migliaia di finestre scintillano al sole. L’immagine di quella città che sorge sull’acqua e mira dritto al cielo gli rimarrà negli occhi per sempre – cosí vicina, e cosí irraggiungibile. Di fronte alla catastrofe, di fronte a un fallimento cosí indecoroso, Diamante è scoppiato a piangere senza ritegno e ha sussurrato all’interprete il disonorevole nascondiglio dei suoi dollari. In un batter d’occhio si ritrova, rosso in viso, con i calzoni arrotolati alle caviglie, le brache sventrate per scucirne la tasca interna e la cosa piú segreta che possiede in mano, perché non sa dove metterla. Eccolo come entra in America, Diamante: nudo, con la carruba infreddolita che rialza la testa orgogliosamente man mano che lui avanza, a saltelli per non incespicare, verso la commissione, e gli sventola sotto il naso la banconota scolorita e impregnata dell’odore delle sue notti tormentose. La banconota nessuno se la prende, ma i giudici dietro il tavolo gli fanno segno di passare. È entrato. A questo punto ha già dimenticato la vergogna e l’umiliazione. Lo hanno spogliato? Gli hanno fatto calare le brache? Tanto meglio. In pratica, prima ancora di mettere piede a terra, ha già capito che qui possiede due sole ricchezze, di cui fino a oggi ignorava l’esistenza e l’utilità: il sesso e la mano che lo regge.
Un rumore lontano – forse le ruote di un carro che rimbombano sul selciato – lo precipita di soprassalto in un fetido buio. Appoggia istintivamente la mano sulla branda e tasta il cuscino per sfiorare i capelli di suo fratello. Ma stranamente non ha cuscino: la sua testa posa su un materasso ruvido e bitorzoluto. Diamante si leva a sedere. Guarda fuori dalla finestra, e non vede l’ombra della luna. Non vede niente, perché nel punto in cui è sempre stata, la finestra non c’è. Si trova in una stanza dalle pareti cieche, uno sgabuzzino ingombro di oggetti come il deposito di un rigattiere. Una stanza sconosciuta. Sul pavimento, da sotto il letto che fronteggia il suo, sbuca una sinistra fila di scarpe chiodate da uomo. Ma a chi appartengano quelle scarpe, né dove siano i loro proprietari, non saprebbe dirlo. Solo a poco a poco, mentre dilaga in lui una fame prepotente, realizza di non essere a casa sua. La gorgogliante, ubriaca voce d’uomo che risuona di là dalla tenda non è quella di suo padre. Neanche il puzzo che gli mozza il respiro è quello di suo padre. Suo padre puzza di pietra, calce e sudore. Questo è invece puzzo di scarpe, vino e piscio stantio. Porte che sbattono, passi, un rutto eclatante fa tremare le pareti e la tenda che separa lo sgabuzzino da qualche altro locale si spalanca. Lo investe una fètola puzzolentissima, uno scroscio di risate e un fiotto di luce. Diamante chiude gli occhi, ricade supino sul materasso. Adesso è tutto chiaro. Ha sognato di nuovo la scena dello spogliarello di fronte alla commissione, accaduta solo due giorni prima, ma che continua ad accadere, e accadere, e se la sognerà finché campa. Questa è la sua seconda notte americana. Lo hanno portato a Prince Street. La casa è tutta nera, fatiscente, decrepita che sembra dover cadere da un momento all’altro. L’appartamento, uno dei tanti, in cima alle scale, all’ultimo piano, è dello zio Agnello. Questa è l’America.
Un uomo entra nello sgabuzzino, poi un altro, un altro, un altro ancora, finché perde il conto. Qualcuno si svacca sulla branda di fronte alla sua, qualcuno su una rete che scricchiola. Tonfi di mobili spostati, sospiri. Gente che si spoglia – sentore di ascelle. Una, due, dieci concitate voci maschili che si accavallano. Le voci appartengono a un branco di tagliagole privi di scrupoli e assetati di sangue. Parlano – con dialetti diversi e a volte incomprensibili – di incazzature, mazzate, duemila pezze che Agnello deve consegnare a qualcuno altrimenti gli mozzano il naso e glielo ficcano su per il sedere, cosí la sentirà veramente la puzza al naso, quello sparagnino arricchito e arrepezzato. Parlano di polismen che trovènno una vagliona di nove anni. Diamante non osa nemmeno respirare. Qualcuno impreca, ordinando agli altri di abbentarsi, ma nessuno gli dà retta. Le voci incattiviscono, parlano della pupàtella di Agnello, cioè di Vita – che tiene solo nove anni ma quanto si farà bella quann’ammazzucculisce già si vedette. Strappano la coperta dalle mani di Diamante. Anche se non può vederli – perché serra le palpebre, fingendo ostinatamente di dormire – sa che lo stanno guardando. E questo chi è?
Suscita qualche appetito, perché svariate mani lo percorrono, e – dopo averlo frugato in cerca di un borsellino – si ritirano, deluse. Diamante dorme in mutande, quelle stesse luride brache dell’altroieri, perché non gli resta nient’altro. Gli hanno già rubato tutto. Le voci tornano a discutere di duemila pezze, assassini e ricattatori. Diamante trema come una canna al vento. La coperta gli pizzica il naso, gli viene da starnutire. La tenda si scosta nuovamente. Entra qualcun altro, si siede proprio sul suo materasso. «Buonanotte», dice una voce assonnata, «crocatev’a letto e nun tuzzuliate ch’aio a durmiri. Crai scèteme cetto».
A un tratto, qualcosa di caldo sfiora il viso di Diamante. È un piede. Il nuovo arrivato si è infilato nel suo letto. Il piede puzza. Diamante lascia che un’unghia appuntita e dura come quella di un cavallo gli gratti la guancia. Teme che se reagisce lo sconosciuto gli mozzerà il naso e glielo ficcherà nel sedere. L’uomo del piede si allunga sul materasso, impatta nell’ostacolo imprevisto del suo corpo. «Chistu cu cazz’è?», salta su. Un regalino per te, cosí almeno dormi con qualcuno, l’ultima volta che t’è capitato eri ancora nella cicculattera di tua madre. L’uomo del piede bestemmia fra i denti, spinge e preme perché Diamante si sposti. Spingendo e pressando lo relega contro il muro. Se non ci fosse il muro, Diamante cadrebbe giú dalla branda. L’uomo del piede, appagato, si mette tranquillo. Ma gli altri non hanno nessuna intenzione di dormire. Sono eccitati. Qualcuno si è acceso una sigaretta e adesso, a ondate, lo investe una pestilenza di tabacco. Manca l’aria. Manca tutto. Il buio aleggia su di lui come una minaccia. Le voci senza corpo risuonano ancora piú angoscianti. Un intero mondo sconosciuto gli viene incontro nel cuore della notte, aggredendolo mentre è cosí indifeso – con i sussurri, le ombre e il buio.
La paura diventa sconvolgente quando, mentre lui se ne sta schiacciato contro il muro, appiattito come una coperta, i briganti si mettono a disquisire del pezzo di ragazzo ritrovato nel cantiere della sotterranea. Un pezzo di ragazzo non perché fosse alto o grosso, che anzi era solo un ragazzino di dodici anni – un pezzo perché restava solo la testa e il tronco. Non aveva la lingua e gli mancava la sciuscella.
Per Dio, dormite – sbotta l’uomo del piede. Fatti i fatti toi. Sshhh, basta. E ancora sangue, accisi, mutilazioni. Finché a poco a poco i discorsi si sfaldano, il cadavere del cantiere rifluisce in una lode convincente delle zinne di una certa Lena, la discussione sulla corretta ortografia della parola “PAGA” – PAGHA O MUORI, cosí stava scritto nella lettera – si confonde con quella sulle banconote da dieci dollari – quante ce ne vonno per arrivare a duemila? – un diverbio sulla tecnica per affilare la lama di un coltello con un naso ficcato in un sedere, tra una frase e l’altra s’allungano i silenzi. Nel giro di mezz’ora, i litigiosi fantasmi della stanza cadono schiantati in un sonno profondo. Qualcuno russa, riceve una ciabattata in faccia e si azzittisce definitivamente. Anche i rumori della strada sembrano ovattati, adesso, lontani. Ma Diamante non riesce a prendere sonno. Trema. Pensa a una testa senza lingua abbandonata in un cantiere. Pensa al piede che gli preme contro la guancia. A dieci briganti senza volto che vogliono ammazzare lo zio Agnello. O vogliono ammazzare lui, che è solo una coccola di noce, e non fa paura. Che sia una coccola di noce è vero, purtroppo, perché anche se a novembre compirà dodici anni è ancora minuto come un bambino. Benché in effetti non sia un bambino né lo sia mai stato – e anzi, davanti alla commissione, abbia già capito di essere un uomo vero.
Resta sveglio, senza nemmeno rigirarsi sul materasso bitorzoluto, nell’aria umida e viziata. Quando la prima luce del giorno filtra dietro la tenda, scavalca con un balzo l’uomo del piede e salta sul pavimento. Pesta una buatta aperta di sardine e si taglia col bordo affilato del metallo. Reprime un gemito di dolore e si china a esaminare gli uomini addormentati. Hanno facce preoccupanti, baffi pelosi e neri, visi bruciacchiati dal sole, raggi di rughe attorno agli occhi, capelli bisunti, mani ingombranti. Se li incontrasse per strada, alla luce del sole gli farebbero paura – proprio come stanotte. Ma l’uomo del piede no. Ha un paio di baffetti striminziti a forma di spazzolino da denti. È lungo, secco e spinoso come un asparago. Lí per lí non lo riconosce, ma in effetti deve essere suo cugino Geremia. È partito l’anno scorso.
La casa di Prince Street è stipata di pentole, ciotole, bigonce, sacchi di farina, barili e bauli. Diamante s’aggira a tentoni fra le gabbie di legno, dove gloglottano tre panciute galline, e il catino in cui agonizza una pianta di basilico, finché quasi si rompe il naso sbattendo contro la statua in gesso della Madonna delle Grazie patrona di Minturno. È ammaccata. Evidentemente anche altri ci hanno impattato e sono stati ancora meno fortunati di lui. Zigzaga fra canottiere, lenzuola e pedalini umidi penzolanti da precari fili di ferro che tagliano i locali in due e gli schiaffeggiano il viso. Inciampa perfino in un letto matrimoniale, posto dietro un paravento, in quella che sembra la cucina, e rimane allocchito perché accanto alla testa unta di Agnello spicca sul cuscino la nuca pallida di una donna, il suo braccio, e – visione inedita che gli toglie il respiro – una gamba nuda, che la speranza di un refrigerio ha spinto maliziosamente sopra le lenzuola. Chi sia quella donna, Diamante lo ignora. Il fatto è che la testa unta appartiene proprio allo zio Agnello. Lo zio Agnello è sposato con Dionisia la scrivana. Ma la scrivana è rimasta in Italia, era alla stazione con sua madre, quando è partito. Tutt’e due piangevano. Lui non piangeva. S’avvicina alla sconosciuta, incuriosito, sgranocchiando una galletta. Non vorrebbe fare il minimo rumore, ma ha inavvertitamente preso a calci la gabbia delle galline e tutte cominciano a starnazzare. La sconosciuta ha i capelli color miele e gli occhi del colore dell’aceto. Quando si rende conto che se riesce a distinguere il colore dei suoi occhi significa che la donna è sveglia e lo sta guardando, Diamante rincula di soprassalto, travolge la gabbia e cade lungo disteso sul pavimento.
La casa di Prince Street Agnello l’ha presa in affitto dal banchista per rientrare nelle spese dopo l’acquisto del negozio di frutta e verdura, e siccome ha sempre avuto il desiderio acuto dei dollari, l’ha trasformata in una specie di pensione. Quegli uomini coi baffoni, anche se sembrano dei malfattori e potrebbero pure esserlo, sono i suoi pensionanti. I pensionanti, o bordanti, come si dice qui, pagano il letto, i servizi e i pasti. Anche Diamante dovrà pagare. Lo zio Agnello non fa sconti. È sempre stato spilorcio, perché ricco. O ricco perché spilorcio. Per spilorceria, ha pigiato in quelle stanze anguste quanti piú uomini ha potuto. Ci sono brande negli angoli, davanti ai fornelli, dietro ogni tenda, spigolo e baule. Diamante conta quattordici uomini e la donna con la gamba nuda. Ma lui cerca un’altra donna. Anzi, una bambina: Vita.
La mano di Vita – umida, appiccicosa di zucchero, stretta nella sua – sarà l’unica cosa che Diamante finirà per ricordare del momento in cui il traghetto ha accostato ai moli di Battery Park. Tutti gli altri raccontano della forte commozione alla vista degli edifici immensi di Manhattan, bruni di fuliggine, delle migliaia di finestre, sui cui vetri s’infrange la luce, lampeggiando a intermittenza come a ripetere un misterioso segnale. Sbuffi di fumo incoronano le torri, stingendo i contorni, trasformandole in una visione immateriale, quasi un sogno. Raccontano dei comignoli delle navi ancorate alle banchine, delle bandiere, delle insegne che annunciano uffici, banche e agenzie, di una folla stupefacente assiepata nel porto. Ma Diamante è troppo piccolo di statura per intravedere, della terra promessa, altro che culi sbrindellati e schiene macilente. Si calca in testa il berretto – un berretto con la visiera rigida, troppo grande, che gli cala sulle orecchie – e con un saltello assesta il sacco che porta sulla spalla. È la federa di un cuscino a righe – la federa del suo cuscino – e contiene tutto il suo bagaglio. Gli scarponcini, coi lacci legati troppo stretti, gli fanno male. Serra la mano di Vita nella sua, temendo che un urto, uno strattone, anche solo l’inerzia della folla, finiscano per separarli. «Non lasciarmi», le ordina, «per nessuna ragione, non lasciarmi». Vita è il suo passaporto per l’America, anche se non lo sa. Un passaporto sgualcito e febbricitante, con i capelli aggrovigliati sulla testa e la veste a fiori. Dovrebbe avere lo scontrino giallo in bocca, ma stranamente non ce l’ha. È uno scontrino simile a quello che danno a chi deve ritirare i bagagli. Infatti anche loro dovevano essere ritirati. Sullo scontrino giallo c’è scritto GOOD FOR FATHER, ma né lei né Diamante hanno la minima idea di cosa significano quelle parole. Vita annuisce, e per dimostrargli che ha capito gli ficca le unghie nel palmo della mano.
Tutti si cercano, si chiamano in dozzine di lingue – per lo piú ignote, aspre e gutturali. Tutti hanno qualcuno che è venuto a prenderli, o li aspetta al molo, un indirizzo scarabocchiato su un foglietto – il nome di un parente, di un connazionale, di un padrone. La maggior parte ha anche un contratto di lavoro. Ma tutti lo hanno negato. Cosí bisognava. E in verità la seconda cosa che Diamante ha fatto in America è stata di raccontare una storia. E nemmeno questo gli era mai capitato prima. Insomma, in un certo senso ha mentito. Funziona cosí. A Ellis Island gli americani ti rifilano una serie di domande – una specie di interrogatorio. L’interprete – un tizio perfido, un vero acciso che deve aver fatto carriera esercitando il proprio zelo contro i suoi compatrioti – ti spiega che devi dire la verità, solo la verità, perché in America la menzogna è il peccato piú grave, peggio del furto. Ma purtroppo la verità non serve a loro e non serve a te. Perciò non dargli retta e racconta la storia che ti sei preparato. Credici, e pure loro ci crederanno. Guardali in faccia e giura. Giuro che non ho un contratto di lavoro (ma ce l’ha, lo zio Agnello lo manda a Cleveland a lavorare alle ferrovie). Giuro che mio zio provvederà al mio mantenimento per tutto il tempo che resto a Nevorco (questa poi è proprio grossa, perché Agnello è piú tirato del buco del culo di una pecora). Ma la commissione non è stata a sindacare. Aveva fretta: doveva esaminarne altri quattromilacinquecento, piombati sull’America come le cavallette della Bibbia nello stesso giorno in cui c’è piombato lui. I funzionari erano distrutti e hanno ricevuto l’ordine di allargare le maglie del setaccio. Ascoltavano distrattamente le risposte. E lui si è tirato su le brache e li ha fregati.
«Me fai male, Diamà», si lagna Vita. Le stringe il polso talmente forte che la pelle è diventata bianca. «Stamm’appresso», risponde Diamante. Con quel berretto in testa, sembra un soldato. Lei ubbidisce. Scendono tenendosi per mano, subito inghiottiti da una folla esagitata. Nel frastuono assordante di veicoli, fra il cigolio degli argani e delle catene, il fischio delle sirene e le urla dei passeggeri, c’è chi vende passaggi alla stazione ferroviaria, chi un letto per la notte, chi acqua fresca, chi si offre di indicare la strada e chi cerca solo di soffiare un portafogli. I ragazzini che fumano appollaiati su mucchi di carbone hanno l’aria di voler accoltellare il primo meschino che svolta l’angolo. Diamante tiene il passaporto fra i denti – col consenso di suo padre all’espatrio stampigliato accanto ai suoi connotati. È talmente indaffarato a sgomitare che non sta a chiedersi come mai Vita non ciancica piú fra le labbra lo scontrino giallo. Quando i furfanti appostati sulla banchina realizzano che quei due ragazzini che si tengono per mano non vengono ritirati da nessuno, si slanciano verso di loro e si accapigliano per accaparrarseli. Cercano di allettarli, ma Diamante non si lascia infinocchiare. Punta i piedi e si tira dietro Vita, che sorride a tutti quelli ben vestiti che le sorridono – di tutti pensando: chisso è pàteme.
Non parlare con gli sconosciuti, – si era tanto raccomandato suo padre e Diamante aveva promesso di ricordarsene – non dare retta a nessuno, resta sull’isola e aspetta che lo zio Agnello venga a prendervi. Lui vi riconoscerà. Il problema è che Agnello non è venuto. O che Vita s’è stufata di aspettare. Nel salone c’era una baraonda. Ieri, 12 aprile 1903, dodicimilaseicentosessantotto persone sono sbarcate sull’isola. Continuavano ad attraccare navi, partite da Brema, da Rotterdam, da Liverpool, Copenaghen, Amburgo. Solo da Napoli ne sono arrivate tre. Solo dalla loro nave, il Republic, sono scesi in duemiladuecentouno. Non s’era mai vista un’invasione del genere, e i funzionari hanno perso la testa. I gruppi si intruppavano come pecore fra le passerelle, prima uno, poi l’altro, poi un altro ancora. Nella confusione, Vita s’è infilata dietro una zingara che si tirava appresso dieci figli. Diamante le è andato dietro. Se non l’aspetta lei Agnello, che è suo padre, perché mai deve aspettarlo lui? Sul traghetto la zingara s’è accorta di avere dodici figli ma non ha detto niente.
La folla li sospinge inesorabilmente in avanti. Hanno già superato le transenne, sono già davanti ai magazzini della White Star Line, dove i facchini scaricano le valigie e le accatastano in pile alte quattro, cinque metri. Ma non ci sono solo valigie. Ci sono ceste di tutte le dimensioni, fagotti di tela, sacchi sdruciti e rappezzati mille volte. Qualcuno, per timore di smarrire il bagaglio, ci ha scritto sopra, a caratteri cubitali, il suo nome. E adesso quei nomi – ESPOSITO, HABIL, MADONIA, ZIPARO, TSUREKAS, PAPAGIONIS – sembrano supplicare i loro proprietari di venirli a ritirare, per sottrarre agli sguardi degli altri la vergogna della loro povertà. Diamante sgomita e spinge, perché teme che la folla finisca per calpestarli. Si volta indietro. L’acqua ha il colore del granito, ma l’isola già non si vede piú. All’ennesimo spintone, ciò che resta delle treccine di Vita frana giú dalle orecchie. Diamante cerca di appuntarle di nuovo, ma lei non gli presta piú attenzione. Diamante ha fregato i commissari, ma lei ha fregato Diamante.
La prima cosa che Vita ha fatto in America è stata una magia. Era seduta nel salone dell’isola. Mogia mogia, perché dopo la notte nella scialuppa di salvataggio le è salita la febbre. Stranita, passava in rassegna i volti degli sconosciuti che sventolando il passi venivano a ritirare i parenti. Ceffi duri sormontati da coppole, musi tagliati nella pietra, baffi a manubrio e a coda di topo, nasi a uncino, occhi di pece e acquamarina, pelli di cuoio e di alabastro, brufoli ed efelidi, mariti, nonni, suoceri, madri a...