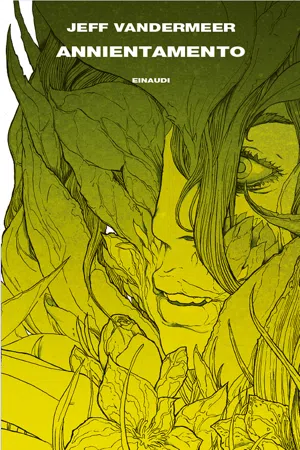Al mattino mi svegliai con i sensi amplificati, perfino la ruvida corteccia bruna dei pini o il normale volo ondeggiante di un picchio mi colpivano come una sorta di piccola rivelazione. La stanchezza persistente dei quattro giorni di marcia fino al campo base mi aveva abbandonato. Era un effetto collaterale delle spore o solo frutto di una bella dormita? Mi sentivo talmente riposata che non me ne importava.
Ma il mio stato di grazia fu subito ridimensionato da una notizia disastrosa. L’antropologa non c’era piú, dalla sua tenda erano scomparsi i suoi oggetti personali. Ma la cosa piú grave, secondo me, era che la psicologa sembrava scossa, e come reduce da una notte insonne. Strizzava gli occhi in maniera strana, ed era piú scarmigliata del solito. Notai che aveva gli scarponi incrostati di terra. Si teneva l’anca destra, come se si fosse fatta male.
– Dov’è l’antropologa? – chiese la topografa mentre io restavo indietro, provando a capirci qualcosa da sola. Che cosa ne hai fatto dell’antropologa? era la mia tacita domanda, un po’ ingiusta, lo sapevo. La psicologa non era affatto cambiata rispetto a prima; conoscevo il segreto del suo spettacolo di magia ma non per questo andava considerata una minaccia.
La psicologa frenò il nostro panico crescente con una strana dichiarazione. – Ho parlato con lei stanotte. Ciò che ha visto in quella… struttura… l’ha talmente innervosita che non ha voluto continuare la spedizione. È ripartita per il confine in attesa dell’estrazione. Si è portata dietro un resoconto parziale per far capire ai nostri superiori a che punto ci troviamo –. L’abitudine della psicologa a lasciarsi attraversare il volto da un sorrisino nei momenti sbagliati mi faceva venire voglia di prenderla a schiaffi.
– Ma non ha preso l’equipaggiamento… neanche la pistola, – disse la topografa.
– Si è portata solo lo stretto necessario per lasciare piú materiale a noi… compresa una pistola in piú.
– Credi che abbiamo bisogno di una pistola in piú? – le chiesi. Ero curiosa sul serio. La psicologa, per certi versi, mi affascinava quanto la torre. Le sue motivazioni, le sue ragioni. Perché adesso non ricorreva all’ipnosi? Forse malgrado il condizionamento implicito, ci sono suggestioni che non vengono recepite, o che perdono efficacia con la reiterazione, oppure gli avvenimenti della notte precedente le avevano tolto le energie.
– Credo che non sappiamo di cosa abbiamo bisogno, – rispose la psicologa. – Ma certo non dell’antropologa, se non è in grado di svolgere il proprio lavoro.
Io e la topografa la fissammo. La topografa stava a braccia conserte. Ci avevano addestrato a tenere i colleghi sotto stretta sorveglianza in modo da riconoscere eventuali segni di stress o disfunzione mentale. Probabilmente stava pensando quello che pensavo io: dovevamo scegliere. Potevamo accettare la spiegazione della psicologa riguardo alla scomparsa dell’antropologa, oppure respingerla. Respingerla voleva dire accusare la psicologa di averci mentito, e quindi respingere anche la sua autorità in un momento critico. E se avessimo tentato di percorrere il sentiero a ritroso, sperando di raggiungere l’antropologa per verificare la versione della psicologa… avremmo avuto voglia, dopo, di tornare al campo base?
– Dovremmo continuare col nostro piano, – disse la psicologa. – Dovremmo esplorare la… torre –. Vista la situazione, la parola torre mi suonò come una smaccata richiesta di fedeltà.
Eppure la topografa tentennava, come se lottasse contro la suggestione che la psicologa le aveva impartito la sera prima. Questo mi allarmò per un altro motivo. Non avevo intenzione di lasciare l’Area X senza prima esplorare la torre. Non ero minimamente disposta a rinunciarci. E poi, in quella situazione, non potevo sopportare l’idea di perdere cosí presto un’altra componente della squadra, ritrovandomi sola con la psicologa. Non ora che dubitavo di lei e non quando ancora ignoravo gli effetti delle spore sul mio organismo.
– Ha ragione lei, – dissi. – Dovremmo continuare la missione. Possiamo fare a meno dell’antropologa –. Ma il mio sguardo pungente alla topografa chiarí a entrambe che il problema dell’antropologa era solo rinviato a piú tardi.
La topografa annuí scocciata e si voltò dall’altra parte.
Sentimmo arrivare un sospiro di sollievo, o di stanchezza, dalla psicologa. – Allora siamo d’accordo, – disse, e passando davanti alla topografa si mise a preparare la colazione. Prima se ne occupava sempre l’antropologa.
Alla torre, la situazione cambiò di nuovo. Io e la topografa avevamo preparato zaini leggeri con viveri e acqua a sufficienza per passare l’intera giornata lí sotto. Tutt’e due eravamo armate. Tutt’e due avevamo indossato le maschere per proteggerci dalle spore, anche se per me era troppo tardi. Tutt’e due portavamo il casco con la lampada frontale.
Ma la psicologa si fermò sull’erba appena oltre la circonferenza della torre, leggermente piú in basso rispetto a noi, e annunciò: – Io rimango qui di guardia.
– A guardia di cosa? – chiesi io, incredula. Non volevo perderla di vista. La volevo immersa nel rischio dell’esplorazione, non ferma su in alto, con tutto il potere su di noi implicito in quella posizione.
Neanche la topografa fece i salti di gioia. Con tono quasi supplice che lasciava intendere un elevato grado di stress represso, disse: – Sei tenuta a venire con noi. Rischiamo meno in tre.
– Ma è meglio sapere che l’entrata è in sicurezza, – disse la psicologa, infilando una cartuccia nella pistola. Il raschio mandò un’eco piú stridula di quanto immaginassi.
La topografa strinse il fucile d’assalto fino a farsi sbiancare le nocche: – Devi venire con noi.
– Non c’è guadagno nel rischio di scendere tutte insieme, – disse la psicologa, e dall’intonazione capii che era un comando ipnotico.
La topografa allentò la stretta sul fucile. Per un attimo i lineamenti del suo viso persero definizione.
– Hai ragione, – disse la topografa. – Certo, hai ragione. È piú che logico.
Sentii una fitta di terrore lungo la schiena. Adesso eravamo due contro una.
Ci riflettei un istante, incassai lo sguardo della psicologa che stava concentrando l’attenzione su di me. Vidi scenari da incubo, da paranoia: io che tornavo e trovavo l’entrata bloccata, o la psicologa che ci abbatteva l’una dopo l’altra mentre riemergevamo in superficie. Sí, ma avrebbe potuto ucciderci nel sonno in qualsiasi notte della settimana.
– Non è cosí importante, – dissi dopo un momento. – Per noi sei preziosa quassú come lí sotto.
E cosí scendemmo, come la volta precedente, sotto l’occhio vigile della psicologa.
Notai subito che, al piano intermedio, prima di raggiungere le scale piú ampie che scendevano a spirale, prima di incontrare di nuovo le parole scritte sulla parete… la torre stava respirando. La torre respirava, e le pareti, quando andai a toccarle, trasmettevano l’eco di un battito cardiaco… e non erano di pietra ma di tessuto vivente. Quelle pareti erano ancora vuote, ma emanavano una specie di fosforescenza bianco-argentea. Mi sentii mancare il terreno sotto i piedi e sedetti di peso accanto alla parete; la topografa mi raggiunse e tentò di darmi una mano a tirarmi su. Quando finalmente mi alzai stavo tremando, credo. Non so se sono in grado di rendere a parole l’enormità di quel momento. La torre era una sorta di creatura vivente. Stavamo scendendo all’interno di un organismo.
– Che c’è? – mi stava chiedendo la topografa, la voce smorzata dalla maschera. – Che è successo?
Le presi la mano, gliela schiacciai contro la parete.
– Lasciami! – Cercò di divincolarsi, ma io la tenevo ferma.
– Lo senti? – chiesi implacabile. – Lo senti o no?
– Ma cosa dovrei sentire? Di che parli? – Ovviamente era spaventata. Per lei, mi stavo comportando in maniera irrazionale.
Ma io continuai a insistere. – Una vibrazione. Una specie di battito –. Le liberai la mano, indietreggiai di un passo.
La topografa fece un sospiro lungo, profondo, e tenne la mano appoggiata alla parete. – No. Forse. No. No, niente.
– La parete. Di che cosa è fatta?
– Di pietra, è logico, – rispose. Alla luce proiettata dal mio casco, il suo viso in ombra appariva scavato, con gli occhi grandi, cerchiati di buio, la maschera lo faceva sembrare privo di naso e bocca.
Feci un respiro profondo. Avrei voluto raccontare tutto: che ero stata contaminata, che la psicologa ci stava ipnotizzando molto piú di quanto immaginavamo. Che le pareti erano di tessuto vivente. Invece lo tenni per me. «Mi diedi una regolata», come diceva mio marito. Mi diedi una regolata perché dovevamo andare avanti e la topografa non poteva vedere quello che vedevo io, non poteva provare quello che stavo provando io. E io non potevo mostrarglielo.
– Lascia stare, – dissi. – Ho perso la bussola per un attimo.
– Senti, è meglio se adesso torniamo su. Ti stai facendo prendere dal panico, – disse la topografa. Ci avevano detto che durante la permanenza nell’Area X forse avremmo visto cose che non c’erano. Avrà senz’altro pensato che stesse capitando anche a me.
Sollevai la scatola nera che portavo alla cintura. – No, non sta lampeggiando. Tutto a posto –. Era una battuta, una spiritosaggine, eppure…
– Hai visto qualcosa che non c’era –. Non aveva intenzione di farmela passare liscia.
Sei tu che non vedi cosa c’è, pensai.
– Può darsi, – ammisi, – ma non sarà importante anche questo? Non bisognerà tenerne conto, quando faremo rapporto? Magari è importante se io vedo una cosa e tu no.
La topografa ci rifletté un momento. – Adesso come ti senti?
– Bene, – mentii. – Non vedo piú niente, – mentii. Il mio cuore era come un animale intrappolato nel petto che cercava di sgusciare fuori. La topografa era circonfusa dalla fosforescenza bianca delle pareti. Non era svanito proprio niente. Era ancora tutto lí.
– Allora proseguiamo, – disse la topografa. – Ma solo se prometti che mi avvisi, se vedi ancora qualche stranezza.
Ricordo che mi venne quasi da ridere. Qualche stranezza? Tipo delle oscure parole su una parete? Scritte fra minuscole comunità di creature d’origine ignota?
– Promesso, – dissi. – E tu farai altrettanto con me, d’accordo? – Per rovesciare la frittata, lasciare intendere che poteva succedere anche a lei.
– Non mettermi piú le mani addosso, se no ti faccio male, – rispose.
Feci di sí con la testa. Non le piaceva sapere che ero fisicamente piú forte di lei.
Sulla base di quell’accordo viziato procedemmo verso le scale e cominciammo a scendere nell’esofago della torre, nelle sue profondità, che ora si rivelavano attraverso una sorta di galleria degli orrori della biodiversità talmente splendida da non riuscire a starle dietro. Ma ci provai, come facevo sempre, sin dagli esordi della mia carriera.
La mia mania, il posto che mi veniva sempre in mente quando mi chiedevano perché fossi diventata una biologa, era la piscina nel giardino incolto della casa in affitto dove sono cresciuta. Mia madre era un’artista tormentata che aveva ottenuto un certo successo ma che amava un po’ troppo la bottiglia e faticava sempre a trovare nuovi acquirenti, papà invece un ragioniere sottoccupato, specializzato in piani per facili guadagni che di solito non fruttavano nulla. Nessuno dei due sembrava possedere la capacità di concentrarsi su qualcosa anche solo per un secondo. A volte mi sembrava di essere stata data in affido anziché essere nata in quella famiglia.
Non avevano né la volontà né la voglia di pulire la piscina a forma di rene, anche se era piuttosto piccola. Subito dopo il nostro trasloco in quella casa, l’erba intorno ai bordi cominciò a crescere troppo. Il falasco e altre piante altissime presero il sopravvento. I cespugli bassi lungo la recinzione schizzarono in alto finendo per coprire la rete metallica. Le fessure tra le piastrelle del vialetto che girava intorno alla piscina si riempirono di muschio. Il livello dell’acqua salí un po’ alla volta, alimentato dalla pioggia, e le alghe intorbidarono la superficie. Le libellule perlustravano la zona senza sosta. Arrivarono le rane toro, i puntini guizzanti e deformi dei loro girini diventarono una presenza fissa. Insetti e coleotteri acquatici iniziarono a sentirsi a casa loro. Pur di non liberarmi del mio acquario da cento litri d’acqua dolce, come volevano i miei genitori, lo svuotai nella piscina e alcuni pesci scamparono al trauma. Cominciarono ad arrivare gli uccelli del posto, come gli aironi e le egrette, attratti dalle rane, dai pesci e dagli insetti. E poi, chissà per quale miracolo, vennero ad abitarci delle piccole tartarughe, anche se non avevo idea di come ci fossero arrivate.
A pochi mesi dal nostro arrivo, la piscina era diventata un ecosistema funzionante. Entravo lentamente dal cancello di legno cigolante e osservavo tutto da una piccola sdraio arrugginita che avevo piazzato in un angolo lontano. Malgrado una notevole e fondata paura di annegare, avevo sempre adorato stare vicino agli specchi d’acqua.
In casa, i miei genitori facevano tutte le cose caotiche e banali che di solito fanno gli esseri umani, alcune delle quali piuttosto rumorose. Ma io non avevo problemi a perdermi nel microcosmo della piscina.
Inevitabilmente, la mia fissazione provocò le inutili prediche dei miei genitori, preoccupati dalla mia introversione cronica, come se cosí potessero convincermi di avere ancora in mano la situazione. Avevo pochi amici (se non proprio nessuno), come mi ricordavano sempre. Sembrava che non mi sforzassi di averne. Avrei potuto guadagnare qualcosa con un lavoro part-time. Ma quando li informai che piú di una volta, come un riluttante formicaleone, mi ero dovuta nascondere dai bulli in fondo alle cave di ghiaia che si trovavano fra i campi abbandonati dietro la scuola, non seppero cosa rispondere. Neppure quando un giorno, «senza motivo», tirai un pugno in faccia a ...