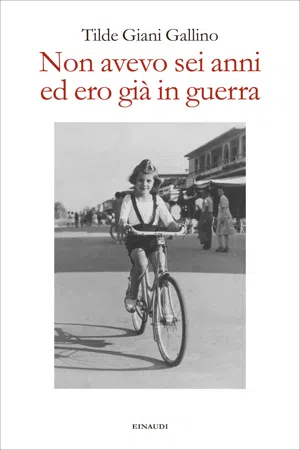![]()
A prima vista potrebbe forse apparire incoerente – dati i temi sinora trattati – dedicare un capitolo ad alcuni scrittori russi e soffermarsi su qualche opera in particolare, che qualsiasi lettore conosce. Tuttavia mentre parlo di loro, della vita e delle opere di taluni celebri autori tra i miei preferiti, e della società russa, in realtà racconto soprattutto del debito che ho sempre ritenuto di avere nei confronti di quegli scrittori, che hanno avuto una parte determinante, cognitiva, intellettuale ed emotiva, nel mio percorso da bambina ad adolescente, cioè la parte finale di questa autobiografia. Del mio Bildungsroman o romanzo di formazione. Senza accennare agli autori e alle opere che mi avevano tanto appassionata, non sarebbe stato possibile esprimere la profonda e significativa influenza che essi hanno esercitato su di me – sino a diventare miei eroi e modelli di vita – nella fase preadolescenziale, e oltre, durante la quale ho avuto la fortuna di incontrarli. Ancora oggi li ricordo con intensa ammirazione. Quegli scrittori descrivevano infatti in prevalenza – in forma di romanzo, racconto o poema, tutti straordinariamente avvincenti – l’arretratezza culturale e l’oscurantismo imposti dal dispotismo zarista, appoggiato da un’aristocrazia dissoluta e dallo stesso clero, o anche dalle legioni di burocrati che trascinavano la loro noiosa ma serafica esistenza negli uffici governativi1. Da ragazzina mi ero identificata, compenetrata con loro, non solo nei protagonisti dei romanzi, ma soprattutto nella lotta combattuta ad armi impari dagli scrittori contro gli zar, tiranni assoluti, nel tentativo di migliorare le condizioni di vita di quelli che venivano considerati gli strati inferiori della società: i servi della gleba.
Di zar in zar, gli scrittori che avevano l’audacia di raccontare della situazione miserevole in cui vivevano i contadini-servi, e del mantenimento di uno Stato feudale e dispotico, potevano venire rinchiusi nella fortezza di Pietro e Paolo a San Pietroburgo, e poi deportati per anni in Siberia. O magari impiccati, oppure forse uccisi in duelli che apparivano progettati ad hoc. Leggendoli mi indignavo, soffrivo con loro e mi facevo partecipe degli eventi narrati (sia pure accaduti in un altro secolo). Senza saperlo e in modo casuale, ero entrata in un universo a me sconosciuto, letterario ma reale, di cui scoprivo di volta in volta la grandiosità, la bellezza, l’intelligenza, la creatività e la fantasia. Ma insieme anche gli orrori e le crudeltà, le sopraffazioni. Il disprezzo per le vite degli altri.
Tutto era iniziato un pomeriggio piovoso mentre vagavo per casa. Avevo dodici anni o poco piú, e forse avevo rinunciato a uscire con le mie compagne di scuola non per la pioggia, ma perché sapevo già di che cosa si sarebbe parlato e quanto mi sarei annoiata passeggiando in centro con loro, su e giú lungo i portici di via Roma. Poi sono entrata in una camera dove non andavo mai. C’erano armadi profondi, a muro, che occupavano intere pareti, da terra al soffitto. Ho aperto un’anta a caso. Dall’alto al basso tutti i ripiani erano colmi di libri, nella maggior parte allineati in piedi, altri disposti in orizzontale sopra i volumi verticali perché non ci stavano piú, per dritto, sugli scaffali. Ho aperto lo sportello di un altro armadio: idem come sopra, salvo che questo era ancora piú ampio. Prima di prendere un libro in mano ho dato un’occhiata a qualcuno dei titoli scritti sui dossier, all’inizio un poco svogliata, poi via via piú attenta, per leggere il nome degli autori di quei libri riposti senza un ordine preciso: Puškin, Lermontov, Radiščev, Griboedov, Gogol′, Dostoevskij, Turgenev, Gončarov, Gor′kij, Černyševskij, Tolstoj, Ostrovskij, Krylov, Čechov…2. Una bordata di nomi sconosciuti che mi sono parsi curiosi, quasi esotici, e che mi hanno subito affascinata. Com’era che non sapevo nulla di quegli armadi e di quegli autori, e di tutti gli altri?
Ho preso un libro a caso fra i tanti che sembravano dirmi «prendimi, prendimi»: Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov (1879-80). Forse perché era uno dei piú voluminosi, oppure perché quel termine nel titolo, «fratelli», mi faceva sentire piú vicina al contenuto (che peraltro non conoscevo), dato che anch’io avevo un fratello. Ho portato il libro con me alla mia scrivania e ho incominciato a leggerlo. E praticamente non ho piú smesso per circa un decennio di leggere, uno dopo l’altro, come affamata o assetata, tutti o quasi i libri serbati in quegli armadi, e gli altri, in giro nelle varie librerie e negli scaffali di casa. Al mattino andavo a scuola ma, tornata a casa, mangiavo in fretta per ricominciare subito a leggere, rimandando a piú tardi i compiti da fare e le lezioni da studiare. Tenevo a portata di mano un quaderno o un libro di scuola in modo che, se mia madre si avvicinava per chiedermi a che punto ero con i compiti, potevo dimostrarle di essere intenta a farli, e intanto leggevo ogni opera con avidità, ma insieme con voluta lentezza, per farmi assorbire meglio da quell’atmosfera. Solo piú tardi mi sentivo costretta al mio dovere di scolara e con profondo rimpianto, quasi incapace di staccarmene, mettevo via il libro. Per recuperare, dovevo poi riprendere quaderni e testi scolastici e studiare sino a tarda sera. Aspettavo con impazienza la domenica perché avevo un’intera giornata a mia disposizione per leggere. Anche la mamma si stupiva e mi chiedeva: «Ma non esci piú con le tue amiche?»
Di volta in volta, a misura che leggevo mi identificavo in qualcuno dei protagonisti, oppure addirittura con l’autore. Quando, dopo averne già letti molti altri, a caso mi sono imbattuta in Maksim Gor′kij, mi sono davvero immedesimata in lui, intanto perché era rimasto orfano come me: anzi, lui non aveva ancora dieci anni quando aveva perso entrambi i genitori. Ma soprattutto, credo, a causa del cognome che aveva scelto per sé, Gor′kij, che in russo significava «l’amaro». Anch’io avvertivo in me qualcosa di amaro, di doloroso, per essere stata privata cosí presto di mio padre e della madrina. Una perdita che – come continuavo a rimuginare tra me – era assai anteriore alla loro morte, perché era avvenuta molto prima, nel 1942, quando la guerra e i bombardamenti avevano completamente rivoluzionato la mia esistenza: costretta a sfollare e a vivere in campagna, lontana da loro, in un «mondo altro». E al ritorno in città la mia vita non era mai piú stata quella di un tempo.
Il vero nome di Gor′kij era Aleksej Maksimovič Peškov, e lui stesso aveva raccontato quando era ormai famoso, in un libro intitolato Infanzia (1913), le varie difficoltà che sin da piccolo aveva dovuto affrontare e come era riuscito a superarle. Da adulto, considerato ormai un simbolo rivoluzionario, era stato arrestato, in questo caso dallo zar Nicola II, e inviato in Crimea. Leggendo altre sue opere autobiografiche, Fra la gente (1913) e Le mie università (1922), avevo ammirato il suo coraggio e la sua determinazione, tanto che nella mia preadolescenza e poi nell’adolescenza Gor′kij sarebbe diventato il mio primo modello, di crescita e di superamento degli ostacoli e delle avversità che la vita oppone a ognuno di noi. Ho sempre pensato di dovergli molto. Lui mi aveva incantata, sedotta: dopo aver letto uno dei suoi libri a caso, avevo cercato negli armadi tutti quelli da lui scritti, e ora facevo cosí anche con altri autori. Se un libro mi piaceva, e in pratica tutti mi piacevano, cercavo ogni opera di quello scrittore, curiosa circa i personaggi, i luoghi, la trama che aveva scelto e il modo in cui aveva sviluppato il racconto e ancor piú, per conoscere davvero a fondo quell’artista, vivere e dialogare con lui quasi mentre scriveva, e riprovare le medesime emozioni che già mi aveva trasmesso, o altre ancora.
In certi casi poi, come quando avevo letto I fratelli Karamazov, mi ero identificata sia con l’autore sia con uno dei protagonisti, Alëša, perché come me era il piú giovane dei fratelli, e anche il piú sensibile. Ma c’era qualcosa in piú che davvero ci assimilava: come io avevo pianto quando erano morti mio padre e prima ancora la mia madrina, cercando tuttavia di non mostrarlo agli altri, di tenere per me il mio dolore, cosí Alëša aveva tentato di nascondere le lacrime sotto un cappuccio, per la morte del monaco che era stato il suo maestro, il suo starec, «la persona che egli aveva amata sopra ogni altra cosa»3. Anche nella vita dello stesso Dostoevskij bambino, avevo però trovato altri eventi che mi accomunavano a lui: come quando aveva dieci anni e suo padre, un medico militare, aveva deciso di abbandonare Mosca, e tutta la famiglia era stata costretta a trasferirsi in uno squallido villaggio. Nel suo caso era stato il papà a prendere quell’infelice decisione, mentre a me era toccato a causa della guerra. Mi aveva inoltre colpita il fatto che nei suoi racconti diversi personaggi diventati anch’essi orfani, si fossero poi trasformati – come dicevano gli studiosi slavisti – in «sognatori solitari». Anch’io, a volte, mi sentivo cosí.
In seguito avevo davvero sofferto con lui leggendo il suo libro autobiografico, Memorie di una casa di morti (1861-62). Dostoevskij, che certo non sembrava un rivoluzionario, era stato arrestato dalla polizia zarista alle cinque del mattino del 25 aprile 1849, e rinchiuso nella terrificante fortezza di Pietro e Paolo di San Pietroburgo – solo perché presente alle riunioni di alcuni giovani socialisti – e piú tardi condannato alla fucilazione per «partecipazione a società segreta con scopi sovversivi». Poi lo zar Nicola I aveva commutato la condanna a morte in lavori forzati, ma per quanto la decisione fosse stata presa in precedenza, la grazia era stata comunicata dallo zar, per maggiore crudeltà, soltanto quando i condannati erano già davanti al plotone d’esecuzione, con i fucili puntati contro. Un trauma che aveva ancora peggiorato la vita, già difficile per motivi di salute, di Dostoevskij. Subito dopo era stato mandato in catene ai lavori forzati in Siberia (e allora non esistevano treni), insieme ai condannati per gravi reati, assassini, ladri, stupratori, nella fortezza di Omsk, in quella «casa dei morti» dove aveva trascorso quattro terribili anni. Piú tardi, nel 1854 era stato assegnato a un battaglione siberiano, il piú lontano possibile, addirittura vicino al confine cinese. Nel corso della sua vita Dostoevskij, anche se non piú in esilio, era poi sempre stato tenuto sotto controllo, spiato dalla polizia zarista anche durante i viaggi in Europa. Quanto ai suoi libri, venivano censurati prima ancora di essere pubblicati.
Dapprincipio avevo ritrovato le informazioni sui singoli autori nelle biografie e nelle premesse che accompagnavano ogni volume, a cura dei traduttori e degli editori. Mi ero tuttavia resa conto ben presto che non potevo soltanto leggere libri e libri presi dagli armadi, senza conoscere piú a fondo le particolarità della società in cui vivevano, e che raccontavano, quegli scrittori. Cosí avevo cercato e acquistato i pochi testi e i manuali che, all’epoca, era possibile acquisire sulla letteratura russa e la sua storia, e poi altrettante riviste, se le trovavo, che hanno molto ampliato le mie conoscenze4. Tutti gli esperti slavisti non mancavano comunque di sottolineare gli impedimenti statali e quelli della Chiesa ortodossa, che sin dal XVII secolo avevano ostacolato in vari modi la produzione letteraria russa, che si trattasse di racconti, narrativa, poemi, teatro5. Contrastare la cultura – spiegavano i commentatori – serviva a mantenere un dominio assoluto sulla maggior parte della popolazione, di per sé povera e ignorante, rendendola schiava. Difficoltà e restrizioni sarebbero poi diventate ancora piú opprimenti nei secoli successivi.
Un personaggio particolare, con il quale non mi sarei invece mai identificata, era Oblomov (1859), protagonista dell’omonimo romanzo di Ivan Aleksandrovič Gončarov. Lui, Il′jà Il′ič Oblomov, piccolo nobile di provincia, proprietario di una tenuta chiamata Oblomovka che comprende 350 anime, è l’eroe negativo del racconto. Vive in un palazzo di San Pietroburgo, perennemente sdraiato su un divano, avvolto in una morbida e logora vestaglia, tra disordine e squallore. Passa il tempo ad almanaccare nella sua mente importanti propositi e persino progetti di miglioramento, che non realizzerà mai, riguardo alla tenuta che è la sua unica fonte di reddito – ormai in mano a un amministratore infido. Del tutto opposto nel romanzo all’indolente Oblomov, è Andrej Ivanovič Stolz, l’amico dal nome tedesco: nome non casuale – spiegavano gli slavisti – simbolo dell’energia interiore che molti intellettuali russi attribuivano ai tedeschi e di cui deploravano la carenza nei propri concittadini. Stolz cerca con forza ma invano di scuotere Oblomov dalla sua ipocondria, insieme a Olga, la fidanzata che lui ama ma che non si decide a sposare.
In quegli armadi avevo inaspettatamente trovato il mio Eldorado, e ogni giorno realizzavo nuove, straordinarie scoperte. Le pagine scorrevano una dopo l’altra e quando si faceva tardi e i compiti di scuola non erano ancora terminati, anzi nemmeno iniziati, mi intimavo: «Adesso smetti!», poi mi ripromettevo: «Solo piú la prossima pagina, ancora una, l’ultima, poi basta», quasi come se fossi stata drogata dalla lettura di quei libri. Mi immergevo in ogni singolo romanzo di quei grandi scrittori, che mi avvincevano per le cap...