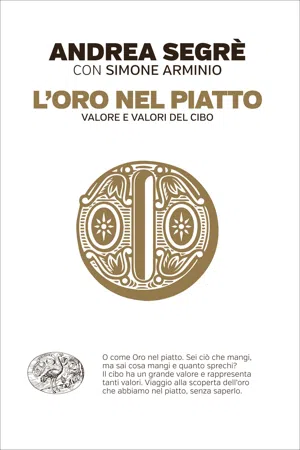![]()
Chi studia il cibo, oggi? Potrebbe essere questo l’incipit giusto per una ricerca che ha velleità di riscoprire il valore di ciò che mangiamo nelle nostre vite quotidiane. Magari partendo dalle materie prime, in molti casi le piante. Per prima cosa occorrerebbe ricostruire il contesto storico di un ambito di studi, quello di Agraria, che nei decenni è sempre stato abituato a cambiare forma, peso e interesse. Ecco, ad esempio, la voce di un vecchio agronomo: «Mi iscrissi ad Agraria nel 1938 perché rinnovare il lavoro nei campi facendo leva sulla scienza rappresentava una sfida per il futuro, riconosciuta molto anche dal regime fascista, che nel Ventennio aveva spinto cosí tanto sull’agricoltura. Ma oggi, mi dica, chi vi si iscriverebbe mai? Nel terzo millennio la tecnologia impera. Studiare le piante è rimasto un vezzo, un inutile gingillo, una nicchia per appassionati». Questa di Alfonso, classe 1921, napoletano, laureatosi nella storica facoltà di Agraria di Portici in piena Seconda guerra mondiale e intervistato nel 2001 da un giornale locale a testimonianza del crollo delle iscrizioni di quell’ambito di studi, era la vulgata nei primi anni Duemila. Tempi in cui, difatti, spopolavano le lauree del futuro: scienze della comunicazione, fisioterapia, biotecnologie. Comprensibilmente, a quei tempi, il rapporto tra iscritti effettivi ai corsi della facoltà di Agraria e i pretendenti a fare i comunicatori, sottoponendosi a durissimi test d’ingresso, superava l’uno a cinque.
Inutile dire che le cose sono cambiate. L’agricoltura, dicono gli esperti, è un settore anticiclico, che cresce quando gli altri vanno in recessione. In Italia, confermano le statistiche di Alma Laurea, nel 2014 l’ambito di studi agrari nel suo complesso è stato quello cresciuto di piú, mettendo a segno un +72% sull’anno precedente, contro il -21% di Economia (chi l’avrebbe mai detto, negli anni della new economy?) e dell’evergreen Giurisprudenza (-22%). A Bologna l’anno accademico 2014-2015 verrà ricordato come il primo in cui, per accedere a uno dei corsi dell’ex Facoltà di Agraria, oggi divisa in due dipartimenti, gli studenti sono dovuti passare da un test d’ingresso. E si badi bene: la parte del leone non l’ha fatta Tecnologie alimentari, ma il tradizionalissimo corso di Tecnologie agrarie. Nulla di troppo strano per Alberto Vicari, direttore del dipartimento di Scienze agrarie, che riconosce tra le cause «il fatto che sempre piú spesso, sui giornali e in tv, si parli di cibo», ma poi chiama in causa Andrea Segrè, preside della facoltà di Agraria dal 2005 (e fino a che la riforma dell’università non l’ha abolita, lasciando spazio alla scuola di Agraria e Veterinaria). «L’incremento degli studenti, – dice Vicari, – nasce dal lavoro di sviluppo e promozione fatto dalla nostra Facoltà in quegli anni. All’epoca gli studenti dei due dipartimenti non superavano i trecento. Oggi sono piú di un migliaio, e noi ci ritroviamo a dover programmare un test d’ingresso. Un’eventualità che pochi anni fa sarebbe sembrata fantascientifica».
Ma chi studia Agraria oggi, si diceva? Giovani appassionati di produzioni alimentari, ma anche adulti folgorati sulla via di Damasco in seguito a un radicale cambio di abitudini alimentari, oppure obbligati dalla crisi a rivedere certe priorità professionali. Quelli appena passati, diciamolo con chiarezza, sono stati anni in cui il vecchio pezzo di terra dello zio o la masseria del nonno, abbandonata da tempo, per molti hanno acquisito improvvisamente piú valore del master in finanza appena frequentato. Ma dove e in che modo si studia l’agricoltura? Per capirlo a Bologna, dove ha sede il piú antico ateneo del mondo, occorre prendere l’auto e lasciare la zona universitaria, fino a viale Fanin, in un’area frequentata oggi principalmente per la presenza di un centro commerciale. Siamo ai confini della città, dove gli ultimi palazzi lambiscono i campi di Granarolo, noti ai piú per il colosso del latte che ne porta il nome. Qui sorge l’ex facoltà di Agraria, oggi rappresentata da due dipartimenti. Uno di questi è diretto da Andrea Segrè, che vi insegna Politica agraria internazionale e comparata. Un’ottima location, si dirà, per chi studia la terra. Ma non è sempre stato cosí. Nel 1999, quando l’allora rettore dell’università, Fabio Roversi-Monaco, investí da queste parti per restituire la facoltà di Agraria ai campi e al verde, infatti, le proteste di docenti e studenti non si placarono per mesi. Lontanissimi dal centro cittadino, lontanissima la sede storica in via Filippo Re, dove la facoltà di Agraria ha avuto la sua sede a partire dal 1928, giusto a ridosso della pulsante via Zamboni, cuore della zona universitaria.
Dalle nuove aule di viale Fanin, invece, lo sguardo dà sui campi o, se si è piú fortunati, su Decathlon e il parco commerciale Meraville. Per arrivarci c’è da fare uno stradone a quattro corsie dove le auto corrono veloci. Un solo autobus urbano arriva fin qui, il 35, ma passa ogni mezz’ora e arriva al capolinea di Agraria dopo un giro tortuoso lungo la città. Per contrappasso, il giardino della vecchia facoltà, quella in pieno centro, da qualche estate è diventato il centro del mondo giovanile per via di un seguitissimo festival musicale estivo, chiamato Botanique per ricordarne gli antichi legami con le sue origini agrarie. In viale Fanin, a parziale soddisfazione delle coscienze, nessun mattone è stato posato per creare la nuova facoltà. Il palazzo in questione, infatti, c’era già. È una complessa struttura fatta di vetro, legno e mattoni rossi. Un palazzo che si sviluppa su tre lati, con davanti uno spazio verde e alle sue spalle il Caab, quel mercato ortofrutticolo che oggi è oggetto di un imponente progetto proprio su idea di Andrea Segrè, che ne è presidente.
L’assurdità è che l’insieme della facoltà di Agraria, del Caab e dei terreni circostanti di prossima edificazione, una volta, era un tutt’uno. Faceva parte di un progetto magniloquente, da ruggenti anni Ottanta, che avrebbe dovuto assicurare alla provincia di Bologna un fabbisogno di frutta e verdura fresche già del tutto antistorico a quei tempi. Era infatti già nato in città, in quegli anni, il Centro Borgo, primo grande centro commerciale con relativo ipermercato che, da lí a pochi anni, avrebbe avuto decine di cloni giganteschi in tutti i quartieri cittadini e nei comuni della cintura. Quel mercato ortofrutticolo, difatti, non è mai stato pieno. Oggi è vuoto per tre quarti, anzi, e quel centro direzionale – ben 40 000 metri quadrati – dove oggi ha sede la facoltà non ne fece mai parte. Rimase inutilizzato finché l’Università non decise di acquistarlo, pensando agli studenti di Agraria e alla necessità che perlomeno, oltre che in slide, potessero vedere dal vivo l’argomento dei propri studi.
Lo studio di Andrea Segrè è nell’ultimo civico, all’estremità destra del palazzone, insieme alle startup di Alma Cube, l’incubatore di imprese che l’Ateneo ha creato insieme alla locale Confindustria. Raggiungiamo il secondo piano, che si apre con un profondo corridoio arredato da romantiche cartine dell’Emilia-Romagna, in cui i campi e la produzione agraria sono ancora al centro dell’economia, quindi dell’attenzione del geografo, come avveniva negli anni Sessanta. La penultima porta è quella di Last Minute Market – la prima creatura del professore – che da tre lustri si occupa di prevenzione degli sprechi e di recupero dei cibi nei supermercati, nelle mense, in ogni luogo dove ci sono eccedenze. Il professore ci accoglie nel suo studio, tavolo sgombro e pc portatile, adatto a chi è abituato a cambiare spesso scrivania. Libri ai lati, premi e riconoscimenti vari e un unico vezzo incorniciato alle sue spalle: un articolo in bianco e nero del Piccolo di Trieste, la sua città natale, che per la prima volta nel 2006 lo ha scoperto e pontificato con un’intervista a tutta pagina intitolata: «Andrea Segrè, il triestino geniale che sfama i poveri» e con un incipit memorabile: «Togliere ai ricchi per dare ai poveri. Ma senza far torto ai primi».
SIMONE ARMINIO Professore, andiamo, il vezzo di prendere ai ricchi per dare ai poveri è vecchio quanto il mondo. Robin Hood, poi, un antesignano del settore, non faceva torto ai primi ma non si può dire che li vezzeggiasse. In piú c’è un dato: ai poveri non si può dare ciò che mangiano i ricchi. Sono cibi troppo sofisticati...
ANDREA SEGRÈ L’obiettivo, infatti, dovrebbe essere a monte: saper riconoscere anche il cibo “medio”, quello – per intenderci – che sta in mezzo ai due estremi piú noti fra i consumatori che mangiano troppo poco, gli affamati, oppure troppo, gli obesi. Nel mondo, oggi, si parla solo di questi estremi, il resto – che è tanto – non fa neppure notizia. Ciò senza considerare che mangiare troppo poco o troppo in ogni caso è malnutrizione, cioè mangiare male: per difetto o per eccesso. Vede, oggi siamo fin troppo pieni di nicchie di prodotti sani, puliti, giusti e oltremodo costosi. Portiamo avanti pratiche encomiabili (lo faccio anch’io) come quelle del chilometro zero, del biologico integralista e del “fatto a mano”, con tutti i crismi di una volta. Ma la considerazione, il dato vero, è che il cibo medio, nel senso di non troppo alto e non troppo basso in termini di qualità e di quantità, rappresenta l’unica speranza per sfamare dignitosamente il mondo. Capisco che dirlo non è popolare. Ma è cosí.
ARMINIO Allora medio nel senso di cibo popolare, che va bene per tutti? Con questo termine a me vengono in mente proprio le cose di una volta, quei cibi umili di cui si nutrivano e ci nutrivano i nostri nonni. Magari poco nutrienti ma di certo buoni e semplici. Dalle mie parti, ad esempio, va molto di moda la pasta e patate. Cotta con un filo di sugo di pomodoro e un po’ di formaggio. Una sciccheria che farebbe impazzire qualsiasi nutrizionista: ma come, carboidrati conditi con carboidrati? Amido piú amido? E, in effetti, non avrebbe tutti i torti.
SEGRÈ Il mio concetto di cibo medio, né troppo né troppo poco dal punto di vista quantitativo, è anche nel senso di equilibrato, giusto ed equo. Rispetto a popolare, l’aggettivo medio mi pare piú corretto, piú comprensibile: rappresenta meglio quei beni alimentari che stanno sotto le nicchie di alta qualità ma ben sopra il cibo spazzatura, che invece dobbiamo respingere come la morte perché porta proprio alla spazzatura. Cerco di spiegarmi. Posto che anche i piú accorti di noi non possono nutrirsi di solo biologico e a chilometro zero, il che sarebbe impossibile almeno nel breve periodo, si è chiesto cosa affolla i nostri frigoriferi? Si tratta in larga parte di cibi prodotti, correttamente, dall’industria alimentare. Correttamente nel senso che corrispondono a determinati parametri di qualità e magari – se lo abbiamo selezionato ponendo un minimo di attenzione alle etichette e alla provenienza – con un’attenzione piú alta nei confronti delle materie prime. Apra il suo frigorifero e guardi cosa c’è dentro. Immagini di farlo in altri Paesi del mondo. È questo il cibo che troverà in larga parte.
ARMINIO Sí, d’accordo, questo vale per i prodotti confezionati, che si trasportano facilmente e anche si conservano meglio. Ma per frutta e verdura come la mettiamo? Deperiscono in fretta, il processo industriale non è cosí facile. O mi sbaglio?
SEGRÈ È vero, per questi prodotti il discorso è diverso. Prendiamo la frutta: io faccio fatica ad appassionarmi alle banane, vede, perché mi impressiona la lunghezza della strada che devono percorrere per arrivare sulla mia tavola. Un percorso intercontinentale, e che per questa sua caratteristica non può fare a meno di essere strutturato secondo criteri di gestione “multinazionale” del cibo, criteri che non ci appartengono. È una considerazione, quella sulle banane, che ho avuto ben chiara qualche settimana fa, in montagna, risalendo a piedi un sentiero d’alta quota. Quando vado in montagna, in genere sto molto attento a ciò che vedo lungo il percorso, perché ogni segno del passaggio dell’uomo è indice delle differenti abitudini alimentari e sociali delle persone, dell’attenzione e del rispetto per la natura. Ecco, quella volta ho incontrato una buccia di banana abbandonata con discrezione alla base di una roccia, per nasconderla alla vista e far sí che qualcuno non ci scivolasse sopra. Un comportamento corretto, in ogni caso, abbandonarla lí, visto che la buccia di banana è ciò che di piú biodegradabile possiamo trovare in natura.
Mi ha fatto sorridere, comunque: il buon scalatore non aveva considerato un particolare che il tempo, invece, ha consegnato al mio passaggio. Alla buccia di banana, ormai quasi del tutto degradata, era sopravvissuto un fulgidissimo marchio Chiquita, prodotto in chissà quale lato del mondo e impossibile da biodegradare pure al forte sole del Monte Rosa. È solo un esempio, utile a porci una domanda: qual è l’alternativa all’esportazione di massa di un frutto che viene prodotto cosí lontano da noi? Le banane sono buone, si dirà, nutrienti e benefiche perché ad alto contenuto di potassio. Inoltre in molti le scelgono per la loro praticità: si sbucciano facilmente, non colano come una pesca e perciò possono essere mangiate senza sporcarsi e sporcare. Ma per farle arrivare da cosí lontano e soprattutto per essere in grado di diffonderle in tutto il mondo, obblighiamo intere regioni del Sud del pianeta a una monocoltura che toglie cibi e risorse agli abitanti del luogo e soprattutto, per sostenere il prezzo del viaggio senza che ciò faccia lievitare a dismisura il costo di ogni singola banana nei nostri supermercati, siamo costretti a pagarle una nullità a chi le produce, innescando uno sfruttamento capestro nei confronti dei produttori locali. Dovremmo fare da noi, consumare sí banane, ma in quantità ridotta, e far crescere nel frattempo il consumo delle nostre colture. Ma qual è l’alternativa pulita ed economicamente sana alle banane e alla grande distribuzione organizzata della frutta? Di certo non può essere l’albero di nespole che piantiamo (o che qualche nostro avo ha piantato per noi) in giardino o nell’orto, posto che un pezzo di terra sia nelle nostre disponibilità immobiliari. E non può essere neppure soltanto la frutta che acquistiamo nei mercatini del chilometro zero, la cui produzione, trasporto e vendita diretta offre per contro due svantaggi: toglie le braccia di quell’agricoltore al lavoro nei campi per molte ore, costringendolo a pensare anche alla distribuzione e alla vendita, oltre che alla produzione, e soprattutto non gli permette di agire sulle quantità per rendere il suo lavoro economicamente remunerativo.
In ogni caso: quante persone può servire un agricoltore col suo banchetto? E quante persone, viceversa, hanno la possibilità di trovare un banchetto di frutta lungo la loro strada e poter pagare qualche centesimo in piú per assicurarsi un prodotto di maggiore qualità? Ecco, allora, il bisogno sempre piú impellente di una soluzione di mezzo tra questi due estremi: l’impresa alimentare e la grande distribuzione da un lato e il chilometro zero e il piccolo agricoltore dall’altro. Scusi, ma io lo chiamo ancora cosí: agricoltore, anzi imprenditore agricolo. Quando sento parlare di “contadini” ho l’impressione che non si tenga conto del reale significato di questo termine, portandoci a una visione nostalgica dell’agricoltore, a un richiamo della tradizione. Invece l’etimo stesso della parola è molto chiaro: “conte”, “contea”, “contado”, ovvero il dominio storico del proprietario terriero sui lavoratori. Ci sono ancora “contadini” cosí nei paesi in via di sviluppo. Anche in prospettiva, meglio dunque sarebbe parlare di “agricoltori”, termine che si coniuga con tanti attributi: imprenditori, giovani, part-time...
È il cibo medio che vorrei considerare, quello di cui non si parla mai ma che sfama o potrebbe sfamare il mondo. E badi bene che il discorso non vale soltanto per la frutta ma per tutto ciò che mangiamo e per tutta l’industria alimentare. Fatta di prodotti realizzati su larga scala e attraverso l’utilizzo di tecnologie e macchinari, ma non per questo del tutto privi di qualità. Basta saper scegliere, e usare bene anche le parole.
ARMINIO Il suo ragionamento ha molti punti ancora in ombra. Prima di tutto non esiste soltanto il chilometro zero da considerare. E poi in molti, ormai, quando acquistiamo un prodotto, ci siamo abituati a leggere l’etichetta e a considerare, oltre alla distanza di produzione, anche la tipologia delle materie prime utilizzate, il produttore, la presenza di conservanti o coloranti e la presunta eticità del marchio che stiamo acquistando. Ma non basta a cambiare lo stato delle cose: tutti, presto o tardi, siamo avvezzi a cedere, a cercare il compromesso tra l’etico e il buono, tra il sano e il sottocosto, tra la qualità e la quantità. I tempi, d’altronde, sono quelli che sono. C’è crisi e la spesa alimentare continua a essere la voce piú importante nei bilanci familiari. In piú è ancora molto facile, nonostante l’etichetta, lasciarsi condizionare dalla confezione. Che dev’essere pratica, sana, facilmente smaltibile, sufficientemente biodegradabile e possibilmente anche bella e colorata. Vogliamo la luna, non le sembra?
SEGRÈ Quest’ultima considerazione sulle confezioni mi riporta a un’esperienza di qualche tempo fa. Ero invitato alla piú importante fiera europea delle macchine per imballaggi, a Düsseldorf, in Germania. Facendo un giro tra gli stand il colpo d’occhio era impressionante: oggi, al contrario di quel che si pensa, il packaging è sostenibile, smart, ecologico, leggero. Contiene, protegge, trasporta, allunga la vita, porziona, addirittura parla quando si legge cosa c’è scritto sulle confezioni. Meraviglioso. Ma, ho chiesto ai produttori di contenitori che mi ascoltavano, avete mai pensato al contenuto? A cosa si mette dentro a questi straordinari contenitori? È un bel paradosso, se ci pensa: cosa me ne faccio di una confezione iperintelligente, tecnologica e di design se poi servirà per contenere del cibo spazzatura? Sarà valsa davvero la pena studiare e approfondire il mantenimento della qualità dei cibi se quella qualità, a monte, non c’è? Vede, fino a oggi l’imballaggio, la confezione, il packaging è uno “strumento” servito alla grande industria alimentare e alla distribuzione piú che a proteggere il prodotto, come nelle sue funzioni, a invogliarci nell’acquisto. Sugli scaffali dei nostri supermercati, capisce, oggi ha piú peso il contenitore che non il contenuto. E talvolta il contenitore è davvero troppo pesante. Perciò, in quell’occasione, la domanda che ho fatto alla platea delle aziende di packaging è stata: vi siete mai posti il problema di cosa c’è dentro al vostro meraviglioso contenitore? Avete pensato che realizzare degli involucri sempre piú perfetti e all’avanguardia può essere encomiabile se isoliamo il vostro prodotto ma diventare inutile se il contenuto per cui è nato non ha avuto la stessa cura? C’è uno scollamento troppo evidente, oggi, nel cibo, tra l’immagine e l’essenza, ciò che sta fuori e ciò che sta dentro. Del resto, dopo la mia conferenza ho fatto un giro nei padiglioni della fiera. In uno di questi ho trovato un manifesto bellissimo di una delle piú importanti multinazionali alimentari dove veniva illustrato il “valore condiviso” lungo la filiera alimentare, un pomposo bilancio di responsabilità sociale. Nella parte del packaging, naturalmente piú che sostenibile, c’era a mo’ di esempio la fotografia di un contenitore alimentare magnificato, ça va sans dire, in tutte le sue componenti tecnologiche. Peccato che proteggeva, si fa per dire, gli spaghetti po bolońsku DoReMi per bambini. Aiuto!
Ed ecco l’aspetto paradossale del cibo spazzatura: lo compriamo credendolo buono e soprattutto immodificabile, come fosse un prodotto perfetto al pari della scatola che lo contiene. Poi, a casa, lo scopriamo cattivo, facilmente deperibile. E il piú delle volte – senza pensarci troppo – lo buttiamo, come dimostrano i dati che stiamo elaborando con il nostro Osservatorio Waste Watcher. Il cibo spazzatura finisce nella spazzatura insieme alla sua scatola, indifferenziato: ma che senso ha?
ARMINIO Sarà dura convincere i produttori mondiali e le multinazionali del cibo di quanto afferma, professore. Ma, se volesse tentarci, di certo questo è il momento giusto. L’Italia ospita l’esposizione universale che, manco a dirlo, ha come tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. E noi italiani saremo gli ultimi della classe ma tutto il mondo ci riconosce perlomeno una certa autorevolezza in termini di cibo. Il che, ci perdoni, ha un risvolto economico non da poco. Se fossimo noi, con la nostra enogastronomia, a nutrire il pianeta, non sarebbe per nulla male, di questi tempi, per l’economia italiana. E d’altronde Oscar Farinetti va ripetendo in lungo e in largo che oltre le Alpi e il mar Mediterraneo c’è un mondo intero che brama di mangiare cibo italiano. Quel Farinetti che lei stesso ha coinvolto nella realizzazione di F.I.CO - EatalyWorld a Bologna, un immenso parco agroalimentare dotato di tutte le filiere, dal campo di grano duro al piatto di pasta, tutte riunite in un solo luogo, qui dietro al suo studio, all’interno del mercato ortofrutticolo. Un progetto, si legge sui giornali, con il quale la città della buona tavola, Bologna la grassa, si candida a diventare capitale internazionale del cibo. Ce lo auguriamo tutti, ma resta intatto il dubbio: l’enogastronomia e l’agroalimentare di qualità saranno mai in grado di sfamare il pianeta?
SEGRÈ Oscar Farinetti ha ragione quando parla della straordinaria richiesta di cibo italiano che arriva dal mondo. E soprattutto Farinetti, con i suoi ristoranti e punti vendita Eataly in tanti Paesi, da un continente all’altro, è tra le poche persone che ha davvero il polso della situazione sul consumo e l’apprezzamento del cibo italiano. È per questo che abbiamo deciso di coinvolgere lui per la realizzazione del parco tematico agroalimentare, che non a caso si chiama EatalyWorld-F.I.CO (Fabbrica Italiana Contadina, nome proposto da Farinetti quando lo abbiamo incontrato). Lo abbiamo pensato proprio in staffetta con Expo e in linea con l’obiettivo importante e complesso che si è posto: nutrire il pianeta. La domanda che ne consegue è lecita e stringente: è davvero possibile nutrire il pianeta tenendo ferma la barra della qualità? Si può dar da mangiare ai troppi poveri con il cibo rubato ai pochi ricchi? Anche Robin Hood, ci dicevamo, se avesse di fronte un problema di queste dimensioni, sarebbe chiamato a cambiare strategia, a cercare altre soluzioni. Ciò che io dico è: attenzione al tipo di soluzione che cerchiamo, perché fino a oggi, occupandoci del problema, lo abbiamo affrontato nel modo piú sbagliato. Pensi ai tanti prodotti idrosolubili pensati finora, agli integratori in pillole e, per ultimo, al mito del beverone nutriente, capace di assicurare il fabbisogno energetico quotidiano di un essere umano con pochi euro. Siamo onesti: non potrà mai essere una soluzione. Il cibo resterà sempre qualcosa che mangiamo per sentirci vivi oltre che per mantenerci in vita. E i due problemi, giocoforza, saranno sempre correlati. Ciò che abbiamo fatto finora, invece, andava da tutt’altra parte: agire sul lato psicologico e sociale tenendo bassa, bassissima, la sfera della salute. Sfamare a poco anche se ciò che mangiamo ci farà piú male che bene. Due strade opposte che non fanno altro che divaricare i due lembi di mondo attuali, quello dei troppo poveri e quel...