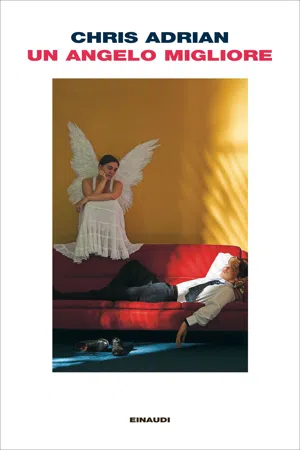![]()
Nel novembre di cui parlo ho nove anni e rubo: dolciumi al supermercato, giocattoli all’emporio, libri in libreria. Ma non titoli come George mano morta il curiosone, o Racconti di uno stronzetto di quarta, benché sia in quarta e sia uno stronzetto. Sono troppo intelligente per leggere libri cosí e troppo intelligente per essere in quarta, ma la mamma non vuole togliere alla scuola il piacere della mia presenza. Sono troppo intelligente per Miami Springs, e troppo intelligente per il mio stesso bene.
Nel novembre del 1979 sono alto circa un metro e mezzo e papà è morto da nove mesi. Il mio fratellino è matto e io qualche volta vorrei avere il dominio del mondo. Ho nove anni, ma in realtà non li ho. Di sangue, di cuore e di ossa sono antichissimo. A volte mi sento saggio come un faraone. Sono in classe e sto ascoltando Miss Ouida Montoya che ci legge ad alta voce:
Notti selvagge – Notti selvagge!
Fossi io con te
Notti selvagge sarebbero
la nostra passione1.
E prosegue, concludendo con la stessa passione con cui ha cominciato. Quando finisce ha il fiatone. – Qualcuno mi sa dire chi l’ha scritta? – chiede, nel silenzio generale. Non è la nostra vera maestra, è solo la supplente che ci hanno dato dopo l’incidente di Miss Orton con l’autobus.
– Nessuno? – Oggi è la prima volta che ci rifila poesia. Ieri abbiamo passato quasi tutto il tempo a costruire tacchini coi piatti di carta e pupazzetti di pellegrini coi bicchieri per l’imminente festa di Thanksgiving che, come ogni anno, si svolgerà in sala mensa e durante la quale intoneremo gli inni di ringraziamento fra una portata e l’altra di hamburger di tacchino, mais in scatola e budino di zucca. L’altroieri aveva allungato la lezione di spagnolo leggendoci tutto il giorno la storia in traduzione del topolino in motocicletta. – Allora? – insiste.
– Lo chieda a Con, – risponde Maria Josiah, una bambina di Hialeah con la testa a martello.
Risatine soffocate in tutta la classe. Buddy Washington, seduto dietro, dà un calcio alla mia sedia. – Mostro, – bisbiglia.
– Allora, Con? – chiede Ouida Montoya.
– Allora cosa? – dico io, con voce tagliente e stronzetta.
– Mi sai dire chi ha scritto questa poesia?
– Non siamo un po’ piccoli per questa roba?
La maestra mi guarda, poi si leva gli occhiali. – Devi sapere, Con, che stamattina mi sono svegliata di ottimo umore, e ho pensato: «Oggi voglio lasciare un segno. Voglio entrare in classe e lasciare un segno. Voglio usare questo breve periodo di supplenza per cambiare un pochino la vostra vita. Un pochino appena» –. Fa schioccare le dita molto piano, al punto che quasi non lo sento. – E che c’è di meglio di un po’ di poesia, per cambiare un po’ le cose? – Mi sorride, di un sorriso dolce e sincero, puntando i denti dritto verso di me.
– Ma la poesia non fa succedere nulla, – dico io. Lei si rimette gli occhiali e alza la testa come incuriosita da un buon odore.
– Chi ha scritto la nostra poesia? – La nostra poesia, penso io, ma capisco al volo che per lei non è cosí.
– Due volte si è chiusa la mia vita, – dico, – prima di chiudersi. Ora non mi resta che attendere…
Il sorriso della maestra si allarga ancora di piú – talmente tanto che il labbro superiore finirà per avvolgerle il naso, mi dico –, e cambia l’incrocio delle gambe. Nel silenzio si sentono le due superfici di nylon che strusciano l’una contro l’altra.
– Se l’immortalità mi sveli… – continua lei.
– Un terzo evento… – aggiungo io.
– Immenso…
– Inimmaginabile, impossibile…
– Come questi, due volte accaduti. La separazione è tutto ciò che sappiamo del Cielo…
– E tutto ciò che ci basta sapere dell’Inferno.
Maria Josiah scoppia a ridere: – Con ha detto «inferno»! – Si mette la mano davanti alla bocca, manco ci avessi mandato lei. Il resto della classe si limita a fissarmi come fossi un alieno e a guardare Ouida Montoya in trepida attesa della sua mossa successiva.
– Miss Emily Dickinson, – dice. – Ecco chi ha scritto queste poesie! Avanti, ripetete con me: Emily Dickinson!
– Emily Dickinson! – esclamano tutti, con voce un po’ tremula.
– Molto bene, – dice lei. – Vogliamo ascoltarne un’altra? – Aspetta finché si alza una mano. – Sí, Maria?
– Perché invece non finiamo i tacchini?
– È una possibilità. Mettiamola ai voti.
I tacchini vincono ventiquattro a zero; io mi sono astenuto. Cosí tiriamo fuori i mezzi tacchini che avevamo precedentemente ritagliato dai piatti di carta e passiamo il resto della lezione a spillarli insieme e a colorarli. Serviranno alla festa come segnaposto, ma sul mio scrivo: Buon compleanno culo triste, stronzetto che non sei altro. Che cos’ha di speciale un compleanno? Fattene una ragione, rompicoglioni. I tuoi piagnistei mi bruciano il buco del culo. Non fanno accadere niente, i compleanni. Sopravvivono nella valle del loro dire.
Sono cosí concentrato nel mio lavoro, a disegnare ogni lettera in un colore diverso e quel genere di vaccate lí, che quando Ouida Montoya si avvicina non mi accorgo della sua presenza finché non capisco che l’odore di antipulci che sento sopra la testa è il suo profumo. Copro il tacchino con una mano, ma lei la sposta per leggere le ultime righe.
– È tutto cosí difficile, – dice, chinandosi a mettere un trattino fra culo e triste con la sua penna rossa di supplente.
Durante l’intervallo me ne sto in cima a una casetta, a cui non si avvicina nessuno quando ci sono io. Guardo di sotto i bambini che giocano e penso: «Ehi tu, Maria Josiah! A morte! Una rasoiata sull’occhio per te, Maria!»
«Buddy Washington, a te tiro una bella badilata in testa, cosí forte da farti schizzare marmellata di lamponi dal naso!»
«Molly LaRouche, a te metto la testa in una ganascia!»
«Sammy Fie, ti cospargo di miele e ti do in pasto alle api!»
«Rosetta Pablo, ti faccio mangiare da un cane coi denti smussati!»
Nome per nome, passo in rassegna l’intera classe. Trascorro cosí l’intervallo. Quando sono piú o meno tutti morti, mi appendo a testa in giú e chiudo gli occhi, finché non sento avvicinarsi qualcuno. È Yatha McIlvoy, che tra l’altro è l’unica a cui di solito risparmio la vita.
– Buon compleanno! – mi dice. – Ti ho fatto una cosa –. Mi porge un pellegrino. Sopra c’è scritto: Pellegrino per il compleanno di Con.
– Come facevi a sapere che era il mio compleanno?
– L’ha detto Miss Orton la settimana scorsa, non ti ricordi?
Arriva Ouida Montoya. È in pieno sole. Dalla mia posizione sembra un aereo nemico in avvicinamento. Posa una mano sulla spalla di Yatha.
– Mi lasci parlare un attimo con Con, Yatha?
– Certo, – risponde Yatha, e si allontana camminando a ritroso. Dopo qualche metro mi saluta con la mano, si gira e corre via.
– Posso venire vicino a te?
– No, – rispondo io, e mi tiro su. Sono di nuovo seduto in cima quando lei mi raggiunge.
– Non sei felice, – mi dice.
– Sto benissimo.
– Scusa se ieri mi sono dimenticata del tuo compleanno, – dice ancora.
– Non m’importa.
– Qui c’è scritta un’altra cosa –. È il tacchino di carta, che avevo strappato in otto pezzi e buttato via. Lei l’ha rimesso insieme con il nastro adesivo.
– Non è per lei, – dico. – Non m’importa di lei, signora. È mia madre che se n’è dimenticata.
– Ah! – esclama lei. – Povero Con.
– Ehi! – dico io. – Vaffanculo! – Mi aspetto che se ne vada o che mi trascini da suor Gertrude, la preside, come fa sempre Miss Orton. Invece rimane lí ferma, con la lunga gonna di seta che pende fra le sbarre.
– Ho detto vaffanculo, – ripeto. – Nessuno le ha chiesto di fare la buona samaritana col povero bambino triste senza compleanno.
Lei si appoggia indietro sulle mani e tira il mento piú su che può senza smettere di guardarmi.
– Sei uno stronzetto arrabbiato, vero? – Mi limito a ricambiare lo sguardo. Non che la ami particolarmente, ma poiché mi parla come se fossi un bambino vero, poiché è la prima persona in quel posto di una noia mortale a parlarmi come se fossi un bambino vero, mi succede qualcosa, me ne rendo conto. Un lieve sussulto, come uno spostamento dentro di me. Dice lei: – Dicevo davvero, prima. Questa mattina mi sentivo in estasi. Mentre guardavo la luce del sole inondare il pavimento di legno di casa mia ho detto ad alta voce: «Ouida Montoya, oggi aiuterai qualcuno». E non mi capita mai di parlare ad alta voce quando sono da sola. Mai. Perciò permettimi di aiutarti –. Distende il braccio e mi tocca la spalla: – Vuoi raccontarmi che cosa c’è che non va?
– Niente di speciale, – rispondo. – La mamma si è dimenticata del mio compleanno.
– No, c’è qualcos’altro, – dice lei. – Ho letto la tua scheda in segreteria –. Avvicina la sua faccia alla mia tanto che ci potremmo baciare. Notti selvagge, penso d’un tratto, e mi gira un po’ la testa. Cristo santo, signora, penso. È la vita: tutto qui. Indietreggio per scansarla, e oscillo all’indietro fra le sbarre fino a lasciarmi cadere a terra.
– Ci vediamo in classe, – le dico andando via, senza alzare lo sguardo.
– Andiamo a fare un giro in macchina, piú tardi! – mi grida dietro.
– Come vuole, – borbotto. Ho voglia di distruggere qualcosa, cosí prendo il pellegrino di Yatha e lo accartoccio, poi mi pento e cerco di rimetterlo in sesto, però lui continua ad avere un aspetto parecchio incasinato.
A casa, ieri, c’era un biglietto sul televisore:
Con e Caleb
Sono uscita con Milo a comprare plettri per chitarra e roba varia. Torno nel tardo pomeriggio. Nel posto segreto ci sono cinque dollari per cena.
Baci,
la Donna Misteriosa
Quando l’ho letto ho sentito una specie di pugnalata nella pancia dalle parti dell’appendice. Non me ne importa dei compleanni – è da quando ho tre anni che non me ne importa niente – eppure ho sentito una puntura dolorosa come se mi avessero fatto una fattura, e una vocina dentro l’orecchio che bisbigliava: «Se n’è dimenticata!»
Sono andato in camera mia e di Caleb, che stava dormicchiando nel letto a castello basso. Ho preso la rivista degli scout, «Vita di ragazzo», che avevo rubato per lui alla biblioteca della scuola, e gliel’ho messa addosso. Era un Lupetto, all’epoca in cui impazzí, sostenendo di venire da Marte, dove i fuochi si accendevano cosí e dove le gare di automobiline a pedali si facevano cosà, e dove tutto era di gran lunga superiore rispetto ai Lupetti in versione terrestre. Non sono contento che sia pazzo ma sono contento che l’abbiano espulso. Fra i due, avrei preferito se fosse stato una Brownie, una piccola scout fascista con le mutandine marroni, piuttosto che un Lupetto, ma nessuno dei due è ancora meglio.
Mi sono seduto di fianco al letto e l’ho guardato dormire. Aveva la faccia gonfia e gli occhi che roteavano sotto le palpebre. Ho svuotato la cartella sul pavimento. Avevo fatto un salto anche in libreria, dove avevo comprato Thuvia, fanciulla di Marte e il numero di ottobre di «Scientific American». Frieda, la proprietaria, all’inizio del mese mi vende a metà prezzo il numero del mese prima. È una lesbica. So che cosa vuol dire perché ho rubato nella sua libreria, che si chiama «Il professorino», Le gioie del sesso lesbico, Le gioie del sesso, Le gioie del sesso gay e Le gioie del sesso 2. Li ho nascosti sotto il materasso. Sfoglian...