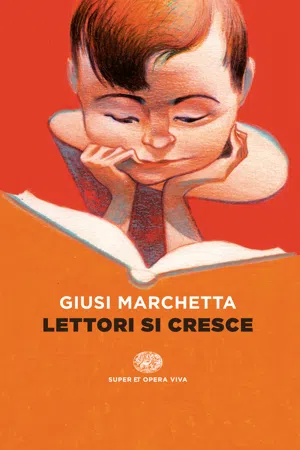![]()
Le fiabe sono vere. Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine fino a noi; sono il catalogo di destini che possono darsi a un uomo e a una donna soprattutto per la parte di vita che è appunto il farsi di un destino: la giovinezza dalla nascita che sovente porta in sé un auspicio o una condanna, al distacco dalla casa, alle prove per diventare adulto e poi maturo, per confermarsi come essere umano. E in questo sommario disegno, tutto.
Italo Calvino, Introduzione a Fiabe italiane.
![]()
L’argomento del mio romanzo sono io.
Michel de Montaigne, Al lettore.
La prima cosa che ho letto sono stati i muri della città. Non solo i manifesti, i cartelli stradali, gli annunci mortuari che mi servivano come allenamento per sveltire la procedura con cui accorpavo consonanti e vocali fino a dar loro un senso. Le scritte sui muri: quelle sbilenche, sgrammaticate, storte, misteriose, confuse descrizioni del mondo.
Qualcuno amava una ragazza; qualcun altro era morto molto tempo prima e andava ricordato. Un giovane camerata, un fascista. Un ultras morto sul suo motorino. Che Guevara poteva essere un nome o un’esclamazione. Gesú c’era e ci aspettava da qualche parte nei dintorni del sottopasso.
Sotto forma di macchia, di vandalismo, sui muri compariva la storia di una città viva che veniva fuori improvvisamente per manifestare un odio o un desiderio nascosti. Per questo le cercavo e ancora oggi le cerco; mi dicono che c’è qualcuno che viene o si sente oppresso, che è in atto una privatizzazione dell’acqua o dei trasporti pubblici, che «io e te tre metri sopra il cielo» può rappresentare una dichiarazione d’amore pratica e abbastanza universale. Mi dicono quello che mi suggerivano da bambina: che le parole hanno il potere di farci puntare lo sguardo su qualcosa e che se sono quelle giuste lo faranno di certo.
Per quasi un anno su un muro di Porta Palazzo ha campeggiato una scritta nervosa, in una vernice nera, sottile: denunciava la vergogna dei Centri di identificazione ed espulsione, minacciava la rivolta nella strada.
LA REVOLUTION DANS LA ROU
Per tutto un anno andando al lavoro, dal finestrino del tram ho guardato quella scritta come se fosse nuova ogni volta, finché una mattina lo è stata davvero. Durante la notte qualcuno aveva cancellato sotto una croce impietosa la parola rou sostituendola con rue. Aveva rischiato una multa o peggio solo perché voleva che il giorno dopo la scritta parlasse ai passanti in un francese corretto.
La vita a parole.
Henry Denies è un omino che lavora in banca. Ha le spalle basse, gli occhiali come binocoli, la vocetta stridula: lo sportello sembra quasi una gabbia che lo contiene come farebbe con un animale buffo offerto agli sguardi dei visitatori dello zoo. Ma questi che ha davanti non sono visitatori, sono clienti e hanno tutti una gran fretta di sbrigarsi. Henry però non lo capisce: si ferma ogni momento sul libro che sta leggendo di nascosto, tenta di raccontarne la trama a una signora visibilmente disinteressata e, bersagliato dalle lamentele, finisce nell’ufficio del capo dove, nel mezzo di un’umiliante strigliata, non può fare a meno di sbirciare le copertine dei giornali impilati sulla scrivania. Del resto non può fare altrimenti: pur essendo ciò che piú ama al mondo, a casa gli è proibito leggere. La sua sadica, nevrotica, dominante mogliettina, infatti, pretende attenzione e compagnia e passa le sue giornate a scovare i libri che lui nasconde per strapparli o buttarli via. Quella sera però, dopo l’ennesimo battibecco, succede un fatto incredibile: un’esplosione nucleare distrugge la città e probabilmente la nazione, cancellando dalla faccia della Terra tutti quelli che Henry conosce tranne lui.
(Di colpo cancella anche tutto quello che c’era intorno alla mia televisione, scolpendo nel mio immaginario di bambina una moderna visione dell’Apocalisse, un’ecatombe in bianco e nero, costruita non sul sangue e i cadaveri, ma sull’assenza e il silenzio, l’improvvisamente possibile esistenza di una zona Ai confini della realtà in cui perdere tutto senza rimedio).
Henry si dispera. Ovunque macerie e desolazione paiono ignorare le grida e i pianti di quest’ometto che si aggira frenetico tra le rovine della città. Finché non arriva sulla scalinata all’ingresso della biblioteca: collezioni intere di classici giacciono sparpagliate sui gradini aspettando di essere raccolte, ricomposte, lette. Finalmente privo di impedimenti, Henry può passare il resto della sua vita a leggere.
(Lo scioglimento della tensione nel mio stomaco e la scossa di felicità imprevista, che passa da lui a me, per un attimo mi sembrano un traguardo ottenuto meritatamente. Ce l’abbiamo fatta, dico all’attore sullo schermo, siamo sopravvissuti, e lo credo davvero finché non lo vedo inciampare e allora nel mio salotto tutto si perde di nuovo).
Henry inciampa e gli cadono gli occhiali. Le lenti spesse, brutte, ridicole con cui abbiamo identificato la sua faccia fin dalla prima scena, si rompono e diventano inservibili. Circondato da libri, ha tutto il tempo di leggere ma non ha gli occhi per farlo. Ora può urlare piú forte, di un dolore piú vero. Adesso, dal mio divano posso trasalire di un’infelicità profonda, completa: adesso, sono tutti morti.
Mi hanno detto che posso portare dei libri e che non me li toglieranno. Che mi perquisiranno, un passaggio di mani veloce lungo i fianchi, almeno le prime volte: niente cellulare, penne e altre cose vietate dal regolamento. Ma i libri non sono un problema per il carcere: non sono un’arma o un oggetto contundente. Non sono un pericolo.
Per questo arrivo con la borsa piena di King, Bradbury, qualche classico d’avventura, Dracula, Frankenstein e una manciata di fumetti. Poesie di Brecht e di Trilussa. La strada di McCarthy.
Mi hanno detto che il Ferrante Aporti non è come le Vallette, che un istituto penale minorile non è mai troppo carcere. Mentre nel cortile aspetto il mio turno per entrare ne cerco conferma nell’intonaco chiaro dei muri, nella gentilezza dell’agente all’ingresso, nelle persone che incrocio nel corridoio che parlano sottovoce e mi rifilano un’occhiata lunga, sospettosa.
Come programmato, il maestro viene a prendermi appena varco il primo cancello. Non sono una novità per lui: il Salone del Libro organizza da un po’ Adotta uno scrittore, una manifestazione destinata alle scuole di Torino, a cui il Ferrante Aporti partecipa già da qualche anno con le sue classi di alunni che arrivano, escono e vengono riportati dentro qualche mese dopo. È un uomo alto, con le spalle larghe e lo sguardo buono, non può che piacermi anche se ha ancora quel dubbio negli occhi, lo avverto mentre mi stringe la mano, mi invita a seguirlo, mi presenta agli agenti che devono farci passare, mi tiene aperta la porta, mi cerca una sedia, mi chiede se voglio il caffè; tutto con quella frase negli occhi, la perplessità che gli ha fatto scuotere la testa durante la prima riunione del progetto, quando lo hanno informato che sarei venuta nel settore maschile, il suo, e squadrandomi ha detto: «Mi dispiace, ma non credo che funzionerà».
E adesso che ci siamo me lo chiedo anch’io se funzionerò e come lui ho dei dubbi che cerco di zittire mentre mi mostra la scuola del Ferrante, una stanza con un tavolo largo e delle sedie, cartine alle pareti, un vecchio computer.
Mi hanno detto che quella di fronte era l’ala destinata alle ragazze, ma che le hanno tutte trasferite da qualche mese ormai, perciò affacciandomi vedo un edificio uguale a tanti altri, se non fosse per le sbarre.
– Lí, vedi? – dice, indicandomi il cortile vuoto. – Quando le ragazze avevano il passeggio li trovavi tutti incollati alla finestra.
Arrivano in cinque accompagnati da un agente di custodia. Lo chiamo «guardia», una prima volta, e lui precisa che si chiama «agente», devo dire cosí. Recupera una sedia e si piazza in un angolo: ci resterà per tutta la lezione.
– Allora, come andiamo? – chiede il maestro.
Due sono africani, poi ci sono un rumeno e un rom con una lunga cicatrice che gli scava una guancia. Avranno dai sedici ai vent’anni. Lo salutano stringendogli la mano, poi, con mia sorpresa, la porgono anche a me. Lo faranno sempre, all’entrata e all’uscita e quando un mercoledí di due mesi dopo D. si alzerà di scatto, arrabbiato, anche allora, prima di insistere per essere riaccompagnato in cella si fermerà un momento per farsi avanti e salutarci cosí.
Ci sediamo attorno al tavolo e il maestro mi presenta velocemente prima di lasciarmi la parola. Cerco qualcosa di gentile da dire sul fatto che mi piacerebbe parlare con loro soprattutto, magari leggere qualcosa o partecipare semplicemente a una tipica lezione.
– Ecco, a proposito – dice il maestro. Tira fuori un paio di fotocopie spillate da un lato. Un compito. – Non male, Stevan. Meglio la grammatica comunque.
Il ragazzo rom prende i fogli e stringendo gli occhi comincia a sillabare: – C-c-c-comp. Compren. Compre.
Sbuffa. Ci riprova.
– Com-prensi-one. Comprensione! Suf-sufficiente. Comprensione sufficiente.
Sorride, poi mi guarda e riabbassa la testa sul foglio.
– Nella testa leggo meglio. L’italiano a dirlo è difficile.
– E fare le pulizie negli appartamenti invece è facile – scherza il maestro.
Stevan però è serio.
– È facile se sei bravo – spiega a mio beneficio. – E veloce anche.
Il suo compagno, biondo, occhi azzurri, smunto in viso e nel corpo, scoppia a ridere.
– Che bravo sei stato tu che sei finito qua dentro.
Stevan alza le spalle.
– Non dico di essere bravo.
Il maestro gli appoggia una mano sul braccio.
– E tu invece sei bravo, Slavic? Non sei pure tu qua dentro? – chiede.
Il biondo ridacchia ma non risponde.
I due africani sono rimasti zitti tutto il tempo. Uno in particolare sembra concentrato a guardare un punto sulla parete; è molto grosso e la tuta lo stringe piú che vestirlo. L’altro, piú piccolo, con i capelli rasati, guarda il maestro e sorride. Indica il pc nell’angolo.
– Puoi chiedermelo a voce alta, Sonny. Lei non si offende.
Sonny mi guarda.
– Possiamo sentire la musica?
– Dopo – risponde il maestro e con la testa indica il ragazzone in tuta. – Prima sentiamo cosa ci racconta oggi Kelvin. Senza esagerare, eh, non farci una testa di chiacchiere.
Il ragazzone continua a guardare fisso davanti a sé.
– E quando mai ha parlato questo? – dice l’agente stiracchiandosi sulla sedia. – Due settimane che è qua, due settimane che è muto.
Quando D. entra nella stanza scortato dalla solita guardia, lo fa col passo indolente del padrone di casa appena svegliato da ospiti indesiderati. Stringe la mano a tutti e mi dedica appena un’occhiata prima di sedersi sulla sedia che gli ha subito liberato Stevan.
– È da un po’ che non ci si vede, D. – dice il maestro.
Lui alza le spalle magre, si tocca l’orecchino e non dice niente.
– Hai visto? Abbiamo compagnia oggi.
D. afferra uno dei libri che ho disposto sul tavolo, se lo rigira tra le mani. Ha dita lunghe e sottili, estremità adatte a un corpo magro, essenziale. Nei mesi che seguiranno parleremo della sua Genova, del porto e dei caruggi, cosí stretti e intricati, e allora mi sembrerà che braccia e gambe di D. l’abbiano preceduto a disegnarmi i contorni di una geografia privata, e mi chiederò se accade per tutti, se per chi ci incontra siamo degli oggetti di studio ambulanti da cui ricavare fin dalle prime occhiate pezzi sparsi della nostra identità. Adesso guardo D. e il suo accento mi sembra una mappa su cui imparare a orientarmi. Il modo in cui muove a scatti la testa e gli occhi corrono verso l’angolo in cui siede la guardia è un capitolo di storia da intuire in...