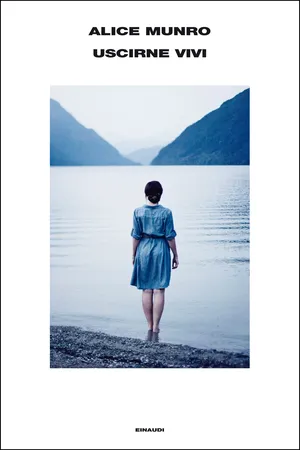Seduta sulla panchina fuori della stazione, aspettavo. Per l’arrivo del treno la stazione era stata aperta, ma adesso era sprangata. C’era un’altra donna seduta sul lato opposto della panchina: teneva tra le ginocchia una borsa a rete piena di pacchi avvolti in carta oleata. Carne, carne cruda. Si sentiva l’odore.
Sul binario sostava il treno elettrico, vuoto, in attesa.
Non si presentò nessun altro passeggero e, dopo un po’, il capostazione cacciò fuori la testa e gridò «San». Lí per lí pensai che chiamasse qualcuno per nome, Sam. In effetti dall’angolo dell’edificio sbucò un tale con indosso una specie di uniforme. Attraversò il binario e salí a bordo della locomotiva. La donna con i pacchi si alzò e lo seguí, quindi feci lo stesso anch’io. Si levò un coro di urla, dal lato opposto della strada, mentre le porte di un edificio dal tetto piatto ricoperto di scandole scure si aprivano liberando un gruppo di uomini che si calzavano i berretti in testa sbatacchiando il portapranzo contro la coscia. Dal baccano che facevano si sarebbe detto che il treno stesse per scappargli via da un minuto all’altro. E invece quando furono sistemati non successe niente. La carrozza era ferma e loro intanto si contavano a vicenda chiedendosi chi mancava e dicendo al conducente che non poteva ancora partire. Poi qualcuno ricordò che era il giorno libero del tale che mancava all’appello. La carrozza si mosse e non era chiaro se il conducente avesse dato retta a quei discorsi, o se ne fosse infischiato.
Gli uomini scesero tutti a una segheria in foresta – a non piú di una decina di minuti a piedi – e poco dopo si cominciò a vedere il lago, coperto di neve. Un lungo edificio di legno bianco di fronte al lago. La donna risistemò i pacchi di carne, si alzò e io la seguii. Il manovratore tornò a gridare «San» e si aprirono le porte. C’erano due donne in attesa di salire. Salutarono quella con la carne e lei disse che faceva proprio un freddo cane.
Tutte evitarono di guardarmi mentre scendevo dietro la donna della carne.
A questa stazione non c’era nessuno da aspettare, evidentemente. Le porte si chiusero sbattendo e il treno ripartí in direzione opposta.
Poi ci fu silenzio, l’aria come ghiaccio. Betulle dall’aspetto friabile, con chiazze nere sulla corteccia bianca, e cespugli diseguali di sempreverdi avvoltolati come orsi sonnolenti. Il lago gelato non piatto, bensí a dossi lungo la riva, come se le onde si fossero ghiacciate in movimento. E l’edificio in fondo, con le sue metodiche teorie di finestre e i porticati a veranda a ciascuna estremità. Un insieme austero e nordico, bianco e nero, sotto la volta di nuvole alte.
La corteccia delle betulle non bianca, però, a mano a mano che ci si avvicinava. Grigio-gialla, grigio-azzurra, grigia.
Un incantesimo sconfinato e fermo.
– Dov’è diretta? – mi chiese la donna della carne. – L’orario di visita finisce alle tre.
– Non sono in visita, – dissi. – Sono l’insegnante.
– Beh, dal portone non la fanno entrare comunque, – disse la donna con una certa soddisfazione. – Sarà meglio che venga con me. Una valigia non ce l’ha?
– Il capostazione ha detto che me la portava lui tra un po’.
– A vederla, lí immobile, aveva l’aria di una che s’è persa.
Dissi che mi ero fermata a guardare perché era bellissimo.
– Per qualcuno, può anche darsi. Sempre che non sia troppo malato o che non abbia da fare.
Nessuna delle due disse piú nulla finché non entrammo nella cucina a un’estremità dell’edificio. Avevo proprio bisogno di un po’ di quel calore. Non ebbi modo di guardarmi intorno perché l’attenzione si concentrò sui miei stivali.
– Meglio che se li levi quelli se non vuole far la scia sul pavimento.
Faticai a sfilarli – non c’era una sedia per farlo da seduta – e li posai sul tappetino dove la donna aveva messo i suoi.
– No, li prenda e se li porti, non so dove vogliono sistemarla. Si tenga anche il cappotto, lo spogliatoio non è riscaldato.
Niente riscaldamento, niente luce, tranne quella che entrava da una finestrella ad altezza non raggiungibile. Era come essere in punizione, a scuola. Fila nello spogliatoio. Proprio cosí. Lo stesso odore di vestiti invernali che non asciugano mai del tutto, di stivali fradici che inzuppano le calze sporche, di piedi non lavati.
Montai su una panca ma non riuscivo comunque a vedere fuori. Sul ripiano ingombro di berretti e sciarpe trovai un sacchetto con dentro qualche dattero e dei fichi secchi. Dovevano averli rubati e nascosti qui per poi portarseli a casa. All’improvviso avevo fame. Niente nello stomaco dal mattino, a parte un tramezzino di formaggio rinsecchito, sull’Ontario Northland. Riflettei sulle implicanze etiche di rubare qualcosa a un ladro. Ma i fichi mi sarebbero rimasti tra i denti, pronti a tradirmi.
Scesi appena in tempo. Qualcuno stava entrando nello spogliatoio. Nessuna delle aiutanti di cucina, bensí un’alunna infagottata in un cappotto e con un foulard in testa. Entrò come un temporale: libri scaraventati sulla panca cosí da farli finire sparpagliati a terra, foulard strappato via, a rivelare un cespuglio scomposto di capelli e contemporaneamente, o cosí almeno sembrò, stivali sfilati uno dopo l’altro con un calcio, e spediti in fondo allo spogliatoio. A quanto pareva, nessuno l’aveva intercettata per farglieli togliere sulla porta di cucina.
– Ehi, non volevo tirarglieli addosso, – disse la ragazza. – È cosí buio qui dentro, arrivando da fuori, che non vedi quel che fai. Ma lei non sta congelando? Aspetta qualcuno alla fine del turno?
– Aspetto il dottor Fox.
– Non ne avrà per molto allora. Arrivo adesso con lui dal centro. Lei non è malata, vero? Se è malata, qui non ci può venire, deve andare da lui in paese.
– Sono l’insegnante.
– Ah sí? Viene da Toronto?
– Sí.
Ci fu una pausa, di rispetto, forse.
Anzi, no. Era di osservazione del mio cappotto.
– Molto carino. Che pelliccia è, quella sul colletto?
– Astrakan. Imitazione, s’intende.
– Io non me ne sarei accorta. Chissà perché l’hanno spedita qui dentro, c’è da gelarsi le chiappe. Mi scusi. Se vuole vedere il dottore, posso accompagnarla. So tutto di questo posto, in pratica ci abito da quando sono nata. Mia madre è capocuoca. Io sono Mary. E lei, come si chiama?
– Vivi. Vivien.
– Se è l’insegnante non dovrebbe essere Miss qualcosa?
– Miss Hyde.
– Come quello del dottor Jekyll, – disse lei. – Scusi. Mi è venuto spontaneo. Mi piacerebbe che fosse lei la mia insegnante ma devo andare a scuola in paese. Colpa delle stupide regole. Perché non ho la tisi.
Mi condusse parlando oltre la porta al fondo dello spogliatoio e poi lungo un corridoio come quello di un qualsiasi ospedale. Linoleum tirato a cera. Verdino alle pareti, odore di disinfettante.
– Ora che c’è lei magari riesco a convincere Reddy a farmi cambiare.
– Chi sarebbe Reddy?
– Reddy Fox. Viene da un libro. Io e Anabel avevamo deciso di chiamarlo cosí.
– E chi è Anabel?
– Non è piú nessuno. È morta.
– Oh, mi dispiace.
– Non è colpa sua. Succede da queste parti. Sono alle superiori da quest’anno. Anabel non è mai andata davvero a scuola. Quando andavo ancora alla pubblica Reddy aveva convinto la maestra a farmi stare a casa spesso, cosí potevo farle compagnia.
Si fermò davanti a una porta socchiusa e fischiò.
– Ehi. Ho portato l’insegnante.
Una voce maschile disse: – Va bene Mary. Per oggi ne ho abbastanza di te.
– Okay. Messaggio ricevuto.
Saltellò via, lasciandomi al cospetto di un uomo magro di statura media, i cui capelli rossicci tagliati cortissimi splendevano sotto la luce artificiale dell’ingresso.
– Ha già conosciuto Mary, – disse. – Bella parlantina, eh? Non sarà in classe con lei, perciò non le toccherà sopportarla tutti i giorni. O ti piace subito, o non ti piace piú.
L’avrei detto di una decina o una quindicina d’anni piú vecchio di me e al principio mi parlava proprio come avrebbe fatto un uomo piú grande. Da serio futuro datore di lavoro. Mi domandò del viaggio, di come avessi preso accordi rispetto alla valigia. Volle sapere se mi sarei adattata a vivere qui nei boschi, dopo Toronto, se non mi sarei annoiata.
Per niente, dissi, e aggiunsi che era bellissimo.
– È come… è come stare dentro un romanzo russo.
Mi guardò attentamente per la prima volta.
– Davvero? E quale romanzo russo?
Aveva occhi di un azzurro chiaro luminoso, tendente al grigio. Un sopracciglio si era sollevato a mo’ di cappellino a punta.
Non è che non avessi letto dei romanzi russi. Ne avevo letti alcuni per intero e alcuni in parte. Ma a causa di quel sopracciglio e della sua espressione divertita, ma anche provocatoria, non riuscii a ricordarmi nessun titolo tranne Guerra e pace. E non volevo dirlo perché era quello che avrebbe ricordato chiunque.
– Guerra e pace.
– Beh, qui direi che abbiamo solo la Pace. D’altronde, se fosse stata la Guerra che voleva, immagino che si sarebbe infilata un’uniforme per poi farsi spedire oltreoceano.
Ero offesa e umiliata perché in realtà non avevo voluto vantarmi. O non solo, comunque. Avevo semplicemente voluto comunicare l’impatto meraviglioso di quel paesaggio su di me.
Era di sicuro una di quelle persone che fanno domande trabocchetto per coglierti in fallo.
– È probabile che mi aspettassi una vecchia signorina maestra sbucata da chissà dove, – disse, quasi a scusarsi un po’. – Come se tutte le persone di età ed esperienza ragionevoli dovessero trovarsi inserite nel sistema, di questi tempi. Lei non ha studiato da maestra, giusto? Che progetti aveva di preciso dopo il diploma?
– Proseguire gli studi, – dissi brusca.
– E come mai ha cambiato idea?
– Ho pensato che dovevo guadagnare qualcosa.
– Mi sembra sensato. Anche se ho paura che non guadagnerà molto qui. Scusi l’indiscrezione. Volevo solo essere sicuro che non decidesse di scappare e di lasciarci nei guai. Non pensa di sposarsi, vero?
– No.
– Bene. Bene. Adesso la lascio in pace. Non l’avrò scoraggiata, spero.
Avevo girato la testa.
– No.
– Al fondo del corridoio trova l’ufficio della direttrice: le dirà tutto quello che le serve sapere. Quanto al vitto, mangerà insieme alle infermiere. La direttrice le dirà del suo alloggio. Cerchi solo di non raffreddarsi. Immagino non abbia nessuna esperienza in fatto di tubercolosi.
– Beh, ho letto…
– Lo so. Lo so. Ha letto La montagna magica –. Secondo trabocchetto; ne sembrò ristorato. – Abbiamo fatto qualche passo avanti da allora, mi auguro. Tenga, qui c’è qualche appunto sui ragazzi e su quello che pensavo lei potrebbe...