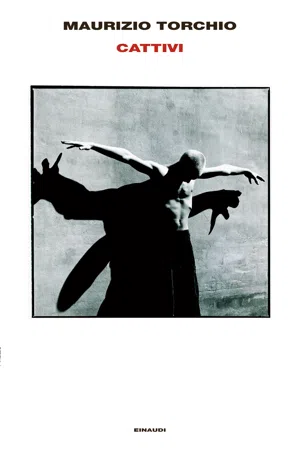![]()
Maurizio Torchio
Cattivi
![]()
![]()
Ti dicono: Orecchie. Tu pieghi le orecchie e ti giri, prima a destra, poi a sinistra.
Narici. Inclini la testa all’indietro, per facilitare l’ispezione.
Bocca. Apri la bocca. Le porte del corpo si schiudono a comando. Apri la bocca ma non ti alimentano. Non aggiungono: controllano che tu non abbia.
Solleva la lingua. Obbedisci.
Tira fuori la lingua. Obbedisci.
Gengive. Scosti le labbra, usando le mani. Le tue dita a disposizione delle guardie.
La bocca è vuota, niente di irregolare. Tornando è facile sia vuota, perché nei permessi conviene parlar molto. Conviene andare con una donna che conosca il carcere: perché ce l’hanno rinchiusa, o la portavano da bambina a trovare un padre, un fratello. Forse il marito è ancora lí. Ci sono ragazze che hanno fretta, e non capiscono. Pensano che se non vedi una donna da vent’anni vorrai ingozzarti per strada. Invece chi conosce il carcere ti porterà a casa, ti alimenterà goccia a goccia. Ci andrete di pomeriggio, sperando faccia buio presto. Ti offrirà un caffè. E parlerai. Parlerai. Devi svuotarti la bocca. Far uscire un po’ di carcere. Se non parli, non c’è spazio per altro.
Toro va da una donna cosí.
Tornato in carcere dicono: Mani, e tu distendi le braccia, spalanchi le dita, come per non cadere. Camminando nel buio. Poi cominci a muovere le dita. Difficile capire perché. Chi può riuscire a nascondere qualcosa fra le dita di un palmo aperto? Ma quando torni da un permesso sei cosí fiero delle tue mani che lo fai quasi volentieri. Sono mani da uomo, finalmente. Ti faccio un caffè?, avrà chiesto la donna. Grazie, avrà risposto Toro. Metti in bocca la tazzina ed è come avere un lavandino tra le labbra, tanto è spessa, pesante. Io non sono mai uscito in permesso, né mai potrò uscirci. Però l’ho provato andando a un processo, otto anni fa. Un cucchiaino vero, d’acciaio, faticoso a girarsi. Il tintinnare, dopo anni di plastica. La tazzina se cade si rompe, hai una responsabilità. È una tazzina per adulti. Quando ti scortano i poliziotti può capitare si fermino all’autogrill e ti offrano un caffè. Le guardie mai. Perché i poliziotti sono abituati ad avere a che fare con gente libera, ancora da catturare. Ai poliziotti insegnano a riconoscere un viso, anche a distanza di anni. Alle guardie no.
Ascelle. Toro alza le braccia.
Solleva e separa. Solleva il pene, separa i testicoli.
Qualche ora prima la donna li ha tenuti fra le mani, carne dopo mura.
Toro piú nudo davanti alle guardie che davanti a lei.
In carcere reimpari la paura del buio. Toro le avrà chiesto di accendere una luce piccola, un abat-jour, e di spostarla sul pavimento, sotto il letto. Mettere strati fra loro e la luce. E in quella penombra si saranno guardati. La donna, conoscendo il carcere, non chiede scusa per quanto è piccola la stanza. Accende la stufa a gas. Quasi tutti gli oggetti, intorno a loro, esistevano già vent’anni fa. Forse non in quella stanza. Forse non esattamente di quei colori. Forse piú grandi, meno poveri, piú nuovi. Ma niente, intorno, mette a disagio. Da quando la donna ha spento il cellulare, e l’ha posato sul tavolino, niente sembra arrivato dal futuro. Niente costringe a contare gli anni. La luce gialla da sotto il letto, la luce blu della stufa a gas.
Ai piani guardano le donne in televisione, le incontrano ai colloqui. Non io.
Va bene, girati, dicono le guardie.
Piedi, ordinano. Prima un piede, poi l’altro, come un cavallo. Piedi subito sporchi di carcere.
Chinati e apri.
Toro si accovaccia e dilata le cosce.
Tossisci.
Quando non tossisci per il freddo, tossisci a comando. Lo fanno per umiliarti. Per controllare davvero dovrebbero usare uno scanner, o mettere il guanto, infilare il dito. Invece ti fanno chinare e tossire, guardano le contrazioni. Un ordine è piú intenso, se non serve.
Toro per fortuna è ancora circonfuso dalla donna.
Ogni volta, quando si separano, lei lo benedice. Come un figlio che parte per la guerra. Un figlio di sessant’anni.
E ogni volta gli chiede: Perché non scappi? Hai l’ergastolo, perché ritorni?
Ma Toro sa che lo prenderebbero subito. Nel suo quartiere, al suo bar, al tavolino in fondo, quello vicino al muro.
Gli unici che riescono davvero a evadere sono quelli capaci di vivere dappertutto: non telefonare, non scrivere. Non contattare nessuno, mai. Morire da un posto e rinascere in un altro, senza rimpianti. Spostarsi come spostano i soldi: in un lampo, senza nemmeno vederli. Ma Toro è uno che ha sempre maneggiato contanti. Ha le mani grandi come badili. Il corpo di chi lavora, da generazioni, anche se non ha lavorato mai. Le uniche cose pesanti sono stati i soldi, mucchi di soldi. E il continuo problema di trovare sacchi, valigie, cantine, bagagliai, posti capaci di contenere tutti quei soldi. Fare attenzione all’acqua, il fuoco, gli animali, le muffe. Il vento e la pioggia. E il dubbio di averne dimenticati un po’, da qualche parte. E non riuscire a ricordare dove.
Toro non sa sparire.
Per quelli come lui l’unica latitanza è nascosti in un bunker, sottoterra, vicino a casa. Vicino a un figlio, sepolto poco lontano.
Meglio il carcere: si vede piú sole, si incontrano piú persone.
Per questo Toro ha lasciato la donna e si è incamminato, scansando le macchine e i passanti.
Fuori c’è sempre qualcuno che ti viene addosso, e le macchine diventano ogni anno piú silenziose. Dentro, anche nella piú grande delle prigioni, se sai chi sei, sai come muoverti. Uno come Toro può camminare a occhi chiusi, qui, perché tutti gli cederanno il passo. Una prigione senza un passeggio ordinato è una prigione dove nessuno vuol stare. Qui, quando scendono all’aria il primo o il terzo piano, che sono organizzati, il cortile è ordinato. Quando tocca al secondo, o al piano terra, è un disastro, perché sono tutti tossici, o gente che non appartiene.
Ma fuori non c’è niente di organizzato: ti devi scansare in continuazione. Senti la fretta di chi ti sta intorno. Hai la sensazione che siano tutti in coda, dietro di te, e si stiano chiedendo: Chi è, quell’uomo rallentato? E a volte è vero. Hai la sensazione che abbiano capito da dove vieni. Ma questo non è mai vero, perché quelli di fuori al dentro non ci pensano mai.
![]()
Ieri Toro è arrivato alla stazione con quasi un’ora di anticipo. Nonostante sia al quarto permesso ancora non sa regolarsi, ha paura di far tardi, paura di perdersi. Non conosce la città, ma gli sta bene cosí. È bello girare dove non hai mai avuto una moglie, né un figlio, e non ricordi quali negozi ci fossero prima di adesso. Camminare dove non ti ha mai cercato nessuno. Dove non si hanno nemici né amici, e non sai chi rifornisce i bar di slot-machine. Non sai qual è il pezzo di marciapiede dove i padri raccolgono i figli da terra, e urlano, e tutti i negozi abbassano le saracinesche, da dietro le finestre bisbigliano, e i padri col corpo del figlio in braccio s’incamminano senza sapere dove andare. E tutto intorno i campi.
Toro è cresciuto in un paese di case a un piano, massimo due, lasciate a metà, senza intonaco, perché la terra vale poco e chi ha qualcosa di prezioso lo tiene nascosto.
Adesso è felice di camminare in questa città senza lotti vuoti, con i vicoli stretti e le case ristrutturate mille volte, le macchine parcheggiate sottoterra, o dentro i palazzi.
Alla stazione rimane in piedi, ad aspettare.
Siamo bravi ad aspettare.
Poi sale sul treno, rumoroso e sporco, come il carcere. Il riscaldamento è rotto, come in carcere. I controllori in divisa. A noi piacciono i treni. Un orario di partenza, uno di arrivo. Qualcun altro che guida.
Le guardie lo sanno.
Gli evasi li cercano nelle stazioni. Li raccolgono a grappoli, orgogliosi di essersi comprati il biglietto.
Ma Toro non è evaso, e dopo un’ora e mezza è sceso alla fermata giusta, nel tratto di costa che ha solo tre luci: la stazione, in basso, vicino al mare; il carcere, quattrocento metri sopra; e un paese in cresta. Intorno alla stazione ci sono scogli, la cava di pietra, e nient’altro.
Toro cammina fra la stazione e il carcere, su una terra che gli è nuova quanto la città. Non ci sono bus per il paese, solo per il carcere, e solo in orario di visita. C’è piú gente nel carcere che in paese. Quelli del paese usano l’autostrada che corre all’interno. Se devono scendere al mare, vanno altrove.
Questo era un riformatorio, in origine.
Il paese lo costruirono i minorenni, cent’anni fa, insieme al carcere e alla strada.
Paese per guardie, piú alto della prigione, perché sembrava giusto cosí. Nessuna guardia ci abita ormai, né siede al bar; e se i familiari dei rinchiusi si fermano a comprare qualcosa, i negozianti li trattano male. Ma sulle pietre angolari, nascosto sotto i cartelli delle vie, c’è ancora inciso l’anno di costruzione, e il nome del primo direttore del riformatorio.
Hanno persino raccolto firme, in paese. Dicono che una volta, da questo tratto di costa cosí buio, si vedevano infinite stelle. Invece adesso il carcere colora il cielo di arancione per chilometri, ogni notte, tutta la notte. Succhia l’energia dalla terra e la proietta altrove. La terra resta vuota. Dal largo, per le navi, dall’alto, per gli aerei, il paese e la stazione svaniscono. Invece di cento case, solo il carcere. E chi si affaccia alla finestra, nelle sere nuvolose, vede un latte arancione che toglie la voglia di qualsiasi cosa.
Ma il carcere c’era da prima. Prima il buio, poi il carcere, poi il paese.
Toro suona: Sono Toro, rientro dal permesso.
Va bene, aspetta.
In una grande prigione forse Toro non sarebbe nessuno. Qui invece, almeno fino a cinque anni fa, parlando di Toro e di Comandante si parlava di tutto il carcere. Il resto era polvere: tossici, disorganizzati, cani sciolti. Poi sono arrivati gli Enne. Ma Toro resta Toro. Eppure neanche a lui basta suonare. Un detenuto normale aspetterà un’ora, Toro cinque minuti. Ma deve comunque aspettare. Le otto di sera, il mondo fuori comincia a cenare. Per il carcere è già notte fonda. Nel parcheggio solo le auto degli agenti; inutili, perché non hanno dove andare. Resteranno chiusi anche loro, a dormire in caserma o a lavorare.
Dopo lo scatto della porta esterna, Toro attraversa l’intercinta. Intorno al vecchio riformatorio di pietra e mattoni hanno costruito un muro di cemento, piú alto del tetto. E nella terra di nessuno che sta fra il carcere e il muro hanno piantato dei pali, ancora piú alti, con dei fari rotondi in cima, come soffioni, o meduse infilzate, quattrocento metri sopra il mare.
Toro cammina protetto da una grata. Fra il fuori dove vive il mondo, e il dentro dove viviamo noi, vivono i cani. Qui una volta cadeva chi si calava dal carcere. Perché qui si è continuato a fare come cento anni fa, a scavare muri e annodare lenzuola. E come cento anni fa, si è sempre sbagliato qualcosa, all’ultimo momento. L’intercinta è un cimitero di gambe. Sopra quel cimitero corrono i cani.
Toro prosegue, di cancello in cancello, fino alla stanza dove si spoglia, accovaccia, e ce la mette tutta per tossire.
Basta cosí, alzati, dice la guardia.
Ma lui continua a tossire. Toro ha inerzia, come una petroliera. Come il carcere.
La guardia fruga nei vestiti e poi glieli passa, uno per uno.
Rivestiti.
La guardia controlla le scarpe, l’attacco fra suola e tomaia. Le scarpe nuove che fanno sanguinare i piedi. Svuota la borsa sul tavolo: lattine, libri, snack, riviste, accendini, carta da lettera. La carta si può ordinare anche al sopravvitto, ma nessuno la vuole, perché è bianca. C’è l’idea che scrivere nero su bianco ricordi le sbarre. Toro per il ragazzo che vive con lui ha comprato carta azzurra con delfini disegnati. O qualcosa del genere. Io non l’ho vista. Ma in carcere non c’è bisogno di vedere tutto, perché molte cose si ripetono. Se non sono delfini sarà un koala. Scriverebbero sul velluto, potessero. Vogliono cose soffici. Lustrini d’argento per la spuma delle onde. Patatine. Bibite dolci e gasate.
![]()
I vestiti li lavo da me. Non vengono cosí puliti in lavanderia. E sei costretto a pagare, se non vuoi che li perdano. Però mi si son storte le dita, a forza di impastare in questa coppa di alluminio. Hanno preso la forma del lavandino. Come i piedi fasciati delle cinesi, come si chiamano? Mi viene bonsai, ma non è giusto. O forse sí, il principio è quello: costringi qualcosa a restar piccolo. Da cinque anni non salgo nemmeno all’aria. La cella è lunga quattro passi e larga un paio di braccia distese. Se mi alzo in punta di piedi tocco il soffitto. È uno spazio a misura d’uomo. A misura mia.
L’isolamento è la prigione della prigione. Perché ogni posto deve avere una prigione. Se sei già all’ospedale e ti senti male, cosa fanno? Ti mettono in terapia intensiva, che è l’ospedale dell’ospedale. Se sei in prigione e vogliono punirti è uguale: deve esserci qualcosa. Dev’esserci sempre qualcosa da togliere, altrimenti tutto si ferma. A volte ti danno delle cose perché ti venga paura di perderle. Dove stavo prima distribuirono delle televisioni solo per minacciare di spegnerle. Per farti provare la sensazione di cadere ti sollevano, ogni tanto. Altrimenti dopo un po’ arrivi al centro della terra, e da lí non vai piú da nessuna parte.
Io però sto bene dove sto. E non m’importa se ai piani possono fare la spesa, scendere in cortile, invitarsi a cena, guardare la tv… Io non sono abituato al rumore. C’è gente che a casa aveva piú rumore che in carcere. A loro sembra tutto normale. Fuori dormivano, mangiavano gli uni sugli altri, qui fanno lo stesso. Dormono per terra. Nella vecchia sala giochi hanno steso dei materassi, e dormono lí, perché non c’è piú posto.
Io anche nel furgone stavo in silenzio. Mi piaceva. Un posto tranquillo, dove pensare ai fatti tuoi, vedere il mondo che scorre.
Qui sotto, nella prigione della prigione, non ci sono ubriachi e non si gioca a carte. Non urlano, la notte, da quando non c’è piú Piscio. Lui era capace di gridare anche dieci ore di fila, senza mai perdere la voce. Ora c’è quasi silenzio. Poi è vero che anche ai piani, anche al camerone piú schifoso troverai sempre chi ti dice: Sei fortunato, questa è la cella migliore del carcere. Perché gira bene l’aria. Oppure perché non fa troppo freddo d’inverno. Perché è lontana dal bancone degli agenti, o perché hanno ristrutturato i bagni due anni fa. Il carrello del vitto passa prima, arriva ancora caldo. Si vede un pezzo di montagna. Oppure: In un attimo sei in cortile. E lo pensano davvero. Cioè si lamentano, perché si lamentano in continuazione, ma sono orgogliosi.
Un po’ è inevitabile. Ti affezioni al posto dove stai. Anche chi si ferma solo tre o quattro anni, passa comunque piú tempo in cella di quanto la maggior parte della gente non ne passi, in casa, lungo la vita intera. Qui, quando scendi all’aria senza asciugamano dici: L’ho dimenticato a casa. E quando ancora giravano soldi la gente pagava, corrompeva, pur di farsi ridipingere la cella tutti gli anni. Compravano le spugne, i secchi, i detersivi migliori. Pavimenti sempre lucidi. Devi toglierti le scarpe, quando vai a trovare qualcuno. E prima di lasciar fare le pulizie a un nuovo arrivato lo mettono alla prova, perché sono convinti che pulire sia una questione delicata, importante, che nessuno sa gestire meglio di loro. Loro che sono qui da sempre. La not...